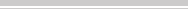paolo bonetti
Nessun commentoDopo la guerra e il crollo della dittatura, il partito liberale risorge per opera soprattutto del grande prestigio culturale e morale di Croce, ma è un partito prevalentemente meridionale, con scarso radicamento nelle aree più avanzate del paese e guardato con diffidenza da molti intellettuali di ascendenza crociana (si pensi soltanto a figure di primo piano come Adolfo Omodeo e Guido De Ruggiero) che gli preferiscono il nuovo Partito d’Azione, più aperto al rinnovamento del vecchio apparato burocratico statale e alle esigenze di una giustizia sociale intesa peraltro in termini non classisti. Ma anche il Partito d’Azione sarà ben presto travagliato dalla contrapposizione fra l’ala liberaldemocratica e quella socialista fino alla rapida dissoluzione nel congresso di Roma del 1946. Il PLI, a sua volta, dopo l’abbandono da parte di Croce della presidenza effettiva del partito, sbanda paurosamente verso destra fino ad allearsi con l’Uomo Qualunque di Giannini, subisce ripetute scissioni a sinistra, finché non si giunge, nel congresso di Torino del 1951, alla ricomposizione provvisoria del partito. Durerà poco. La sua possibile base elettorale è ormai emigrata in gran parte verso la Democrazia cristiana, mentre, al suo interno, il gruppo raccolto attorno alla rivista “Il Mondo”, fondata e diretta da Mario Pannunzio, sempre più lavora, seppure con scarso successo, per la creazione di una “terza forza” laica in grado di bilanciare la straripante egemonia democristiana e il clericalismo che le fa da supporto. Nel perseguimento di questa linea politica, gli uomini del “Mondo” trovano una valida spalla nel liberalismo pragmatico e interventista di Ugo La Malfa che, dopo la scissione azionista, è confluito nell’antico Partito repubblicano e ne è diventato il leader.
Quando Malagodi, nel 1954, conquista la segreteria del partito, comincia per il Pli forse l’unico periodo della sua storia in cui c’è stato un serio tentativo di radicamento organizzativo in quelle zone e in quei ceti sociali dove, sotto la spinta di una tumultuosa crescita economica, si veniva formando una nuova borghesia imprenditoriale che si sperava potesse essere immune dai vizi corporativi dell’elettorato democristiano. Fra la linea politica di Malagodi, che scommetteva sulla crescita di questa borghesia, e quella degli uomini del “Mondo” che ritenevano altamente improbabile una reale conversione al liberalismo dei nuovi “padroni del vapore”, scoppiò un dissidio insanabile che portò a una nuova scissione e alla formazione del Partito radicale. Da una parte, dunque, il liberalismo/liberismo di Malagodi che aspirava a strappare voti a una Dc sempre più avviata verso l’alleanza con i socialisti, dall’altra il liberalismo rooseveltiano degli uomini del “Mondo”, che, pur fedelissimi all’economia di mercato e ai valori etico-politici dell’Occidente, pensavano che fosse ormai necessaria, assieme ad altre riforme (scolastica, universitaria, urbanistica, giudiziaria), una programmazione economica capace di razionalizzare la grande trasformazione industrial-capitalistica di un paese fino a quel momento arretrato. Fallirono entrambi i liberalismi: quello malagodiano, che raggiunse la massima espansione nelle elezioni del 1963, non seppe venir fuori da una condizione di sostanziale emarginazione politica e non scalfì, se non in misura assai limitata, il consenso democristiano presso i nuovi ceti borghesi; il liberalismo del “Mondo”, a sua volta, che pure aveva elaborato, con i suoi convegni, un programma organico di riforma della società e dello Stato, naufragò nell’esperienza di centro- sinistra, che si risolse nella nascita di nuove corporazioni e di nuove clientele, questa volta con targa socialista, pronte a colludere con quella tradizionali della Dc.
Perfino la secolarizzazione della società italiana negli anni ’70, con l’introduzione del divorzio e dell’aborto legalizzato, non si tradusse in una crescita delle forze politiche laiche, liberali, radicali o repubblicane che fossero. Gli italiani “secolarizzati” preferivano votare per il partito comunista di Berlinguer con le sue fumisterie ideologiche e il suo “compromesso storico”. Quello che è venuto dopo è troppo noto per farne ancora una volta la storia. Ma sarebbe un grave errore se gli uomini di cultura liberale (una cultura, non dimentichiamolo, che ha sconfitto nel Novecento tutte le ideologie che le si sono contrapposte) imprecassero, come un noto uomo politico, al destino cinico e baro: i partiti non si creano a tavolino per opera di alcuni intellettuali ben intenzionati, i partiti, anche quelli liberali, hanno necessità di crescere in un humus popolare fecondo di interessi, bisogni, convincimenti radicati a livello di massa. Anche gli evanescenti partiti italiani di questi ultimi anni resisteranno alla inevitabile scomparsa dei loro fondatori, solo se avranno compiuto almeno parzialmente questo faticoso processo di radicamento. La televisione può contribuire grandemente all’esplosione iniziale di un partito, ma a lungo andare, di fronte alle complicazioni della vita sociale, non basta a garantirne la sopravvivenza. Bisogna lavorare sul territorio, mettendoci entusiasmo e spirito di sacrificio. Fatta questa premessa, la diagnosi sulle condizioni attuali del liberalismo italiano non è incoraggiante e la prognosi sul suo avvenire decisamente infausta. A meno che... e qui, prima di proseguire, occorre fare un’ulteriore riflessione storica.
Il liberalismo italiano, come decisiva forza di governo, è morto con l’avvento del fascismo, e quando è rinato, nonostante qualche fiammata di vitalità, ha condotto la vita di un anziano dalla salute precaria e sempre a rischio di estinzione. Il 1922 per il nostro liberalismo è stato come l’8 settembre del ’43 per la nazione italiana: un colpo irreparabile alla sua identità e al suo orgoglio, un divorzio mai più sanato con il paese profondo, quello di ceti popolari e borghesi che il vecchio liberalismo non seppe né capire né interpretare. Da allora esso è vissuto soprattutto per la presenza di gruppi eretici che cercavano di mantenere il contatto con la cultura del più avanzato liberalismo europeo e americano e per il carisma di alcune grandi personalità che erano, tuttavia, avulse dal costume e dalle idee di quei ceti che trovarono nella Democrazia cristiana un partito assai più in sintonia con il loro bisogno di rassicurazione sociale e di identità antropologico-culturale. Saltati gli equilibri politici della prima Repubblica per un tasso di corruzione ormai insostenibile e per un corporativismo clientelare che ha moltiplicato follemente la spesa pubblica, l’annuncio da parte di Berlusconi di una “rivoluzione liberale” e della formazione di un partito liberale di massa, è stata l’ultima illusione, ben presto svanita per il carattere demagogico-populista del personaggio, di una possibile nascita anche in Italia di un partito liberale che non fosse confinato nella stretta cerchia di gruppi intellettuali di stampo europeo e di uomini politici illuminati ma con scarso seguito elettorale.
Ci sarà mai, anche da noi, una forza politica di ispirazione liberale che raccolga un consenso tale da essere determinante nelle concrete scelte di governo? No, non credo che ci sarà, a meno che… a meno che la storia d’Europa, dopo anni di stallo, non si avvii decisamente verso quella compiuta unificazione politica, e non soltanto finanziaria, che permetterebbe anche ai minoritari liberali italiani, di navigare nella grande corrente del liberalismo europeo che esercita tuttora, nonostante la prevalenza numerica di popolari e socialdemocratici, una funzione di stimolo verso le tante pigrizie e paure che frenano le politiche del vecchio continente. Ma l’adesione a un partito liberale europeo, che è una prospettiva di lungo termine a cui dobbiamo comunque lavorare, non deve interrompere quel lavoro di dissodamento liberale della politica che, in Italia, può essere oggi fatto in due modi, entrambi legittimi e utili: tenere in vita e potenziare associazioni, fondazioni e riviste che, come Critica liberale, non si arrendono al conformismo e alla viltà dei cosiddetti liberaloidi; portare in altri partiti, di diversa matrice ideologica, il contributo delle nostre idee, resistendo pazientemente alle incomprensioni che certamente non possono mancare e che finiscono con l’indurre ad atteggiamenti di amaro e sconsolato pessimismo. In un partito si deve saper stare anche in condizioni di estrema minoranza, purché questo partito non sia tale da escludere per un liberale che vi milita ogni possibilità di azione. Nella nascita o rinascita di un partito liberale o liberalsocialista esclusivamente italiano sinceramente non credo, anche se apprezzo la passione e lo spirito di sacrificio che taluni mettono in questa impresa quasi disperata. Se uno non se la sente di militare in partiti che di liberale hanno assai poco, l’unica strada utilmente percorribile è quella dell’impegno culturale, tenace e senza compromessi. Ma, intanto, bisogna lavorare per l’Europa e per un liberalismo europeo che inglobi e dia vigore a quello italiano, troppo gracile e disperso in piccoli gruppi. Liberalismo europeo vuol dire che tutte le libertà sono solidali compresa quella economica, che il grande tema dei diritti civili non è oggi privilegio delle élites, ma interesse concreto di tutti i cittadini, che la laicità non è guerra contro le religioni ma difesa per tutti di una sfera intangibile di autonomia, che la lotta contro la corruzione non è semplice sdegno moralistico, ma lo strumento indispensabile per garantire un uso razionale delle risorse di cui la società dispone.
{ Pubblicato il: 07.10.2011 }
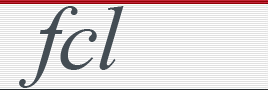




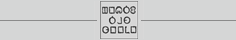




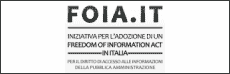






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.