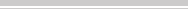pierfranco pellizzetti
Nessun commentoCi sono volute sei ore di scontri durissimi davanti alla Prefettura di Genova - dalle 11 di mattina alle 17 - perché il Ministro dello Sviluppo economico (denominazione che di questi tempi assume un significato platealmente derisorio) Paolo Romani trovasse il tempo e la voglia di spedire un fax di convocazione delle parti a Roma, il 3 giugno prossimo. Intanto quattro manifestanti e dieci agenti erano finiti al pronto soccorso con i volti insanguinati e le teste spaccate.
Tutto era cominciato la mattina del 24 maggio, quando si diffondeva la notizia che Fincantieri aveva presentato un piano che prevede 2.551 esuberi nelle sedi di Castellamare di Stabia e Sestri Ponente. La ragione per cui 770 lavoratori genovesi si erano subito messi in marcia: manifestare davanti al locale Palazzo del Governo un sentimento che è rabbia ma anche disperazione.
Il blocco attuato dalle forze dell’ordine aveva dato fuoco alle polveri. Con le conseguenze di cui si diceva.
Ma si diceva anche di rabbia e disperazione. Perché i manifestanti sono intimamente consapevoli dell’essere i soggetti più vulnerabile tra quelli in campo. Quelli che pagheranno – e duramente - gli errori e le omissioni altrui. In una crisi della cantieristica annunciata da anni, ma nei cui confronti chi poteva e doveva prendere provvedimenti non mai ha mosso neppure un dito.
Certo, questo management presidiatore delle proprie poltrone, incapace di giocare in anticipo almeno per una volta nella vita, che quando l’azienda sbatte contro il muro delle dure repliche del mercato l’unica ricetta in grado di escogitare è quella della decimazione dei propri dipendenti. Poi arriverà qualche bocconiano con la boccuccia a cuore, pronto a pontificare sulla globalizzazione. Come se la Germania non si trovasse anch’essa immersa in un mondo globale. Ma lì, manager che sono tali, non politicanti e rentriers travestiti da aziendalisti, hanno saputo fare il mestiere per cui sono (stra)pagati: innovare prodotti e processi, riposizionare le proprie imprese in settori che consentano di competere senza dover svendere il lavoro. Anzi, valorizzando le alte abilità e competenze professionali diffuse nel tessuto produttivo da almeno un secolo di tradizione industriale interiorizzata, senza buttare a mare vocazioni storiche e conquiste democratiche.
A fronte di tutto questo, sindacalisti uomini e donne non hanno perso tempo a flirtare nei convegni con qualche Emmamarcegaglia di turno, ma si sono dati il compito prioritario di tutelare i propri rappresentati attraverso mediazioni “alte” (oppure – per non essere sbertucciati da un Nanni Moretti come ingraiani - chiamiamole non dissipatorie né sconfittiste) con le caratteristiche strutturali dei nuovi contesti.
Ma il vero motore della risposta tedesca alla crisi è rappresentato dall’attitudine strategica del comando politico. Ossia l’applicazione intelligente e determinata di quel patrimonio concettuale che - almeno dai tempi di John Maynard Keynes - chiamiamo “politica industriale”. Dunque, la priorità di governare tanto tenuta come crescita del sistema produttivo d’impresa attraverso le scelte di indirizzo e la conseguente allocazione delle risorse.
Ora, distraendoci solo un istante dalla rabbiosa disperazione di chi perdendo il posto di lavoro (come gli addetti alla cantieristica di Sestri e Castellamare) viene privato di ruolo e status, potremmo domandarci: quel governo che impiega sei ore per spedire un fax e porre temporaneamente fine allo scontro sociale distruttivo, ha una pur vaga idea di quali potrebbero essere gli assetti alla portata dell’Italia per riprendere il cammino dell’accumulazione di ricchezza collettiva? A che cosa potremmo dedicarci che sia – al tempo stesso – appetibile sui mercati mondiali e coerente con quello che sappiamo fare? Dove e come orientare il sistema formativo nazionale affinché le ragazze e i ragazzi raggiungano livelli di capacitazione – come si dice nel gergo alla Amartya Sen (nei convegni è sempre un successone!) - che li mettano in condizione di realizzare ragionevoli progetti di vita?
La risposta – ad oggi – è solo il silenzio.
Ma un Paese che non sa pensare futuro è un Paese che non ha più futuro.
Esprimiamo – dunque - la nostra solidarietà ai lavoratori di Finmeccanica, rei di colpe che vanno imputate ad altri. Ma rendiamoci conto che stiamo assistendo all’ennesima battaglia di retroguardia; che gli unici ad accorgersi davvero del loro dramma sono i pedoni e gli automobilisti costretti a deviare a causa dei blocchi stradali. E non è detto solidarizzino con i lavoratori che gli creano disagi.
Non vale proprio la pena di rievocare – come pure abbiamo fatto – le giornate gloriose in cui i lavoratori in lotta facevano cadere governi reazionari. Perché, nel frattempo, i luoghi di lavoro non sono più la sede del “conflitto centrale” (per dirla alla Alain Touraine), non sono più l’articolazione primaria del sistema sociale. E lo sciopero offre solo alibi e vantaggi a chi ne dovrebbe essere il bersaglio: le aziende che hanno perso commesse, a cui si fa risparmiare sui salari e sugli stipendi; i governi che potranno giustificare strette Legge & Ordine, risparmiando – così - sulla comunicazione terroristica.
Risparmiamoci – però – la retorica dell’ineluttabilità, visto che altrove tutto questo ineluttabile non è. È solo l’ennesima riprova della totale inettitudine che da troppo tempo caratterizza la classe dirigente italiana nel suo complesso.
{ Pubblicato il: 26.05.2011 }
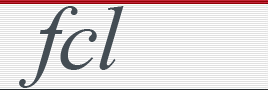




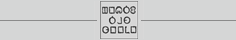




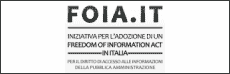






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.