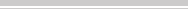vito francesco gironda
1 commentoNegli ultimi giorni vi è un gran parlare attorno al tema di una grande coalizione tra il Partito Democratico e il PDL, la quale è vista come soluzione politica per superare la crisi della rappresentanza parlamentare in cui versa il paese. Un governo di scopo a tempo determinato, il quale dovrebbe avviare una serie di riforme di struttura per traghettare il paese fuori dall’emergenza economica, dal pantano istituzionale e sociale. In questa specie di operazione di „Tutti per l’Italia“ non mancano i modelli di riferimento. Molti guardano all’esperienza tedesca tra il 2005 ed il 2009 e vedono in essa una via di successo da seguire perché essa sarebbe stata in grado di dare una stabilità governativa, avviare una serie di riforme strutturali, le quali, secondo molti politici e opioninisti italiani, avrebbero consentito un migliore impatto alla governance della crisi economica.
Va bene che uno dei tanti vizi della politica nostrana è il vouyerismo estero, la tendenza a guardare cosa succede negli altri paesi, ma è possibile istituire una comparazione tra l’Italia e la Germania? Siamo sicuri che l’idea di una grande coalizione, di un governo politico di grandi intese abbia prodotto in Germania gli effetti tanto decantati dalla stampa e dalla politica? Proviamo a riflettere, non prima di sottolineare due aspetti fondamentali.
In primo luogo, bisognerebbe ricordare che la nostra storia repubblicana ha conosciuto forme di governi, dal carattere più o meno tecnico, sostenuti dai maggiori partiti del Parlamento. Una sorta di „grandi coalizioni“ sui generis sono stati tanto il governo Ciampi del 1993 quanto l’ultimo di Monti; senza voler andare a scomodare i governi di solidarietà nazionale di andreottiana memoria, tra il 1976 ed il 1979, e, nonostante le differenze del caso, se mi si lascia passare l’osservazione, perché non considerare sotto quest’ottica anche il cosiddetto triennio consociativo (1968-1971) come prassi di gestione delle isituzioni pubbliche. Poi, quali siano stati i risultati raggiunti da queste forme governative dovremmo tenerlo sempre presente.
In secondo luogo, bisognerebbe partire dalla premessa che esiste una grande differenza tra l’Italia e la Germania sia in relazione ai meccanismi di funzionamento del sistema politico, il cui processo decisionale è equibrato tra il Bundestag (Parlamento) ed il Bundesrat (organo di rappresentanza dei Länder) e sia, più in generale, in termini di cultura politica ed istituzionale. Si tratta di fattori che giocano, o meglio, hanno giocato un ruolo fondamentale per la tenuta della grande coalizione del primo decennio del XXI secolo e per l’implementazione delle politiche pubbliche.
Certo, si può anche provare a comparare le mele con le pere, ma alla fine avremo come risultato una macedonia il cui sapore ed il cui odore è tutto da decifrare.
Ora, proviamo a vedere concretamente i presupposti, gli effetti ed i risultati delle grandi coalizioni tedesche. Uso volutamente il plurale perché in Germania, nel secondo dopoguerra, abbiamo avuto due grandi coalizioni ed una comparazione tra le due può aiutare a capire meglio l’ultima del governo Merkel e Steinmeir, la quale sta suscitando tanto plauso ed aspettative in queste turbolente settimane postelettorali.
La prima grande coalizione della Germania Federale (1966-1969) tra CDU e SPD, tra Kurt Georg Kiesinger e Willy Brandt, partorì in un contesto storico caratterizzato da una crescente recessione economica e si pose come obiettivo una serie di riforme strutturali di grande respiro: riduzione del debito pubblico, riforma delle legge elettorale, ridefizione delle strutture federali ect. Rispetto all’operato riformistico, la storiografia e, in generale, la politologia ha espresso un giudizio molto positivo.
Di diversa valutazione è il giudizio scientifico sulla seconda grande coalizione tra il 2005 e il 2009. Dal confronto tra le aspettative di partenza ed i risultati ottenuti emerge una chiara dissonanza. Nel 2005 il programma di coalizione si era basato su quattro questioni nevralgiche: risanamento delle finanze pubbliche, politiche di crescita economica, diminuizione della disoccupazione, riforma costituzionale del federalismo.
Per quanto concerne la riforma dello Stato federale da una parte sono state apportate delle nuove discipline in materia di approvazione delle leggi federali da parte del Bundesrat, dall’altra parte sono state modificate le responsabilità dei Länder negli affari comunali. Mentre, attorno alla questione centrale del federalismo fiscale non si è fatto molto, solo alcune correzioni, diciamo cosi, di natura leggera e non di riformismo strutturale.
Il debito pubblico è aumentato, passando da 1489,9 miliardi di Euro del 2005 a 1689, 4 miliardi di Euro nel 2009, un incremento che se poi tradotto per ogni singolo abitante è passato da 18066 Euro a 19213 Euro (Fonte: Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), settembre 2011)
È vero che il numero dei disoccupati durante la legislazione della grande coalizione è sceso da 4,9 milioni(10% della popolazione) a 3,4 milioni nel 2009 (7,1%). Paradossalmente, poi, il successivo impatto della crisi finanziaria mondiale non ha scalfito questo trend, tanto che la curva della disoccupazione è diminuita ancora nell’ultimo triennio, assestandosi attorno ai tre milioni di disoccupari (6%). Però, bisogna stare attenti a valutare questi dati come frutto delle politiche economiche della grande coalizione, piuttosto questi risultati dovrebbero essere letti alla luce degli effetti di lungo periodo scaturiti dall’Agenda 2010 del cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder, che per via della diminuzione della spesa sociale, della rimodulazione del welfare, per la flessibilità introdotta nel mercato del lavoro, nonchè per la politica degli sgravi fiscali si è rilevata, alla fine, un adeguato strumento per manterene competitiva l’economia tedesca. Il governo della grande coalizione in materia occupazionale e del mercato del lavoro non ha fatto quasi nulla, ha solo raccolto il frutto riformista del governo precedente.
Questi esempi dimostrano che i risultati raggiunti dalla grande coalizione in Germania sono stati molto meno significativi di quanto si discuta in Italia. L’idea di guardare all’esperienza tedesca, di enfatizzarne il carattere di successo e dire che le grandi coalizioni rappresenterebbero l’unica via praticabile per apportare le necessarie riforme strutturali è vero solo in parte. È vero che per il tipo di maggioranza che esprimono, per i numeri a disposizione è più facile pensare a fare le riforme, ma per sopravviere come forma di governo le grandi coalizioni necessitano di avere una specifica cultura politica ed istituzionale. Le grandi coalizioni possono funzionare nei paesi nei quali la cultura istituzionale e il comportamento delle élites politiche è di natura consensuale, ossia in paesei in cui l’idea di consociational democracy (Arend Lijphart) non sia un corpo estraneo alla prassi di governo e la tradizione parlamentare. In Italia, viceversa, come giustamente ricordava tempo fa Michele Ciliberto, un elemento importante della crisi della democrazia nostrana è la decadenza della mediazione da interdersi come una prassi culturale del riconoscimento tra soggetti politici alternativi.
{ Pubblicato il: 27.03.2013 }
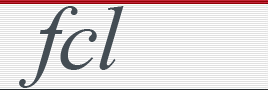


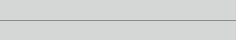

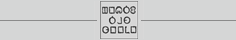




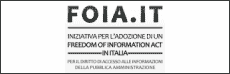



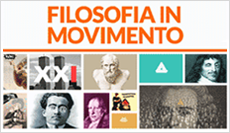


 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.