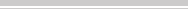livio ghersi
Nessun commentoLasciamo parlare le cifre.
— 25.935.372 cittadini italiani hanno votato SI alla proposta di abrogazione di disposizioni concernenti l'affidamento e gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Sullo stesso quesito, i NO espressi sono stati 1.265.495.
— 26.130.637 cittadini italiani hanno votato SI alla proposta di abrogazione di disposizioni concernenti i criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico. Sullo stesso quesito, i NO espressi sono stati 1.146.639.
— 25.643.652 cittadini italiani hanno votato SI alla proposta di abrogazione di nuove disposizioni concernenti la produzione di energia elettrica nucleare. Sullo stesso quesito, i NO espressi sono stati 1.622.090.
— 25.736.273 cittadini italiani hanno votato SI alla proposta di abrogazione di disposizioni in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. Sullo stesso quesito, i NO espressi sono stati 1.462.888.
I dati sono tratti dal sito del Ministero dell'Interno e riguardano la totalità delle sezioni in Italia e la totalità dei voti espressi dai cittadini residenti all'estero.
Il rapporto di venticinque ad uno, tra SI e NO, si spiega con il fatto che i contrari all'impostazione dei quesiti hanno preferito disertare il voto, puntando sul mancato raggiungimento del quorum di validità dei referendum.
Invece, dopo quindici anni consecutivi che non si raggiungeva il quorum per i referendum abrogativi, si è avuto questo dato straordinario, imprevisto ed imprevedibile, di massiccia partecipazione degli elettori. Risultato tanto più straordinario perché le reti televisive del servizio informativo pubblico (RAI) non avevano certo brillato per spiegare all'opinione pubblica la materia del contendere, con spazi e tribune dedicati ai referendum. Fatte sempre le dovute eccezioni (in particolare, segnalo in positivo RAI-News 24).
Si può dare una lettura politica del voto. Si coglie, negli elettori, un diffuso sentimento di malcontento e di protesta nei confronti della politica dell'attuale Governo. Malcontento e protesta che si erano già manifestati in modo clamoroso nella recente tornata di elezioni amministrative; determinando, ad esempio, l'elezione di Giuliano Pisapia a Sindaco di Milano e di Luigi De Magistris a Sindaco di Napoli.
Soltanto sei mesi fa nessun analista o commentatore politico rispettabile avrebbe azzardato una previsione su questo esito del voto nelle elezioni amministrative, prima, e del voto referendario dopo. Il mese che va dal 15 maggio al 13 giugno 2011 sarà forse ricordato dagli storici futuri come fatale per il destino politico di Silvio Berlusconi.
Lascio queste valutazioni, più facili, ai tanti che si cimentano e continueranno a cimentarsi nel commento politico. Mi interessa soffermarmi sul significato del voto ai primi due referendum, quelli riguardanti il bene dell'acqua. I quesiti referendari sono stati elaborati, sotto il profilo tecnico-giuridico, da sei docenti universitari. Tre dell'Università di Roma "La Sapienza": i professori Gaetano Azzariti, Gianni Ferrara e Stefano Rodotà. Uno dell'Università di Torino: il prof. Ugo Mattei. Uno dell'Università di Napoli "Federico II": il prof. Alberto Lucarelli. Uno dell'Università di Palermo: il prof. Luca Nivarra.
Mattei, Rodotà ed Edoardo Reviglio hanno fornito un approfondimento teorico con in libro: "Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica" (Il Mulino, 2007). Intervistato dal quotidiano "La Stampa" ("La scommessa sull'acqua del professore di Torino", edizione del 14 giugno 2011), Mattei ha ricordato alcune scomode verità. Quando lo Stato espropria, è tenuto ad indennizzare i privati espropriati, secondo parametri certi e garantiti. Viceversa, quando un Ente pubblico dismette la gestione diretta di un bene che costituiva un monopolio naturale (come, appunto, l'acqua), non si preoccupa che l'affidamento del servizio sia rimunerativo (eppure, i cittadini stanno perdendo il controllo di un bene di utilità comune). Si ha fretta di scaricare la gestione di quel bene prezioso al primo che si dichiari disposto a farsene carico; non si batte ciglio, quando i privati affidatari richiedono margini di profitto, a fronte dei capitali investiti, e computano fra i costi a proprio carico pure "compensi astronomici" per i manager utilizzati per l'organizzazione del servizio. E' tutto a perdere. E' una vecchia logica, che il buon Ernesto Rossi aveva brillantemente sintetizzato nell'espressione: "privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite" (si veda "Lo Stato industriale", Laterza, 1953, p. 52).
Prima che si votasse per i referendum, ho letto una buona analisi di Paolo Leon: "La deriva privatistica dell'ultimo ventennio ha concentrato l'attenzione sulla gestione dell'acqua potabile, immaginando che la concorrenza, attraverso il mercato, avrebbe ridotto i guasti della gestione pubblica (perdite di rete, morosità, arretratezza tecnologica) mentre la spesa necessaria per mantenere e far crescere le infrastrutture poteva essere addossata alla gestione privata (che, peraltro, l'avrebbe fatta comunque pagare nella tariffa, esattamente come la gestione pubblica). Ora, la gestione pubblica dell'acqua potabile è spesso pessima, perché i governi locali sono pessimi. Ne segue che la liberalizzazione è in realtà una privatizzazione volta a sottrarre il settore pubblico dalle sue responsabilità: una fuga, non una soluzione" (ne "L'Unità", edizione dell'11 giugno 2011).
Ho ascoltato assertori del NO al Referendum argomentare che l'acqua deve essere gestita con gli stessi criteri normalmente seguiti per l'affidamento di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica: ad esempio, il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Se c'è un settore che, più di ogni altro, costituisce la prova provata della cattiva amministrazione, della cattiva politica, del degrado del vivere civile, della criminalità organizzata che si sostituisce ai poteri pubblici e detta le proprie leggi, quello è appunto il settore dei rifiuti!
Bisognerebbe che ogni tanto si dicesse qualche verità scomoda: per le opere pubbliche più complesse dal punto di vista della tecnica costruttiva e per l'affidamento di servizi pubblici di primaria rilevanza sociale, un Legislatore razionale ed insieme realista dovrebbe proibire, scansare come la peste, il criterio dell'affidamento al maggiore ribasso. Quanto più gli operatori economici con cui si viene a contatto sono spregiudicati, tanto più sono disposti a concordare prezzi stracciati pur di vincere la gara. A loro conviene sempre: negli appalti di opere, si può procedere a successive variazioni di prezzo; sia negli appalti di opere che in quelli di servizi, si può guadagnare molto omettendo di fare tutta una serie di adempimenti che per contratto si sarebbe obbligati a fare. Tanto chi controlla? Chi ha preso la mazzetta? L'offerta più conveniente, dal punto di vista dell'interesse generale, si può valutare davvero soltanto ex post, dai risultati: da come un'opera pubblica viene realizzata (anche, da quanto dura nel tempo); dalla qualità e dall'efficienza del servizio che viene reso.
Non sono antistatalista; credo anzi nel valore positivo dello Stato, quando sia uno Stato di diritto. Non è vero che gli impiegati pubblici siano necessariamente inefficienti e che il loro lavoro sia sostanzialmente parassitario. E' quello che vorrebbero dare ad intendere quanti, in questi anni, hanno deliberatamente perseguito l'intento di distruggere dall'interno le pubbliche amministrazioni, proprio perché non potessero assolvere i loro compiti d'istituto. Conosciamo la canzone. Non sanno fare: quindi, affidiamo la gestione dei servizi pubblici agli imprenditori privati. Costano troppo: quindi, lasciamo gli organici scoperti e diamo gran parte del lavoro all'esterno, in "outsourcing". Sono troppo lenti: quindi eliminiamo ogni autorizzazione ed ogni concessione, e consentiamo ai privati di intraprendere e di costruire liberamente, dopo una semplice dichiarazione di inizio attività.
Impiegati pubblici ben motivati, orgogliosi di poter servire la comunità di cui fanno parte, ben organizzati da dirigenti capaci, pagati in modo da poter condurre un'esistenza dignitosa, arricchiti professionalmente da periodici scambi di esperienze con colleghi che altrove svolgono il medesimo lavoro, possono produrre ottimi risultati. Certamente non inferiori ai risultati forniti dai dipendenti, magari sfruttati e mal pagati, di imprenditori privati.
Fino a non molti anni fa, una serie di funzioni di primario interesse sociale erano normalmente assolte da pubblici impiegati: dalla gestione delle risorse idriche, alla manutenzione delle reti fognarie; dal consolidamento degli argini di fiumi e torrenti, alla cura di ville, giardini e spazi verdi; dalla raccolta dei rifiuti, ai trasporti urbani. In questo modo, le amministrazioni e le aziende municipalizzate acquisivano nel tempo un patrimonio di saperi, di conoscenze specifiche. In altri termini, erano le amministrazioni, più che le aziende private, a possedere il vero "know how": cioè il saper far funzionare le cose. Lo stesso fenomeno per cui una volta erano molto ricercati nell'aviazione civile i piloti che prima si erano formati ed avevano fatto esperienza nell'aviazione militare.
Una cosa è lamentare eccessi burocratici e chiedere procedure snelle e trasparenti; altra cosa è tendere all'eliminazione degli apparati burocratici.
Gli oltre ventisei milioni di elettori italiani che hanno votato SI al referendum sulla tariffa del servizio idrico, secondo me hanno voluto esprimere un pensiero di fondamentale importanza, nella sua semplicità: finiamola con le privatizzazioni, che troppo spesso altro non sono che svendite di beni pubblici e regalìe ai privati. Finiamola con la retorica delle liberalizzazioni, perché la cura del bene comune richiede comunque pubbliche amministrazioni ed amministrazioni efficienti. Abbiamo cura dell'acqua, della natura, delle produzioni agricole, del ciclo della vita. La Chiesa cattolica usa un'espressione molto efficace al riguardo: "salvaguardia del Creato". Certamente moltissimi fra i SI sono stati espressi da credenti, cristiani e cattolici. Il loro apporto è necessario e potrà essere determinante affinché il Paese, nel suo insieme, riconquisti la speranza di un futuro migliore.
Riqualificare i poteri pubblici, riorganizzare le pubbliche amministrazioni, studiare le soluzioni organizzative più indicate per tenere la cattiva politica lontano dagli apparati pubblici, assumere in ogni territorio giovani volenterosi e meritevoli che vogliano effettivamente operare al servizio della comunità: una politica nel segno del cambiamento deve fare propri questi obiettivi. Ciò significa avere la consapevolezza teorica e la determinazione politica che occorre voltare pagina, rispetto agli ultimi vent'anni dominati da logiche neo-liberiste.
I fautori del liberismo economico presumono di avere le migliori ricette per promuovere sviluppo economico. Nel breve e medio periodo quelle medesime ricette alimentano, però, forme di occupazione precaria e di vero e proprio sfruttamento lavorativo (cosa succede nel lungo periodo conta relativamente, perché, come diceva Keynes, nel lungo periodo siamo tutti morti). Quelle medesime ricette portano alla devastazione delle risorse ambientali (che non sono illimitate) e questa è una certezza. Infine, spesso portano pure alla distruzione della ricchezza privata accumulata sotto forma di risparmi (come avviene in modo ricorrente con le crisi dei mercati finanziari internazionali). Né, finora, si sono trovate regole sicure e sanzioni efficaci contro gli speculatori finanziari. Siamo di fronte all'evidenza pratica di un fallimento teorico.
Non basta appellarsi al principio che spetta ai pubblici poteri, ossia ai decisori politici, stabilire le regole che poi gli operatori del mercato sono tenuti a rispettare. Troppo spesso questa è una fictio: ogni volta che si fissano regole (a tutela della salute, dell'ambiente naturale, delle bellezze paesaggistiche, o per promuovere uno sviluppo urbanistico ordinato), poi si manifestano subito le spinte di segno contrario, per liberare l'economia dai "troppi lacci e laccioli" che la soffocano. Lo spirito dei tempi di Ronald Reagan fu proprio questo e così si è andati avanti finora.
Qual è il limite massimo di disoccupazione (e di occupazione precaria) che una società può sopportare? Negli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, i politici di professione e gli intellettuali attribuivano importanza prioritaria a questa domanda. Oggi sembra che la questione non vada più nemmeno posta. Errore gravissimo. Per confutare il quale, non serve richiamare ponderosi testi di economia politica. Basta ricordare una canzoncina cantata da Rita Pavone quando interpretava Gian Burrasca, in un fortunato sceneggiato televisivo degli anni 1964-1965: "La storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzion". Questa è l'autentica saggezza popolare. I nostri fratelli Arabi attualmente stanno appunto facendo la loro rivoluzione in Nord Africa e nel Medio Oriente.
Lasciatemi concludere che, dopo tante amarezze e sconfitte, individuali e collettive, il 13 giugno 2011 ho vissuto, con piena soddisfazione e consapevolezza, una bella pagina della storia d'Italia. Ringrazio i ventisei milioni di Italiani che mi hanno regalato questo momento. Anch'io, nel mio piccolo, ho contribuito a regalarlo a loro. Il bello della libera democrazia è questo: che tutti danno e ricevono per affermare una concezione comune.
{ Pubblicato il: 21.06.2011 }
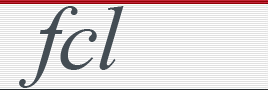




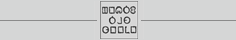




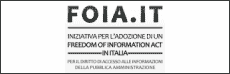






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.