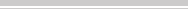gim cassano
Nessun commentoBossi, animale politico cui il fiuto sopperisce ampiamente alla carenza di argomentazioni razionali, sa bene che la parabola del cavaliere è entrata nella sua fase discendente, ma non sa con quale velocità si compirà questo percorso, né cosa vi sarà al termine di esso.
In compenso, sa bene che il sultano cercherà in tutti i modi di governare la situazione, partendo dall’ipotesi preferita di mantenere la rotta attuale, derubricando ad incidenti di percorso fisiologici nella vita di una maggioranza i voti amministrativo e referendario, con l’intento e proseguire sulla strada già avviata con l’attuale maggioranza. Quindi: riforma della magistratura, qualche provvedimento economico, ed una inutile, o meglio dannosa, riforma fiscale imposta a Tremonti, ma da questi scritta allo scopo di costruirvi sopra un possibile anello di congiunzione tra l’età berlusconiana e l’eventualità di un berlusconismo senza il cavaliere.
Bossi sa bene di non poter oggi staccare la spina al governo in carica: unico sbocco ne sarebbero elezioni a scadenza ravvicinata, dalle quali avrebbe tutto da perdere, non disponendo di una linea convincente in termini di proposta e di alleanze. In questo, il suo interesse immediato coincide esattamente con quello di Berlusconi, e quindi è obbligato a fare il possibile perché il governo resti in un modo o nell’altro in piedi.
Ma, detto questo, occorreva anche dare la sensazione ai suoi di saperne prendere le distanze. Infatti sa bene che la spinta propulsiva della Lega appare esaurita: se, sino a ieri, l’idea di una Lega come partito del territorio e del localismo aveva consentito di conquistare consensi anche in presenza di non brillantissimi risultati del PdL, garantendo il successo d’insieme della destra, le difficoltà e le contraddizioni del cavaliere sono divenute di tale entità da ripercuotersi sui suoi alleati.
E sa molto bene che legare i propri destini a quelli del sultano in difficoltà che, nella sua fase di declino appare agli occhi padani molto più condizionato dalle logiche romane di quanto non lo sia stato nei momenti del successo e del “governo del fare”, potrebbe risultare esiziale per il futuro del suo movimento.
A Pontida si poneva quindi un’equazione non facile da risolvere: esser critici sulle questioni che appaiono essenziali agli occhi del cavaliere (giustizia, istituzioni) avrebbe comportato l’immediata apertura di un dissidio di fondo; né si poteva contraddire l’azione di un governo che sino a ieri era stato difeso ad oltranza.
Ma neanche era possibile far finta di nulla: occorreva ribadire i caratteri di populismo localista del movimento, anche a costo di affermazioni inaccettabili o strampalate da parte di un partito di governo, e cercare di evitare quanto più possibile di assumere posizioni politiche chiare. In altre parole, urlare molto, usare toni forti, e dire il meno possibile.
E così, dal “sacro” prato di Pontida, si è cercato di propinare alle plebi prealpine (più che padane) un rituale atto a da rassicurarle riguardo a tre questioni-chiave:
1- l’unità del movimento: era ossessionante il riferirsi a Bossi come al “Capo” (attendiamo la parola del Capo, sotto la guida del nostro Capo, e via dicendo). La regia della faccenda, accanto ai consueti rituali ed all’elencazione dei sindaci neoeletti, quasi tutti emersi da piccoli o piccolissimi centri (tranne Varese, Montebelluna, Dronero e pochi altri), non ha riservato spazio che al discorso di Bossi ed a un breve intervento di un Maroni, di fatto investito del ruolo di successore, che si è profuso in un ragionamento tutto centrato sulla questione immigratoria, ed in funzione di ciò pesantemente e volgarmente critico nei confronti della NATO e dell’Europa.
2- l’identità del movimento: occorreva rassicurare i trinaricciuti delle valli prealpine che la Lega fosse sempre la stessa, dando loro in pasto il consueto campionario di trivialità, doppi sensi e battute da osteria, improbabili suggestioni storiche che accomunavano il Barbarossa ed il Plantageneto da un lato ed Alberto da Giussano e William Wallace dall’altro, proiettando brani di un Bravehearth annunciato in un inglese peggio che approssimativo. E così, abbiamo sentito di tutto: dal citare le funzioni corporali del presidente del consiglio, all’uso del teutonico “borgomastro” al posto di sindaco, al citare l’Insubria, al mitico “secessione”. Sono simboli: ma la politica è fatta anche di simboli, e tanto bastava alle plebi prealpine a farli sentire partecipi del loro “Loss von Rom” (salvo poi richiedere la presenza sul sacro suolo dei ministeri-simbolo del burocratismo romano).
3- Un minimo di prospettiva politica: e qui la faccenda si faceva più complicata. Perché i prealpino-padani, loro malgrado, son pur sempre italiani. E degli italiani possiedono almeno qualcuno dei vizi, tra i quali quello di tendere a scendere come bravi topi (anzi ratt) dalla nave che fa acqua, e quello di tendere a scaricare sugli alleati le colpe dei comuni insuccessi.
Ma il fiuto politico, che non difetta alla dirigenza leghista, faceva capir loro come non vi fossero altre navi in vista; ed allora, in attesa di altro, meglio restare sulla nave attuale per quanta acqua questa possa fare, casomai avvicinandosi il più possibile alle scialuppe di salvataggio. E così, si è partorita la trovata del buttar lì come un osso il trasferimento dei ministeri. Passano due giorni e, di fronte alle levate di scudo del sindaco di Roma e della presidente della Regione Lazio, pare che l’accordo venga trovato derubricando la faccenda a “trasferimento delle sedi di rappresentanza, pur se operative”. Cioè a buttar via per nulla qualche centinaio di milioni di euro, come se questi non fossero costi della politica.
A questo, tra i diktat della Lega a Berlusconi si sono aggiunte prese di posizione demagogiche, quali la riduzione del numero dei parlamentari (ma non delle provincie), e dalle consuete minacce riguardanti un federalismo fiscale sulla cui utilità ed efficacia ormai nessuno più crede, ad iniziare dagli stessi elettori leghisti.
Più rilevante da un punto di vista politico la presa di distanza, poi ribadita da Maroni, nei confronti dell’intervento in Libia. A proposito del quale si è cercato di far passare due concetti: quello di ridurre le spese militari sospendendo l’intervento o riducendo l’impegno nelle missioni all’estero. E quello che sia stato un errore l’intervenire in difesa degli insorti, perché così facendo si è venuta a creare una situazione nella quale non esiste un’autorità civile con la quale trattare il contenimento degli arrivi di rifugiati: come dire che era meglio avere a che fare con Gheddafi (per noi, sia ben chiaro; ma dei libici cosa c’importa?). Ed ancora, arrivando a criticare la NATO perché non si è assunta il compito di attuare i respingimenti in mare, contravvenendo ad ogni criterio umanitario ed alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e richiedenti protezione internazionale.
Ma la cosa che mi appare più significativa è l’interrompersi del rapporto di solidarietà preferenziale con Tremonti. In realtà, il ministro dell’Economia ha iniziato a giocare una partita politica in proprio, che, nel caso di un tracollo dei consensi per un governo che ormai tira a campare, lo potrebbe vedere nei panni del leader di una destra senza Berlusconi.
Si fa avanti il ragionamento su un berlusconismo che faccia a meno del cavaliere, ormai più facilmente impaccio che risorsa per una destra che intenda affrontare da un punto di vista unicamente tecnocratico la questione della stabilizzazione dei conti pubblici, senza porsi troppi problemi di equità, sviluppo, riforme strutturali.
E la cosiddetta riforma fiscale che Tremonti sta mettendo a punto appare il terreno di sperimentazione di un tentativo politico che veda come prima opzione la sopravvivenza del cavaliere senza escludere, alla bisogna, la possibilità di farne a meno; a questa è prontamente arrivato il placet di Confindustria, che ha tutto l’interesse ad una transizione pilotata e moderata al dopo-B; e non è difficile immaginare che altri potranno seguirne.
In effetti, essa viene incontro ad alcune istanze che il cavaliere potrà sbandierare al suo elettorato come “grandi riforme”: la riduzione del numero delle aliquote, che pare andar nella direzione di una flat tax; il trasferimento del carico fiscale dal reddito delle imprese e da una parte (quale?) delle imposte dirette alla riduzione delle detrazioni ed all’aumento delle imposte indirette; tutte azioni che vanno nel senso di politiche redistributive alla rovescia, senza che, dopo il regalo dello scudo fiscale, si parli di tassazione di rendite finanziarie e patrimonio, né di interventi selettivi sulla spesa.
Ma agisce in modo del tutto diverso da quell’allargare i cordoni della borsa che la Lega chiedeva.
E le implicazioni politiche sottostanti sono anch’esse del tutto opposte agli interessi della Lega: Bossi sa bene che in una destra tecnocratica senza il cavaliere la sua capacità di condizionarne le scelte si ridurrà a ben poco.
{ Pubblicato il: 21.06.2011 }
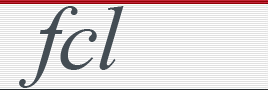




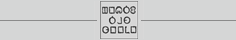




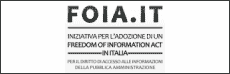






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.