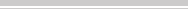gim cassano
Nessun commentoSulle linee-guida sulle quali andrà impostata la politica economica dei prossimi anni, e cioè, in sostanza, sulla cosiddetta riforma fiscale e sulla manovra, (o, più realisticamente, sulle manovre) che dovrebbero assicurare il rispetto degli impegni presi in sede europea circa il rientro del nostro debito pubblico, si gioca una partita di importanza fondamentale per il futuro del Paese.
Il Consiglio dei Ministri di ieri non è solo la rappresentazione evidente di una situazione di stallo tra due concezioni profondamente divaricate sullo stato e sul ruolo dell’economia, la prima delle quali, che fa capo a Tremonti, parte dalla insostenibilità del nostro debito pubblico, mentre nella seconda, impersonata dal capo del governo e da Umberto Bossi, il prius logico è costituito dall’esigenza populista di evitare, alleggerire, rinviare provvedimenti che, chiedendo sacrifici agli italiani, potrebbero alienare ulteriori consensi alla maggioranza di governo.
Dietro questa contrapposizione non c’è soltanto una discussione nell’ambito dell’attuale maggioranza di governo tra due concezioni di politica economica che mi paiono entrambe inadeguate; essa sottende una discussione, che coinvolge anche settori importanti del mondo delle imprese e della finanza (non a caso la bozza di riforma fiscale proposta da Tremonti ha incassato l’immediato placet di Confindustria) sui caratteri di fondo che la prevedibile fase del dopo-Berlusconi dovrebbe assumere.
Se cioè si debba guardare ad un conservatorismo a base populista che prosegua l’andamento sinora seguito, od a un’evoluzione in direzione di un conservatorismo tecnocratico che, senza invertire il percorso seguito dal Paese negli ultimi quindici anni, lo consolidi razionalizzandolo, anche se ciò dovesse richiedere di rinunziare alle seduzioni del paese dei balocchi.
In tempi di crisi economica e finanziaria, i due modelli non possono coesistere, e diventano inconciliabili per la semplicissima ragione che non vi sono le risorse per sostenere in un modo o nell’altro il consenso (sia quello popolare, che quello del parlamento), ed al tempo stesso presentarsi alla comunità finanziaria con politiche dirette a tenere i conti sia pur sommariamente in ordine.
Così si spiega l’incredibile Consiglio dei Ministri di ieri 28 giugno. Le consapevolezze, di Berlusconi di non poter aprire ulteriori contenziosi nella maggioranza, e quella di coloro che già pensano ad un dopo-berlusconi di non poterlo oggi ulteriormente indebolire, pena il naufragio comune non hanno prodotto un piano organico, sia pur scadenziato, ma una serie di annunci che rischia di essere comunque inefficace in termini di credibilità. E si è presa in esame la manovra, per rimandarne le parti essenziali al 2013-2014, quando il debito avrà (nella migliore delle ipotesi), ampiamente superato il 125% del PIL. E quando, comunque sia, vi sarà un governo non coincidente con quello attuale, al quale lasciare in mano la bomba con la miccia accesa.
Di fronte a tanta irresponsabilità, sarà il caso che un centrosinistra che aspiri a governare il Paese sappia essere portatore di proposte credibili, possibili, e non demagogiche: è facile, dai banchi dell’opposizione o dall’esterno del Parlamento, parlare di deficit-spending senza assumersi alcuna responsabilità sulle conseguenze che ne deriverebbero, o considerare l’impegno di stabilità europeo come una bieca imposizione della finanza alla politica.
Ed è anche troppo comodo aver nostalgia dei bei tempi in cui si usava il cambio come strumento di provvisoria competitività, la creazione di base monetaria (fino al 1981) come strumento di surroga del debito, e la conseguente inflazione a due cifre come mezzo di ammortamento dei debiti, con la conseguenza di ripetute e ricorrenti crisi finanziarie che ci allontanavano dal novero dei paesi affidabili. E, anche se questo è un altro discorso, con la conseguenza che proprio da quegli anni ha avuto origine il deterioramento del costume politico.
Piaccia o meno, oggi il rientro dalla massa del debito pubblico italiano è un’esigenza ineludibile ed è, ove sia equamente distribuito, nell’interesse dei meno abbienti e di chi vive del proprio lavoro e delle proprie capacità di impresa e, soprattutto, dei giovani di oggi: il servizio del debito costa attualmente circa 77 miliardi di euro (dato 2011; erano 70 miliardi nel 2010), con un onere pari a circa il 4% dell’ammontare del debito globale, e pari a circa il 5% del PIL, dopo anni di tassi di interessi molto bassi. Ma è cosa certa che, anche se lo stock del debito restasse fermo ai livelli attuali (circa 1900 miliardi), questo costo è destinato ad aumentare a causa dell’inevitabile rialzo dei tassi d’interesse, dovuto a due cause:
- La maggiore richiesta di denaro da parte di tutti gli Stati (USA in primis), necessaria a finanziare deficit che sono sensibilmente aumentati nel corso del 2010 e del 2011. Ciò non potrà avere altro effetto che quello di una tendenza al rialzo generalizzato dei tassi.
- All’interno di questa tendenza, è evidente che il denaro andrà preferibilmente verso quei Paesi ove il rischio è minore. E’quindi facilmente prevedibile che gli spreads tenderanno ad allargarsi, e che i Paesi considerati, a torto o a ragione, come i più sbilanciati subiranno un ulteriore onere aggiuntivo. Già oggi, le emissioni italiane pagano uno “spread” rispetto alle corrispondenti emissioni tedesche pari al 2,25-2,30% (poco meno che la Spagna, e vorrei ricordare che nel 2007, lo spread era pari allo 0,30%).
Ed ancora, se tra rifinanziamenti di emissioni in scadenza e nuovo debito ci si rivolge al mercato per quasi 350 miliardi di euro/anno (dei quali quasi la metà è collocata all’estero), occorrerà pure tener conto di questa necessità, a meno di accettare coscientemente la conseguenza di drenare risorse sempre più ingenti, sino all’insostenibilità, in favore dei detentori del debito, a meno di voler prendere in considerazione ipotesi di tipo argentino.
Bisogna poi considerare che i circa 90 miliardi di incremento annuo del debito pubblico che oggi subiamo, interamente coperti da nuove emissioni delle quali circa la metà sottoscritte in Italia, vogliono dire che ogni anno circa 45 miliardi di nuove risorse vengono sottratte ad altre forme di investimento.
Allora, con buona pace di alcuni che, quasi si trattasse di una congiura ordita da gnomi del capitalismo, considerano con fastidio la questione del nostro debito pubblico, va invece detto chiaramente che il rientro dallo stesso è una grande questione di interesse comune e nazionale, se si vuol evitare che una situazione già grave e tale da paralizzare, senza robusti interventi correttivi, ogni prospettiva di crescita, degeneri ulteriormente e finisca fuori controllo.
Riguardo a questo aspetto, curiosamente vengono a ritrovarsi in una sorta di sintonia trasversale le posizioni di chi irresponsabilmente vorrebbe che venissero “allargati i cordoni della borsa” al fine di non alienarsi il consenso popolare, e quelle di una parte della sinistra che considera il rientro dal nostro debito pubblico come una questione secondaria rispetto a quella di uno sviluppo da assicurarsi attraverso la spesa, e comunque rinviabile a tempi migliori. Mi riferisco ad esempio alle posizioni che Sergio Cesaratto e Lanfranco Turci hanno espresso nella lettera aperta a Bersani del 04-06-2011, o a quelle, ad esse ispirate, espresse da Felice Besostri nel suo intervento “Il governo tra Scilla e Cariddi (per non parlar di sirene ed altri mostri sul fondo del mare)” del 30-06-2011, ove si afferma testualmente: <<Tranne un ristretto gruppo di economisti critici (si veda il documento promosso dal Network per il Socialismo Europeo in vista del vertice Europeo di maggio) nel Governo e nel maggior partito di opposizione non si discute che si debba seguire le prescrizione dell’UE e trovare 40/42 miliardi di Euro per ridurre il deficit e rientrare nei parametri di Maastricht. Le differenze sono su come recuperare le risorse, cosa e quanto tagliare, senza discutere la filosofia di fondo. La scelta dell’UE decisa dalla BCE è una scelta puramente monetaria, che rischia di far saltare la coesione sociale: tagli al welfare e compressione dei salari non innescheranno alcuna crescita virtuosa e senza crescita non si porrà fine ad una compressione del potere d’acquisto dei redditi di lavoro: una costante degli ultimi 10/20 anni secondo i paesi>>.
Questa scuola di pensiero non riesce ad uscire da una concezione riassumibile in un’equazione ormai ben conosciuta: quella del deficit di bilancio come salvifico motore della crescita, accompagnato ad una spesa pubblica elevata da parte di uno Stato poco efficiente e, ove necessario, ad un’imposizione fiscale altrettanto elevata. Il richiamo a Keynes è inappropriato, in quanto il “deficit spending” non fu mai considerato da Keynes una condizione permanente, ma uno strumento per ovviare a fattori ciclici; inoltre, un “deficit spending” che produca essenzialmente spesa corrente in parte generata da inefficienza e clientelismo parassitario è largamente inefficiente al fine di produrre sviluppo.
Ed ancora, ove il debito pubblico superi un determinato limite, che è funzione anche del costo reale del denaro, si arriva ad un punto tale che l’onere che ne consegue fa sì che ingenti risorse vengano sottratte al circuito dell’economia e trasferite a quello finanziario, specie quando, come nel caso italiano, una forte aliquota del debito pubblico sia collocata all’estero.
Non è possibile per un verso ricorrere al mercato per finanziarsi, e per l’altro immaginare di non subirne le conseguenze, perlomeno sin quando se ne ha bisogno. E la conseguenza, brutale ed ineludibile, è che, senza interventi correttivi, e con i tassi di crescita attuali od oggi immaginabili, il nostro debito pubblico arriverà al 130% del PIL nel 2014, con un onere pari al 5-6% del PIL.
Quindi, una sinistra che sappia farsi carico dell’interesse generale non può non avere tra i propri obbiettivi quello della riduzione del debito: perché questa è in definitiva una condizione necessaria per la quale la politica possa riprendere la propria capacità di scelta e di indirizzo.
E, una volta stabilito questo presupposto, una politica non conservatrice e progressista ed attenta allo sviluppo ed all’equità, si distinguerà da coloro che propugnano il mantenimento degli attuali equilibri economici e sociali col ragionare sul come, sul quanto, sul quando, sul dove, sul da chi.
Non essendo immaginabile di poter puntare, in una situazione di debito pari alla nostra, sulla generazione automatica di sviluppo indotta dall’incremento di una spesa pubblica di qualsivoglia caratteristiche qualitative, si tratta allora di stabilire con coraggio e determinazione come riuscire a ridurre il volume complessivo della spesa pubblica, compensando l’effetto deflattivo della riduzione della spesa e del deficit (circa 0,5% di decremento di PIL per ogni punto percentuale di riduzione del deficit incentrato sulla spesa, senza riqualificazione qualitativa della spesa) con un sensibile miglioramento qualitativo della spesa pubblica dal punto di vista della capacità di generare sviluppo, sul quale versante c’è molto da fare.
Occorre dire che, da questo punto di vista, la situazione è molto peggiorata: il contenimento tremontiano del deficit a poco più del 4% è stato ottenuto dopo una riduzione degli investimenti pubblici del 35% tra il 2009 ed il 2011. In altre parole: non si è riusciti a contenere la spesa corrente, che anzi è aumentata, e si sono ridotti gli investimenti: cioè le prospettive per il futuro. Il Paese dei balocchi ha continuato imperterrito la sua corsa, e vengono oggi al pettine le scelte sbagliate di conceder favori a questo ed a quello: valga l’esempio dello scudo fiscale.
Se quindi, come temo, è assolutamente necessario contrarre la dimensione complessiva della spesa pubblica, è evidente che, per compensare l’effetto deflattivo dei tagli occorre una manovra che affianchi al taglio molto severo di alcune spese correnti di dubbia o nessuna utilità economica e sociale, l’incremento degli investimenti in infrastrutture, ricerca, istruzione. Ad esempio: pur considerando una parte delle spese militari come spese capaci di tenere in movimento una fetta significativa del nostro apparato produttivo, lo stesso non avviene con la costruzione di una ferrovia o l’adeguamento di un porto, o con una politica per la casa adeguata in qualità e quantità? E davvero è più utile al Paese di domani una portaelicotteri od una portaerei, rispetto ad un sistema efficiente di infrastrutture in questa o quell’altra regione del Paese, o rispetto ad una scuola pubblica di qualità?
Dobbiamo considerare poi un’altra questione, mutuata dai criteri coi quali un’impresa privata realizza i propri studi di fattibilità: quella dei tempi. Se si realizza un investimento pubblico, dal quale sono attesi benefici in termini di maggiori introiti, minori costi, generazione di reddito, è evidente che le somme stanziate e spese nel corso della fase di studio e realizzazione rappresentano solo costi improduttivi sino al completamento. La questione di snellire ed accelerare gli iter, non solo degli investimenti privati, ma anche di quelli pubblici, è vitale per ridurne il reale costo finanziario e per migliorare la capacità di generare sviluppo.
E si tratta ancora di valutare, in una situazione di difficoltà che non consente l’impiego a pioggia di grandi risorse, quali possano essere quegli interventi a costo pubblico nullo o molto basso, che possano attivare fenomeni di crescita e sviluppo, col creare nuove chances o col rimuovere freni e vincoli. Gli interventi liberalizzatori sulle professioni, immaginati e subito accantonati, rientrano in questa categoria di provvedimenti, con buona pace delle relative corporazioni.
Si tratta quindi di stabilire dove tagliare, ed a scapito di chi e di che cosa, e come riuscire a non penalizzare gli investimenti pubblici già ridottisi -mi ripeto- del 35% in due anni, e di stabilire se a pagare per il tutto debbano essere o meno i soliti.
Non è possibile, al momento, valutare con precisione proposte che ancora non sono adeguatamente definite; ma, nel combinato disposto della cosiddetta riforma fiscale con una “manovra” a rate accuratamente calcolate in modo da non far cadere il peso degli aspetti più gravosi ed impopolari sul governo Berlusconi-Scilipoti, è possibile sin d’ora riconoscere alcuni tratti che ci fanno capire dove si vada a parare.
E cioè: sul fronte dei tagli alla spesa, il peso maggiore graverà sulla scuola, sulla sanità, sui trasferimenti agli enti locali. Peccato che non si parli di spese militari (25 miliardi circa), di abolizione delle provincie (17 miliardi, in parte eliminabili), di sfoltimento e riduzione delle consulenze ministeriali e non, di enti quali l’UNIRE, di costi dei partiti e dei loro fogli stampati per il macero, di emolumenti a “managers” pubblici di ogni risma. E, nel parlare di tagli alla scuola, per quale ragione non si devono eliminare i contributi alla scuola privata (oltre 0,6 miliardi di euro); e perché si devono mantenere l’esenzione ICI sulle attività commerciali di santa romana chiesa, ed una serie infinita di sovvenzioni e contributi (a parte la truffa dell’8 per mille), che nell’insieme superano ampiamente i 600 milioni di euro l’anno?
E sul fronte delle entrate, sembra di capire che la cosiddetta riforma fiscale debba essere a somma zero. Bene adeguare le rendite finanziarie a livelli europei e tassare separatamente le attività di trading delle banche, ma occorre osservare che l’IRPEF 20-30-40, dietro il dichiarato intento semplificatorio, appare un passo verso una “flat tax” che ridurrebbe sostanzialmente la progressività dell‘imposta. Inoltre, il ventilato incremento dell’IVA avrebbe un peso proporzionalmente maggiore nei confronti di chi, per inadeguatezza dello stesso, è obbligato a consumare tutto il suo reddito, o anche più dello stesso.
Una riforma del fisco così concepita avrebbe il solo effetto di trasferire ulteriori pesi su coloro che non appartengono alle categorie di chi ha già beneficiato della riduzione delle imposte di successione, dello scudo fiscale, della generalizzazione dell’esenzione ICI sulla prima casa, dell’imposta fissa sugli affitti, e che si vedrebbero oggi ridurre l’aliquota massima dal 46 al 40%.
E, parlando di riforma fiscale, non sarebbe forse cosa inopportuna il pensare ad un’imposta patrimoniale sui patrimoni maggiori, sensibilmente più moderata di quella francese (che prevede aliquote marginali che vanno dallo 0,55% per patrimoni oltre i 760.000 euro, sino all’1,60% oltre i 16 milioni di euro), finalizzata esclusivamente alla riduzione del debito, che consentirebbe di trasferire quote di imposizione dal reddito al patrimonio, con effetti che è lecito ritenere benefici sulle attività economiche e sull’evasione fiscale.
Credo quindi che vi sia nel centrosinistra, sol che lo si voglia, ampia materia di discussione al riguardo, indirizzata all’interesse generale del Paese e cioè, nell’equità, al rientro del debito pubblico senza compromettere le prospettive di sviluppo. Ma, come al solito, le presunzioni ideologiche non aiuteranno le forze di opposizione del centrosinistra ad individuare soluzioni coerenti, funzionali, e praticabili.
{ Pubblicato il: 01.07.2011 }
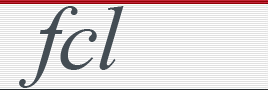




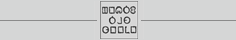




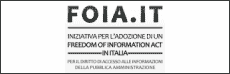






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.