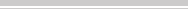mauro barberis – pierfranco pellizzetti
Nessun commentoCONFLITTO
Giustamente, il conflitto e tutte le sue possibili varianti – dal duello rusticano alla libera concorrenza – non è mai stato molto popolare: specie nei paesi cattolici, e ovviamente in Italia. ‘Conflitto’ sembra una parolaccia, che evoca ogni contrasto, resistenza o ripicca che affligge la nostra vita quotidiana; l’esempio paradigmatico di conflitto sembra quella sorta di tomba delle illusioni sulla bontà della natura umana che è una banale assemblea di condominio. Altre situazioni che esemplificano il conflitto, e che contribuiscono a farcelo odiare, sono il processo, in particolare civile, e la politica, specie democratica: come sarebbe bello, verrebbe da dire, se tutti andassero d’accordo e non ci fosse bisogno di parlamenti, tribunali e assemblee di condominio.
La verità è che non riusciamo quasi a immaginare che, quantomeno sulle questioni principali, si possa essere davvero in disaccordo; anche quando assistiamo a quei talk show che sembrano il perfezionamento televisivo degli incontri di catch nel fango, ci consoliamo pensando che sia tutto finto: spente le telecamere i contendenti se ne andranno a braccetto, naturalmente a Trastevere. Che il conflitto appartenga solo alla patologia, e non alla fisiologia sociale ci sembra solo buonsenso: quel buonsenso che purtroppo si rivela invece una specie di pattumiera delle teorie scientifiche ormai confutate. Dopotutto, ci sono intere culture, in particolare orientali, che non riescono a concepire la legittimità, se non la realtà del conflitto: del resto accettate molto di recente anche nella cultura occidentale.
In effetti, è stato un italiano anomalo – il Machiavelli dei Discorsi (1513-1518) – ad azzardare che la potenza di Roma antica non fosse dovuta alla concordia ma proprio al conflitto fra patrizi e plebei: un’idea che faceva a pugni con la filosofia politica classica, per non parlare della morale cristiana. Poi sono venuti tutti gli autori studiati da Albert Hirschman ne Le passioni e gli interessi (1977): tutti coloro che hanno mostrato come l’urto fra le passioni, se trasformato in competizione fra interessi, poteva essere benefico per la società. Un’idea tradizionalmente ostica al familismo italiano, tutto solidarietà e volemose bene, ma accolta con diffidenza anche in paesi come la Francia: che pure ha conosciuto quegli eventi sanguinosi, ma nel lungo periodo salutari, che sono stati la Riforma e la Rivoluzione.
Il conflittualismo – la dottrina della realtà e della legittimità del conflitto – continua così a esserci cordialmente estraneo; e questo benché, o forse proprio perché, negli anni Sessanta-Settanta abbiamo conosciuto forme di conflittualismo marxista, e negli anni Ottanta-Novanta forme di conflittualismo liberista: del resto talvolta propagandati dagli stessi personaggi; come l’Orco italico, al secolo Giuliano Ferrara. Ma nella stessa cultura politica angloamericana, che nelle sue varianti liberal e libertarian sembra divenuta la patria d’elezione del conflittualismo, si tratta pur sempre di corrente minoritaria, rispetto al mainstream rappresentato dalla dottrina della giustizia di John Rawls: una sorta di eresia alimentata da autori eterodossi come Isaiah Berlin o Stuart Hampshire. Eppure, quanto è convincente l’idea di quest’ultimo: parlamenti, tribunali, e persino assemblee di condominio, sono le uniche istituzioni davvero irrinunciabili, proprio perché servono (non a soffocare, ma) ad arginare, incanalare e rendere produttivo il conflitto.
MB
Bibliografia minima:
I. Berlin, Due concetti di libertà a cura di M. Ricciardi, Feltrinelli, Milano, 2000.
A. O. Hirschmann, Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo, Feltrinelli, Milano, 1979.
N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Rizzoli, Milano, 1984
S. Hampshire, Non c’è giustizia senza conflitto, Feltrinelli, Milano, 2001.
LIBERTÀ
Qualche tempo fa, a Rimini, alcuni giovanotti annoiati hanno pensato bene di dare fuoco a un barbone: così, tanto per passare il sabato sera. Dopo i primi pensosi editoriali, la stampa ha dimenticato l’evento: e forse ha fatto bene, se è vero che notizie come queste non suscitano più neppure indignazione, e invece rischiano di suscitare emulazione da parte di una folla di psicolabili. Anche qui di seguito, del resto, la notizia servirà solo da termine di paragone per rispondere alla seguente domanda: quanto è aperta la nostra concezione della libertà? In particolare: saremmo disposti a dire che, dando fuoco al barbone, gli incendiari di Rimini hanno esercitato la loro libertà?
Probabilmente no; la resistenza che ognuno di noi avverte, qui, a parlare di libertà, deriva dalla condivisione di quella che nel dibattito internazionale si chiama una concezione moralizzata (ingl. moralised) della libertà. Detto altrimenti, non abbiamo la libertà di fare qualsiasi cosa ci passi per la testa, ma solo ciò a cui abbiamo in qualche modo diritto; ed è chiaro che nessuno ha diritto a mettere a fuoco i propri simili, meno che mai i barboni. Come pure si dice, la nostra libertà finisce dove comincia quella altrui: e i barboni hanno diritto non solo di vivere, ma proprio di vivere da barboni, purché lo abbiano scelto liberamente.
Eppure, come ho cercato di mostrare in un vecchio libro intitolato appunto Libertà (Il Mulino, 1999), tutta la storia del pensiero occidentale è attraversata dalla divisione fra questa concezione della libertà, detta talvolta positiva, ma che qui chiamerò Libertà di fare quel che si deve, o concezione moralizzata della libertà, e un’altra concezione: talvolta chiamata negativa, ma che qui chiamerò Libertà di fare quel che si vuole o anche concezione grezza. Sino all’Ottocento, le persone colte, e in particolare i filosofi, hanno di solito adottato la concezione moralizzata: per loro, cioè, si era liberi solo di fare quel che si deve o che è lecito; fare quel che si vuole, per loro, non era vera libertà, ma licenza.
La gente comune, però, e anche quei filosofi plebei che sono stati Thomas Hobbes e gli utilitaristi, l’ha però sempre pensata diversamente: hanno sempre pensato che la vera libertà fosse proprio fare quel che si vuole, ma che proprio per questo occorresse diffidarne. In effetti, questa libertà grezza – la «libertà selvaggia» di Kant – sembra quella dei contadini di Bronte nell’omonima novella di Giovanni Verga, quando pensarono di avere il diritto di riprendersi le terre accoppando i padroni; peggio ancora, sembra proprio la libertà degli incendiari di Rimini.
Può apparire sorprendente, stando così le cose, che il liberalismo ottocentesco prima, il neoliberalismo novecentesco poi, abbiano adottato proprio quest’ultima concezione della libertà e ne abbiano fatto il loro ideale politico, sociale ed economico. Eppure, proprio questo è successo: da ultimo, nel lungo periodo che va dalla Guerra fredda sino alla grande crisi finanziaria dello scorso autunno. Oggi, diventa facile dire che una concezione del genere sembra poter servire quasi esclusivamente dal punto di vista conoscitivo: ad esempio, al fine di misurare la quantità di cose che, di fatto, possiamo o non possiamo fare. Dal punto di vista normativo – come ci ricordano, a modo loro, gli incendiari di Rimini – occorre una concezione differente: una concezione che ci dica non solo ciò che possiamo di fatto, ma anche ciò che ci è lecito di diritto.
MB
Bibliografia minima:
M. Barberis, Libertà, Il Mulino, Bologna 1999
N. Bobbio, Thomas Hobbes, Einaudi, Torino 2004
Liberalismo e Democrazia, Simonelli, Milano 2006
Eguaglianza e Libertà, Einaudi, Torino, 2009
G. Sartori e R. Dahrendorf, Il cittadino totale, Biblioteca della Libertà, Torino 1977
FUTURO/UTOPIA
Ci manca il futuro. Manca ai giovani, ai quali per la prima volta da molti secoli si dice che staranno peggio dei loro padri: previsione che potrebbero anche ignorare, come tutte le previsioni, se non incontrassero già oggi i limiti, le chiusure, che le generazioni precedenti hanno apparecchiato per loro. Allora si accorgono dei privilegi dei vecchi e protestano, soprattutto in Italia, contro la gerontocrazia: com’è avvenuto a intermittenza nella lunga vicenda della riforma universitaria, nella quale due generazioni di studiosi si sono trovate opposte l’una all’altra. Così, stufi di aspettare il loro futuro nel tempo, i giovani lo cercano allora nello spazio, in un altrove che i padri non abbiano già occupato. E se ne vanno all’estero: anche se – come ci ricorda Snoopy – si può saltare il recinto e restare pur sempre in questo mondo.
Ma il futuro manca ancor di più, forse, a quelli della mia generazione: e non solo perché lo spazio-tempo – quest’unica dimensione del desiderio – si consuma ogni giorno che passa. Il futuro manca ancora di più a noi: figli del boom cresciuti in un’epoca nella quale non c’erano limiti né spaziali né temporali al desiderio; in cui tutto era ancora letteralmente possibile, se non oggi e subito, certo domani e altrove. Naturalmente, a questo punto, tutti pensano al Sessantotto e dintorni; io penso ai viaggi spaziali, che oggi sembrano una fuga, una curiosa parentesi da chiudere al più presto per mancanza di fondi, mentre allora si trattava semplicemente della promessa di un futuro, per un pianeta già allora divenuto troppo stretto per la nostra specie.
Naturalmente, il clima di un’epoca dipende dalle sue condizioni materiali, dall’espansione demografica, dallo sviluppo industriale, persino dallo sviluppo delle città: tutte cose che oggi, in tutt’altra epoca, sembrano solo ubris, violenza perpetrata ai danni della Terra e delle generazioni future. L’accelerazione del tempo storico si sta mangiando il futuro: cancellando l’utopia e lasciando spazio solo alla futurologia, o ai divulgatori di leggende metropolitane, profeti della fine del mondo dietro l’angolo. All’ultimo convegno cui sono stato, uno studioso serissimo – allievo di quel Norberto Bobbio che s’interrogava ancora sul futuro della democrazia, lui: noi siamo già alla post-democrazia – annunciava agli astanti distratti la prossima terza guerra mondiale.
Programmare, pianificare addirittura? Come si fa con la crisi, con la complessità, con gli effetti perversi dell’azione sociale? La nostra è l’epoca degli improvvisatori, trionfalmente iniziata con Ronald Reagan che non prendeva una decisione senza consultare l’astrologo; già lord Keynes, del resto, diceva che a lungo termine saremo tutti morti. Insieme con il futuro, in effetti, sembra andarsene anche la libertà di scelta: tutta la libertà che ci possiamo permettere, qui, è la coscienza della necessità, à la Spinoza o à la Hegel, questi. Se mi si puntasse la pistola alla tempia e mi si chiedesse di scegliere un futuro, per questo decrepito paese o più semplicemente per me, risponderei chiedendo agli Dei che fosse in Europa: non in Africa né in Asia, dove invece stiamo andando, e meno che mai nel vasto mondo, dove ci perderemmo, ma proprio qui, in questo spazio domestico sulla nostra misura. L’Europa dei caffè e dei regolamenti comunitari più assurdi: il luogo crepuscolare dei quadri di Magritte, con le luci notturne già accese e il cielo smaltato sullo sfondo.
MB
Bibliografia minima:
R. Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Marietti, Casale M. 1986.
PARTITO
La fuga nel passato di questi nostri tempi, insieme a vasti repertori archeologici e varia paccottiglia nostalgica, riporta in auge il sogno di un improbabile ritorno alle forme della politica di “come eravamo”. Imbarazzante rimpianto, indizio di un blocco mentale che impedisce la ricerca di soluzioni a misura del presente.
Sicché vai a un convegno di reduci dal PSI (quelli che «non hanno dimenticato niente, non hanno imparato niente») e senti subito il fruscio di un sospiro collettivo: ci vorrebbe un partito... La gracilità del neonato PD troverebbe adeguate cure vitaminiche nell’accelerazione verso una compiuta forma-partito... Berlusconi, dal predellino di un’auto in San Babila, fonda una SPA di chi è l’unico azionista e la chiama partito...
Si direbbe non ci possa essere politica, partecipazione e neppure democrazia al di fuori dei perimetri in cui la si è organizzata negli ultimi due secoli: i venerandi partiti come agenzie e strutture organizzate dell’agire pubblico.
È proprio così? O non piuttosto la forma-partito è prodotto storico, dipendente dai vincoli di condizioni congiunturali? Condizioni senza le quali tale forma diventa inevitabilmente un guscio vuoto, gozzaniane violette appassite.
In effetti i partiti nascono da uno specifico contesto sociale, dai suoi conflitti come dalle tecnologie di cui dispone. Dunque, la società inglese del Seicento e francese del Settecento, in cui il nuovo ordine borghese lottava per soppiantare il vecchio regime aristocratico; poi quella industrialista, in cui capitalisti e operai contendevano a difesa dei rispettivi interessi. Conflitti virati dalla guerra civile endemica a regime parlamentare grazie all’invenzione della rappresentanza.
I partiti incanalarono queste società concrete quali soggetto rappresentativo di tale contrapposizione, fino all’ultima evoluzione: le organizzazioni di massa, a misura di una produzione e di un consumo di massa. Ossia, il mondo che chiamiamo “fordista”, proprio in quanto è stato il paradigma inventato a Detroit, nello stabilimento automobilistico in cui si applicava per la prima volta la standardizzazione e la divisione parcellizzata del lavoro, a fornire i criteri prevalenti per governare la nascente complessità: gerarchici e piramidali.
La società calco di cui la fabbrica è lo stampo.
Purtroppo (o per fortuna) un mondo alle nostre spalle. Quello che ormai ci sta innanzi vede la prevalenza di paradigmi profondamene diversi: flessibili e a rete.
Sicché, all’inizio degli anni Novanta ha preso avvio in Europa una discussione sulle nuove modalità di organizzare la decisione pubblica, a seguito della presa d’atto dei guasti prodotti dalla deregulation sfrenata (che si era imposta nel decennio precedente; dopo il discredito dei vecchi modelli burocratici centralizzati, rivelatisi incapaci tanto di governare i fenomeni di stagflazione che avevano accompagnato la fine del “Capitalismo amministrato” del dopoguerra, quanto di rispondere efficacemente alle sfide crescenti poste dalla globalizzazione).
Il dato da cui si partiva era l’ulteriore, crescente, complessificazione dei fenomeni in essere e l’estrema varietà dei fattori da tenere sotto controllo. In primo luogo, la presa di coscienza di un deficit informativo a causa del quale nessun attore in campo “sa tutto” ma tutti “sanno qualcosa”. Da cui l’immediata necessità di portare a fattore comune i diversi patrimoni cognitivi, insieme alle rispettive risorse operative, grazie a strategie di alleanze mirate; superando la tradizionale distinzione tra “pubblico” e “privato”.
È nel corso di questa discussione che prendono corpo e si precisano due idee su cui fondare tali Nuove Politiche Pubbliche:
A.il concetto di “governance”, applicato a un’epoca in cui l’architettura di rete diventa il paradigma di riferimento nella cultura organizzativa: «la forma di organizzazione sociale e di coordinamento, alternativa tanto al mercato quanto alla gerarchia, caratterizzata da rapporti cooperativi», anche a distanza;
B. il modello dell’amministrazione “catalitica”.
Secondo Arnaldo Bagnasco «in una società via, via più complessa, nella quale diversi sottosistemi si differenziano e autonomizzano, la governabilità complessiva dipende meno da un unico centro capace di controllo e più da meccanismi di negoziazione fra differenti gruppi e reti di attori, che comprendono le autorità politiche e amministrative». Attori sia pubblici che privati.
David Osborne e Ted Gaebler, nel celebre saggio Reinventare l’amministrazione (1992), hanno definito l’amministrazione post-burocratica come “amministrazione catalitica”: il catalizzatore è quella sostanza che non partecipa a una reazione chimica ma la rende possibile. Allo stesso modo l’amministrazione proposta da Osborne e Gaebler, non assume le decisioni in prima persona, ma cerca di prenderle con gli altri o farle prendere da altri, ossia stimola la partecipazione, l’iniziativa e la corresponsabilizzazione della società civile
Dunque, una governance di tipo inclusivo, guidata da una strategia condivisa in grado di attivare una vasta gamma di soggetti per azioni sinergiche; in cui il soggetto pubblico svolge una prevalente funzione di “regia” (far fare, più che fare), accompagnamento e controllo.
Ma - a fronte di questo ribaltamento di prospettive - dalle nostre parti l’innovazione politica in materia di paradigmi organizzativi, per la partecipazione democratica e la rappresentanza, risulta drammaticamente in ritardo; come ne dà testimonianza l’ansia di spingere all’indietro le lancette della storia.
Eppure qualcosa di nuovo sotto il sole ci sarebbe, come si è visto: esperienze deliberative a livello urbano (prima fra tutte quella di pianificazione strategica avviata a Barcellona già nel 1984); esperimenti che ricollocano la funzione di “dare la linea” (l’interpretazione che guida l’azione pubblica), già svolta dai partiti, nei cosiddetti think tanks; network territoriali di club (l’esempio dei circoli Jean Moulin e Tocqueville con cui i progressisti francesi ricostituirono legature, inventariarono elaborazioni e selezionarono classe dirigente dopo la crisi della vecchia SFIO).
Altro si potrebbe escogitare, se solo ne discutessimo. Se le intelligenze della politica lavorassero in cantieri di pensiero rivolto al futuro.
Invece di continuare a rigirarsi tra le dita violette gozzaniane.
PFP
Bibliografia minima:
A. Bagnasco, Tracce di comunità, Il Mulino Bologna 1999
M. L. Bianco, Classi e reti sociali, Il Mulino, Bologna 1996
R. Dahl, I dilemmi della democrazia pluralista, EST, Milano 1996
D. Della Porta, I partiti politici, Il Mulino, Bologna 2009
R. Hinglehart, La società postindustriale, Editori Riuniti, Roma 1998
R. Harvey, La crisi della Modernità, EST, Milano1997
P. Ignazi, I partiti politici, Il Mulino, Bologna 1997
P. Pellizzetti, La politica dopo la politica, Pendragon, Bologna 2002
P. Perulli, La città delle reti, Bollati Boringhieri, Torino 2000
A. Pizzorno, La politica assoluta, Feltrinelli, Milano 1993
PERIFERIE
Le città - come i sistemi territoriali in genere - si ripartiscono in “centro”, “semiperiferia” e “periferia”; in base ad una gerarchia di mansioni a loro volta correlate a differenti livelli di capitalizzazione. Da cui derivano quei dislivelli economici e sociali tra le differenti zone che vanno trasformandosi in sbarramenti reali e virtuali. In primo luogo la cosiddetta “gentrification” (trasformazione in zona signorile) del contesto residenziale e commerciale, indotta dall’alto reddito
Dunque, il dualismo centro-periferia come prodotto dei rapporti di dominio. Con un codicillo: la specializzazione del territorio non corrisponde strettamente a meccaniche perimetrazioni dentro/fuori: sono ipotizzabili zone periferiche nell’area centrale (vedi le suburre come cisti dei Centri Storici) e - di converso - aree a funzione centrale nelle fasce più esterne (vedi le cosiddette edge city, le “città ai bordi”: consistenti concentrazioni di uffici e attività economiche lungo gli assi residenziali di aree periferiche che sono collegate a localizzazioni centrali mediante apparati elettronici avanzati; come nei casi de La Defense a Parigi o il Docklands londinese).
La gerarchizzazione degli spazi urbani porta a definire le odierne “periferie” come i luoghi della marginalità e della subalternità.
Non più le fasce “fisicamente” esterne della città; dove l’attività economica urbana iniziava sfocarsi, trascolorando senza soluzioni di continuità in quella rurale. Quanto fino a ieri ci rappresentava il senso comune: dalle “città aperte” dell’antichità greca e romana fino alla città industriale della Modernità. Ossia, fino a quando non è avvenuto lo svuotamento del contratto sociale tra capitale, lavoro e Stato; frutto assai poco commestibile della stagione Neo-Lib che ha dominato l’ultimo trentennio. Ed è iniziata ad avanzare una nuova fase di capitalismo deregolato che tende a ricondurre a sistema economico ogni mondo della vita. Con immediato impatto anche sulla configurazione urbana e la messa in gerarchia dei suoi spazi, nella logica dell’egemonia e della conseguente subalternità indotta.
Perché le città - ce lo ricorda storico del fenomeno urbano Lewis Mumford - «sono un prodotto del tempo».
Nell’odierna fase storica il Capitalismo, finanziarizzandosi e smaterializzandosi (dirottando le attività manifatturiere lungo i canali del decentramento produttivo globale), ha perso definitivamente la propria connotazione industrialista del periodo immediatamente precedente, che consentiva alle aree urbane esterne dell’età keynesiano-fordista di non essere intrinsecamente marginali né totalmente subalterne al comando centrale; grazie all’organizzazione politica del lavoro come al conflitto per i diritti e i risarcimenti. Infatti, questa è l’epoca in cui le tendenze dominanti perseguono la svalorizzazione dei fattori materiali, dalla produzione alla vita.
Quindi la svendita del territorio nella speranza di attirare nuovi investimenti. Quindi la svendita del lavoro (la precarizzazione ingentilita dal nome “flessibilità”)..
La svendita di territorio e lavoro impatta soprattutto sulle fasce marginali e subalterne della città - le sue aree periferiche in senso lato - minandone le basi identitarie e consumandone il capitale sociale originario di relazione.
La città centrale - così - desertifica o consente vengano desertificate le sue aree esterne in quanto marginali, dunque condannate all’inespressività; innalza barriere, marca perimetri. Un processo di ghettizzazione “nei due sensi”, in linea con gli esiti intrinseci alla guerra civile non dichiarata dagli insiders contro gli outsiders (che già nel 1996 faceva scrivere a Lester Thurow: «oggi le comunità murate, blindate e sorvegliate sono di nuovo in ascesa. Se si considerano tutti i condomìni protetti da vigilanza privata, sono 28 milioni gli americani che vivono in comunità di questo tipo, e si prevede che il loro numero raddoppi nel prossimo decennio». Ricordiamoci che, all’epoca, l’11 settembre non era ancora deflagrato!).
Conseguentemente, le periferie diventate insignificanti (economicamente come identitariamente) non sono più in grado di fornire significati di appartenenza tali da orientare le donne e gli uomini che in quello spazio vivono (o forse vi ritornano solo per dormire). Diventano “aree dismesse”, popolate da uomini e donne dismessi.
Mentre si avvicina il raggiungimento del punto di rottura in un “modello centrocentrico” (il Centro-vetrina splendente e splendido) che dirotta ogni risorsa all’abbellimento delle zone di rappresentanza e residenziali, trasformando contestualmente in discariche di bruttezza i circuiti esterni. Intanto, nel vuoto che va creandosi, trovano crescente spazio fenomeni malavitosi, organizzati o meno.
Nasce da qui l’attuale dibattito europeo sulla pianificazione territoriale, intesa come occasione storica di trasformazione concreta. Proprio a partire dalla questione delle “aree dismesse”, per ottenere un effetto in contro tendenza (centrificazione) sulle fasce urbane attualmente marginalizzate.
Pur avendo sempre ben chiaro che - in base a un gioco di parole intraducibile nella lingua italiana- gli spazi urbani sono havens not heavens: Porti, non Paradisi.
PFP
Bibliografia minima:
V. Gregotti, Diciassette lettere sull’architettura, Laterza, Bari 2000
L. Mumford, La cultura delle città, Ed. Comunità, Torino 1999
M. e P. F. Pellizzetti, “La rosa di Londra”, Queste Istituzioni 135/2005
S. Sassen, Le città globali, il Mulino, Bologna 1997
L. C. Thurow, Il futuro del capitalismo, Mondadori, Milano 1997
LAVORO/LAVORI
Ormai abbiamo alle spalle quello che è stato definito «il secolo DEL lavoro».
Il XXI sarà «il secolo DEI lavori»? O piuttosto dei «lavoretti»?
Di certo, il brusco arresto e l’inversione del trend millenario con cui questa pratica seppe ribaltare il giudizio sociale nei propri confronti: a lungo disprezzata «macula» servile (“fatica”) nell’immobile mondo agricolo della rivoluzione neolitica, inizia a rivalutarsi con il Cristianesimo e già San Benedetto lo elegge quale primario mezzo di salvezza, nella rimembranza del «lavoro felice» prescritto da Dio ad Adamo prima della caduta.
Sarà la rivoluzione industriale a sancirne la definitiva consacrazione, in una duplice lettura: ideologia borghese dell’operosità e utopia proletaria del riscatto; nella comune priorità assegnata al senso del dovere e al culto per il “ben fatto”.
Riscatto di classe attraverso il “ruolo sociale coperto” che, nei contesti industrialmente avanzati del Nord Ovest italiano all’inizio del Novecento (l’epicentro della Prima Rivoluzione industriale nazionale) si biforca: in lotte per la «dignità del lavoro», nelle grandi fabbriche dove gli operai sono sottoposti al comando industrialista, e in quelle per la «responsabilità del lavoro»; ad esempio sulle banchine del porto di Genova, dove I portuali (i camalli) si battono per l’autogoverno delle “chiamate” al lavoro. Due epopee. Le epopee di quelle “lotte del lavoro” (che entusiasmarono perfino un liberale conservatore quale Luigi Einaudi) con cui donne e uomini si integravano a pieno titolo nella società.
Le lotte collettive che partivano dal posto di lavoro per conquistare il diritto a una vita più degna. Per tutti.
Anche i simbolismi registrano tale rivalutazione: la magrezza, da sintomo umiliante di inferiorità, diventa condizione estetica perseguita fino alle odierne follie anoressiche; le retoriche delle mani callose degli operai nei manifesti dell’Internazionale socialista relegano nel risibile l’unghia ben curata del dito mignolo con cui il mandarino confuciano o lo sfaccendato barone meridionale (modello inconfessabile di ogni travet) per secoli avevano attestato la loro totale estraneità all’attività manuale; da «vil meccanici».
L’estetica nata dal e nel lavoro come costruzione dell’immaginario sociale del tempo.
Un immaginario che trova la sua istituzionalizzazione nell’accordo tra borghesia imprenditoriale e manodopera sindacalmente organizzata. Il cosiddetto «compromesso fordista-keynesiano» (Henry Ford Senior, l’imprenditore visionario che inventa - grazie alla grande fabbrica integrata - il capitalismo di massa con la trasformazione del lavoratore in consumatore, e John Maynard Keynes, l’economista fuori dagli schemi che costruisce la grande teoria dello Stato Sociale e dell’investimento pubblico in funzione anticiclica).
A quel punto il lavoro ha vinto e può - così - marcare della propria impronta indelebile il secolo Ventesimo.
Ma in quel successo, nelle sue straordinarie acquisizioni (dalla cittadinanza sociale all’addomesticamento del Capitalismo), già sono presenti i fattori della sua futura sconfitta: in primo luogo il graduale esaurimento delle politiche redistributive e la burocratizzazione delle organizzazioni preposte a promuoverle (sindacati e partiti di sinistra), che determinano quella nuova situazione per cui - a partire dagli anni Settanta del secolo scorso - si esaurisce la capacità di resistere all’attacco delle forze contrarie, alla predicazione neoliberista; la prevalenza del consumo nel determinare gli stili di vita, per cui oggi più “che cosa fai” diventa importante “ciò che hai”; il nuovo modo di produrre che decentra e sminuzza, con la fabbrica, anche le vecchie appartenenze di classe.
Risultato: insieme all’identità, va pure in briciole l’idea del lavoro come valore, come centro della vita. Quale primario “determinante sociale”.
Soprattutto per le giovani generazioni.
Lo possiamo facilmente constatare – ad esempio - visitando quegli istituti tecnico-professionali che per generazioni avviavano al lavoro i figli degli operai o i corsi di restauro urbano: vi troveremmo solo allievi extracomunitari.
Il lavoro non è finito. Si è solo inabissato, scomparendo allo sguardo dei media e della pubblica attenzione. È diventato politicamente irrilevante, battuto sul piano culturale. Emarginato.
L’invito pressante della pubblicistica liberista a «diventare tutti imprenditori», abbandonando le antiche certezze, lo indirizza verso un destino carico di rischi e crescenti responsabilità al ribasso. Su cui non brilla più il Sol dell’avvenire.
PFP
Bibliografia minima:
- Accornero, Era il secolo del lavoro, Il Mulino, Bologna 1997
L. Einaudi, Le lotte del lavoro, Einaudi, Torino 1997
L. Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino 2003
J. Le Goff, Tempo della chiesa, tempo del mercante, Laterza, Bari, 2004
J. Rifkin, La fine del lavoro, Baldini e Castoldi, Milano 1995
B. Trentin, La città del lavoro, Feltrinelli 1997
I testi sono tratti da Le parole del tempo, Manifestolibri
{ Pubblicato il: 30.01.2011 }
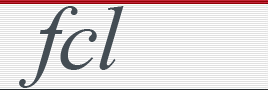




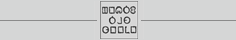




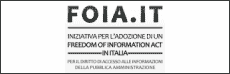






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.