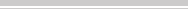paolo fai
Nessun commentoLa storiografia romana viene definita moralistica e, secondo Cicerone, genere oratorio al massimo grado, opera letteraria dunque con intenti artistici ed educativi, che si conseguono fornendo al lettore modelli di virtù da seguire e di vizio da esecrare. Insomma, la storia come maestra di vita.
A quella tipologia, che nessuno dei moderni etichetta come “scientifica”, non sfugge nemmeno Tacito, la cui opera però, assieme al suo modello Sallustio, rimane insostituibile modello di lettura dei fenomeni storici, specialmente di quelli che segnano discontinuità e fratture significative col passato. Per Sallustio, la guerra contro Giugurta, come epifania della corruzione della classe dirigente senatoriale rispetto a un passato di memorabili virtù civiche, e la congiura di Catilina, come tentativo violento di abbattere uno Stato che gli appare irriformabile perché la classe dirigente è ostaggio del lusso e della cupidigia, “due vizi diversi ma parimenti funesti”. Per Tacito, che “legge” i poco più di cento anni di storia dell’Impero romano con gli occhi dello storico di rango senatorio, all’origine del declino della repubblica, più che il “colpo di stato” dolce di Ottaviano, va posta l“infamia della servitù” che si diffuse tra i senatori, per compiacere e adulare il princeps senatus. Consapevole che dall’Impero non si torna più indietro e che con esso si è perduta la libertà repubblicana, Tacito “trova” – si direbbe con espressione tucididea – la causa prima della fine della repubblica nella “libido adsentandi”, nel piacere incontrollato di dire sempre sì al volere del capo, per cavarne benefici personali.
Ammesso che sia vero che la storiografia moderna prescinda del tutto dalle valutazioni etiche nel “raccontare” la storia di Napoleone Bonaparte o di Stalin o della cosiddetta Prima Repubblica italiana, il problema è di quelli che – come si dice – cacciati dalla porta rientrano dalla finestra. Insomma, uno Stato ha una credibilità grande o piccola a seconda del grado di corruzione che l’attraversa e con cui riesce a convivere, partendo dal dato acquisito e inconfutabile che la corruzione si annida in tutti i regimi, dal democratico al dittatoriale. Ma, mentre in quest’ultimo il “popolo” non ha strumenti di riformabilità del sistema perché le leve del potere sono nelle mani di una cricca devota ad uno solo, in democrazia gli strumenti ci sono, e sono le libere elezioni, con le quali i cittadini possono decidere di mandare a casa, mediante il voto, una classe dirigente inetta, corrotta, corruttrice e per di più arrogante.
Questo, però, in teoria, perché anche in democrazia, e specialmente in una democrazia come quella italiana, attualmente nelle mani di un ricchissimo imprenditore che ha costruito la sua fortuna politica sul possesso e sull’uso spregiudicatamente “diseducativo” di ben tre reti televisive (per non parlar d’altro), dove «la servitù volontaria passa oggi soprattutto attraverso i media», l’arte di adulare può raggiungere livelli inverosimili. Come in un regime monocratico. Non si può dar torto allora alle parole virgolettate di Paolo Flores D’Arcais, che concludono l’introduzione al bel pamphlet di Etienne de la Boétie, dal significativo titolo Discorso sulla servitù volontaria, pubblicato nella collana Instant Book da Chiarelettere editore, euro 7. È un opuscolo che si legge d’un fiato e che risulta molto illuminante in questi tempi di “scilipotismo” diffuso, capillare, che, dal Parlamento alla periferia del Paese, appare come lo stigma dell’identità italiana, la vocazione a compiacere il nuovo Principe in nome del mai tramontato motto “tengo famiglia”.
Etienne de La Boétie (1530-1563), amico fraterno di Michel de Montaigne, sostiene che se i tiranni restano al potere, la colpa è solo degli uomini che glielo permettono. «È cosa davvero sorprendente – scrive de La Boétie –, eppure tanto comune da doversene rattristare piuttosto che stupire, vedere migliaia d’uomini asserviti miseramente, con il collo sotto il giogo, non già costretti da una forza più grande, ma in qualche modo, come sembra, incantati e affascinati dal solo nome di uno, di cui non dovrebbero né temere la potenza, poiché egli è solo, né amare le qualità, poiché nei riguardi di tutti loro è disumano e feroce… È straordinario sentir parlare del valore che la libertà infonde nell’animo di coloro che la difendono. Ma ciò che accade in tutti i paesi, presso tutti gli uomini, ogni giorno, che un unico uomo ne opprima centomila e li privi della loro libertà, chi mai vi crederebbe se ne avesse solo sentito parlare, senza vederlo con i suoi occhi?».
L’aureo libretto, meritevole di diventare “libro da comodino” per chi crede nel valore della dignità e della schiena diritta, per gli “indignados” di oggi e di domani (per i cinici e gli opportunisti servono solo i libri contabili), è seguito dal breve Saggio sull’arte di strisciare a uso dei cortigiani di Paul H.D. d’Holbach. Vi si può ritrovare, come in uno specchio, chiunque alla Montalcini preferisce Scilipoti.
{ Pubblicato il: 06.09.2011 }
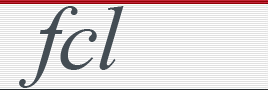


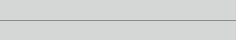

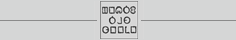




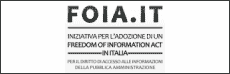



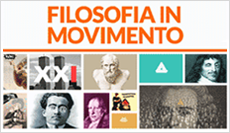


 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.