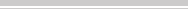giulio ercolessi
1 commento
SECONDA PARTE
Istruzione e ricerca: gli investimenti più indispensabili.
Nel campo dell’istruzione, invece, il ruolo di garanzia dello Stato deve restare decisivo.
All’opposto di quanto irresponsabilmente sostenuto da alti esponenti del governo uscente, quello sull’istruzione è, nella società contemporanea, l’investimento maggiormente indispensabile e più produttivo per il futuro di ogni paese. Proprio quando i principali paesi emergenti investono nell’istruzione ogni possibile risorsa, proprio quando gli altri paesi occidentali, pur alle prese con tagli di bilancio e riduzioni anche draconiane della spesa pubblica, evitano di ridimensionare gli investimenti per l’istruzione perché consapevoli che è su quel terreno che si giocherà nei prossimi decenni gran parte della competizione internazionale, la più irresponsabile delle scelte del governo Berlusconi è stata quella di tagliare prioritariamente le spese per la scuola pubblica, per l’università, per la ricerca scientifica.
Inoltre, in campo educativo, gli individui interessati, minori di età o comunque privi di autonomia economica, non possono operare individualmente alcuna scelta. La tesi secondo cui dovrebbero essere essenzialmente le famiglie a scegliere indirizzo e tipo di scuola dei propri figli, attraverso l’attribuzione di buoni scuola o istituti simili, si presenta spesso come una scelta liberale ma non lo è, per più ragioni.
Innanzitutto, la società italiana adulta è oggi, con ogni evidenza, essa stessa terribilmente carente in fatto di educazione alla cittadinanza e alla legalità. L’educazione civica (in senso lato), e non solo l’istruzione necessaria all’affermazione in campo lavorativo, è il bene diffuso più prezioso che difetta largamente all’attuale società italiana. Ci sembra indiscutibile che, per moltissime famiglie, nell’attuale deprecabile stato della società italiana, l’obiettivo è certamente quello di ottenere il meglio per i propri figli, ma questo “meglio” non sempre ha molto a che fare con quella ricostruzione civile e con quella restaurazione dell’etica pubblica di cui la società italiana ha un bisogno vitale dopo la catastrofe sperimentata almeno nell’ultimo ventennio.
In secondo luogo, uno dei compiti primari della scuola deve essere a nostro avviso quello di realizzare le condizioni per una minimale eguaglianza di punti di partenza, essenziale sia per mettere ciascuno in grado di usufruire effettivamente dei diritti individuali, delle libertà e delle opportunità di vita proprie di una società aperta, sia per l’efficiente funzionamento di un’economia di mercato fondata sul merito e non sull’appartenenza di casta.
In terzo luogo, la scuola deve essere il luogo dell’integrazione dell’individuo in una società pluralistica, non il luogo del consolidamento di identità comunitaristiche e intolleranti a base etnica, religiosa o politica. La laicità dell’istruzione, l’educazione al rispetto e alla conoscenza delle differenze, sono vitali per non trasformare il pluralismo sociale in settarismo e frantumarlo in separatezze contrapposte. La libertà di insegnamento e la libertà di apprendimento, oltre ogni barriera e steccato ideologico, confessionale o etno-regionalistico, devono essere lo strumento principe della formazione del cittadino in un ambiente aperto al dialogo, al confronto, al libero scambio di opinioni e punti di vista, e alla convivenza fra diversi stili di vita. Non si può educare all’esercizio delle libertà liberali se non in un contesto in cui tali libertà, e le regole necessarie a farle rispettare nei confronti di tutti, siano tangibilmente e visibilmente poste a fondamento della vita della scuola.
In quarto luogo, non va neppure sottovalutato che cosa significherebbe per il futuro delle nostre società pluralistiche il parziale ritorno all’istruzione confessionale, come nell’Italia preunitaria. Quel che viene preteso in Italia dalla Chiesa cattolica non potrà esserle accordato oggi e negato domani alle altre confessioni o comunità religiose, etniche, etno-regionalistiche o settarie, che chiederanno parità di trattamento: finanziare oggi le scuole cattoliche con il denaro di tutti i contribuenti – direttamente o indirettamente, e contro il preciso divieto costituzionale – significa inevitabilmente essere obbligati fra qualche anno a fare altrettanto con le scuole islamiche che saranno pretese proprio da quei genitori più fondamentalisti che vorranno preservare i propri figli dall’integrazione nella nostra società occidentale, secolarizzata e “dissoluta”; o con le scuole “padane” pretese da genitori leghisti.
Infine, in una società liberale sono i diritti e le libertà degli individui che devono essere oggetto di tutela, non quelli del gruppo di appartenenza. Ogni individuo, anche quando non può ancora esercitare appieno i diritti e le libertà di cui è titolare, può e deve essere tutelato nel libero sviluppo della propria personalità individuale. Così come la sua integrità fisica e la sua inviolabilità sessuale, anche lo sviluppo della sua personalità individuale deve essere tutelato dai pubblici poteri: anche, se necessario, a fronte della comunità e della famiglia di origine che intendessero coartarlo. Nel caso poi dei minori «naturalmente capaci di formarsi proprie opinioni», la loro libertà di apprendimento e di pensiero è anche espressamente garantita, oltre che dalla Costituzione, dalla convenzione di New York del 1989 sui diritti dei “fanciulli” (così denominata secondo l’opinabile traduzione italiana), ratificata dall’Italia nel 1991.
Il taglio dei fondi per l’università e per la ricerca scientifica ha comportato, oltre che impoverimento culturale, il venir meno di opportunità di vita essenziali, soprattutto, ma neppure soltanto, per i giovani provenienti da famiglie meno abbienti, e l’irrimediabile accelerazione della fuga in massa dei cervelli, destinata a produrre ancora, e per decenni, una continua retrocessione dell’Italia nella competizione internazionale. Questo è un altro dei terreni su cui un governo di centrosinistra dovrà tornare a investire, anche in presenza della necessità di tagliare complessivamente la spesa pubblica, nella situazione di perdurante emergenza economica in cui il paese continuerà verosimilmente a trovarsi nei prossimi anni.
Altrimenti, anche una volta che fosse superata la contrazione dell’economia occidentale verso cui ci si sta apparentemente avviando, sarà inevitabile ripartire scontando una retrocessione stabile, ancor più duratura e definitiva di quella causata dal crollo della credibilità della classe politica italiana negli ultimi anni.
Ma, anche al di là del problema cruciale del ruolo della ricerca e dell’istruzione, indispensabili per scongiurare un declino altrimenti certo e per assicurare un futuro al paese, quel che va anche ripensato è il rapporto fra formazione e occupazione. Dovrà essere fatto tesoro delle best practices esistenti in Europa nei rapporti fra scuola, Università e mondo del lavoro, come raccomandato da una recente risoluzione del Parlamento europeo. Insistere sul ruolo della scuola e dell’Università come luoghi della formazione del cittadino e della classe dirigente non significa in alcun modo sottovalutare il ruolo determinante che istruzione e ricerca devono avere nel far ripartire lo sviluppo; e ciò richiede una maggiore integrazione fra sistema produttivo, percorsi di formazione, innovazione tecnologica, formazione permanente, mobilità.
Infine, accanto alle spese per formazione e ricerca, l’Italia deve tornare a investire nella conservazione e preservazione dei suoi giacimenti artistici e culturali, che – assieme al patrimonio naturalistico e paesaggistico messo a sacco dai ripetuti condoni e dalla collusione fra politica ed ecomafie – costituiscono il solo asset in cui l’Italia continuerà, non certo per suo merito, a poter vantare un primato mondiale, che solo l’insipienza della politica non ha saputo tramutare in primato dei flussi turistici – da ultimo, con lo scandalo, davvero emblematico del modo in cui è stato sistematicamente dilapidato in questi anni il denaro dei contribuenti, dei costi astronomici e dell’infimo livello del sito italia.it .
Discredito della politica e riforme istituzionali
Il discredito di cui è sempre più oggetto l’attuale ceto politico è stato largamente meritato dalla maggioranza dei suoi attuali componenti. Per troppi anni gran parte della classe politica – e niente affatto soltanto la destra berlusconiana – ha sistematicamente adottato comportamenti sempre più intollerabilmente irrispettosi dei dovuti criteri minimi di decenza, correttezza e trasparenza e sempre più improntati a un disprezzo talvolta perfino ostentato della legalità e del sistema dei freni, controlli e contrappesi costituzionali. Il “successo” di Berlusconi e della sua consorteria ha spinto buona parte del ceto politico a imitarne l’esempio, ad abbassare sistematicamente la soglia di quel che veniva considerato intollerabile perfino al tempo delle inchieste dei primi anni Novanta, che resero evidente a tutti quanto l’illegalità dilagante avesse già superato ogni livello di guardia.
Questo meritato discredito sta ora però portando buona parte dell’opinione pubblica a considerare costo inutile tutto quel che riguarda il funzionamento stesso della democrazia parlamentare: paradossalmente, si tratta proprio della strada indicata da Berlusconi, l’eroe negativo della corsa senza fondo della politica italiana verso malgoverno, corruttela e illegalità dilaganti, che già anni fa proponeva di sostituire al voto dei parlamentari quello dei capigruppo, dotando ciascuno di loro di un voto ponderato pari alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari. Paradossalmente, la polemica sui costi della politica e sui privilegi della “casta” finisce spesso, inavvertitamente, per accreditare quella visione delle cose, e la sacrosanta polemica contro gli abusi dell’attuale classe politica tende a sovrapporsi sempre più alla discussione sulle riforme istituzionali, conglobandola e finendo per assorbirla.
Sarebbe ingenuo pretendere che i due argomenti fossero tenuti astrattamente separati, ma non può fare di ogni erba un fascio chi si proponga l’obiettivo di un Nuovo Risorgimento, di una ricostruzione della democrazia italiana che miri a riconferire alla politica il suo ruolo e la sua necessaria serietà e nobiltà.
Fermo restando quanto già si è detto a proposito del bisogno di un ampio concorso di consensi per ogni futura riforma costituzionale, non c’è dubbio che vi siano costi superflui – o comunque ingiustificabili in rapporto ai benefici – direttamente derivanti da strutture del sistema politico la cui esistenza è superata o priva di giustificazioni.
È certamente il caso delle amministrazioni provinciali, cioè di un intero livello di governo territoriale che potrebbe essere interamente soppresso – con tutte le relative strutture, consigli, giunte, assessori, presidenti, gabinetti, sedi relative, centralini, consulenti, attendenti, addetti stampa, auto blu, ecc. ecc. – senza con ciò depauperare significativamente la democrazia italiana. È certamente il caso dei Comuni di dimensioni ridotte, che potrebbero anch’essi essere utilmente accorpati, anche oltre quanto stabilito con la recente manovra di emergenza. È certamente il caso del Cnel, residuo di un’idea di rappresentanza corporativa anziché politica, estranea alla democrazia liberale.
Altrettanto ingiustificabile è la selva di privilegi feudali di parlamentari, ministri e rappresentanti politici ad ogni livello, cresciuta metastaticamente nel corso dei decenni. A tacere degli scandali e dei veri e propri reati commessi con l’uso e l’abuso dei voli militari o “di Stato”, non c’è alcuna ragione per mettere un’auto blu con autista a disposizione personale e permanente di un uomo politico: usare abitualmente i taxi non è disdicevole, così come sarebbe logico ricorrere a servizi pubblici di noleggio nelle singole occasioni in cui ciò sia realmente necessario per ragioni di rappresentanza. Le sole autovetture stabilmente indispensabili dovrebbero essere quelle blindate, quando necessarie alla protezione di personalità – si tratti o meno di uomini politici – oggetto di effettivi rischi di attentati.
Lo stesso, ovviamente, dovrebbe valere per mense, barbieri, palestre, cappelle, e consimili micragnosi privilegi, che non si vede perché debbano essere posti a carico dei contribuenti, al di là e oltre alle retribuzioni riconosciute agli uomini politici. Il loro costo incide proporzionalmente pochissimo sulla spesa pubblica complessiva, ma essi sono comprensibilmente ragione di pubblico scandalo, soprattutto nel momento in cui la classe politica è costretta a chiedere sacrifici ai contribuenti, anche per avere per anni, nella sua maggioranza, sperperato il loro denaro.
Il guaio è che il discredito che gran parte della classe politica italiana si è ben meritata in questi anni rischia di convertirsi nell’idea, largamente diffusa e per nulla contrastata, secondo cui l’attività politica, essendosi squalificata, merita di essere riconosciuta come un’attività strutturalmente dequalificata e disprezzabile: un po’ com’è accaduto agli insegnanti, con il trionfo di populismo diffuso e analfabetismo autocompiaciuto; e con il rischio di promuovere, come nel caso degli insegnanti, una selezione a rovescio della classe politica futura. Fenomeno del resto già ben visibile soprattutto nelle nuove generazioni, dove i pochi disposti a dedicarsi all’attività politica si dividono in due ben distinguibili categorie: una minoritaria, di persone ancora capaci di appassionarsi alla politica e spesso nettamente più colte della media, e una, purtroppo apparentemente maggioritaria, di sprovveduti che vedono nella politica l’opportunità di dedicarsi a una carriera che promette lauti guadagli illegali e che non richiede alcuna qualificazione specifica.
Bisognerebbe che qualcuno trovasse il coraggio di riaffermare con forza il ruolo e la nobiltà della politica democratica, anche se ciò sembra in controtendenza rispetto a sviluppi non solo italiani. Ma ne va del ruolo della democrazia liberale nel mondo globale.
Bisognerebbe avere perfino il coraggio di dire che un parlamentare – così come il Sindaco di un grande Comune, che ha responsabilità personali anche maggiori, per non dire un ministro – svolge una funzione non meno delicata e non meno impegnativa di quelle che si affidano a professionisti affermati. E che nessuna democrazia si può permettere il lusso di fare a meno di una classe politica professionale, di screditare sistematicamente l’attività politica considerandola naturale e scontato appannaggio di disonesti e profittatori; e, come ovvia conseguenza, di attribuirle alla fine sia retribuzioni magari più alte della media ma lontane da quelle di altre attività professionali di simile rilievo, sia pesanti svantaggi reputazionali: pena l’ulteriore depauperamento della qualità media della classe politica. Fenomeno cui effettivamente si assiste, su entrambe le sponde dell’Atlantico, con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
Ma soprattutto non si può, in nome del necessario contenimento dei costi della politica o della giusta indignazione per corruzione ed abusi, accettare che, con toni e argomenti non di rado sinistramente simili a quelli diffusi in Europa negli anni Dieci del Novecento, la democrazia rappresentativa in sé venga sistematicamente denigrata nel chiacchiericcio pubblico corrente, assimilando le ruberie alle retribuzioni, queste ai grotteschi privilegi castali, i privilegi alle offerte commerciali che i parlamentari ricevono da aziende private semplicemente perché essi rientrano nei loro target; e tutto ciò con il finanziamento dei partiti – e anche qui senza distinzioni: in denaro o in servizi, o camuffato da “rimborso”, pubblico e privato, di sostenitori individuali o di lobbies criminali, legale o frutto di illeciti, o di delitti magari gravissimi.
Non si può neppure fingere di non sapere che lo spreco, la dissipazione e l’illecito sono da ricercare non solo, e neppure tanto, in Parlamento. Caso mai, già di più nelle assai meno monitorate amministrazioni regionali, nelle cui mani tutt’altro che mediamente pulite e affidabili rischia di finire un’ulteriore consistente fetta della spesa pubblica. Ma, fra parlamentari e consiglieri regionali, si parla comunque in tutto di meno di duemila persone, e pur sempre, bene o male, di eletti.
Il vero scandalo del costo astronomico e parassitario della politica italiana sta invece nelle centinaia di migliaia di faccendieri, attendenti, uomini di fiducia, politicanti trombati, incaricati di consulenze spesso fasulle, infrattati, in modo invisibile e inestirpabile – e con stipendi e fringe benefits talvolta ben maggiori di quelli dei parlamentari – in consigli di amministrazione, enti, consorzi, società miste, fondazioni, finto “no profit”, confraternite, che inquinano i rapporti fra politica ed economia favorendone intrecci perversi e che costituiscono la parte largamente preponderante, e scandalosa, dei costi e del finanziamento occulto della politica. E sta, anche, nei contributi pubblici all’editoria parassitaria asservita o sfruttatrice della politica.
Peggio ancora se, prendendo a pretesto i costi eccessivi della politica, anziché dedicarsi alla doverosa opera di sistematico disboscamento del sommerso e dell’occulto, ci si volesse davvero sbizzarrire a mettere mano a inconsulte riforme costituzionali al vertice del sistema.
Se il bicameralismo puro è certamente indifendibile, differenziare le funzioni fra le Camere per giustificare la sopravvivenza di entrambe, riducendo il Senato a mero terreno di lotta per la spartizione territoriale delle risorse sulla base di alleanze partitiche e di rapporti di forza numerici sarebbe un rimedio molto peggiore del male (se non per le fortune della Lega Nord e di future Leghe Sud), così come sottrarre a una delle due Camere i poteri ispettivi – prevedibilmente proprio a quella in cui le minoranze politiche sono maggiormente rappresentate. Così come sarebbe rimedio peggiore del male, per ridurre i costi, “dimezzare” i membri, dimezzando così anche il numero dei potenziali controllori e soprattutto di quelli appartenenti alle minoranze, mantenendo però il bicameralismo a vantaggio dell’oligopolio dei partiti superstiti, quelli maggiori e maggiormente responsabili del disastro italiano, e dei loro capibastone, veri beneficiari dell’epurazione, ma perfino capaci, con questa operazione, di atteggiarsi a moralizzatori.
Meglio, molto meglio di tutto questo, pensare piuttosto allora a una più lineare transizione al monocameralismo, soluzione, tra l’altro, anche molto più efficace perfino in termini di risparmio economico, tenuto conto del costo della complessa organizzazione, spesso caratterizzata da una gestione a dir poco allegra, e dell’entità del patrimonio immobiliare di altissimo pregio di ciascuna Camera, ben più rilevante del costo delle retribuzioni e degli stessi privilegi dei loro membri. Le esigenze di necessaria ponderazione dell’attività parlamentare potrebbero essere salvaguardate anche con una sola Camera, attraverso la previsione di doppi passaggi e seconde letture se richiesti da minoranze qualificate, ma senza con ciò depauperare la democrazia per risparmiare sui suoi costi.
Con l’eccezione di quelle cui si è già accennato all’inizio, rivolte ad adeguare i quorum costituzionali all’avvenuto mutamento delle leggi elettorali, tutte le altre riforme costituzionali sono comunque a nostro avviso ben lungi dal costituire una priorità, perché il sistema costituzionale è ben lontano dall’essere stato una delle cause del degrado italiano. Semmai, ha avuto il merito di farci evitare il peggio. Poiché però da anni si aggirano attorno alla Costituzione torme di apprendisti stregoni, che il più delle volte non sanno neppure di che cosa stanno parlando, ma ciascuno entusiasta delle proprie cervellotiche ricette, ci preme sottolineare in particolare la nostra assoluta contrarietà a qualunque modifica della composizione della Corte costituzionale, che, con la scusa di adeguarla all’avvenuta riforma “federalista” della forma di Stato, avesse come conseguenza quella di aumentare il numero dei giudici di diretta nomina politico-partitica, conferendo alla fine alla maggioranza parlamentare il potere di nominare direttamente la maggioranza dei membri della Corte: sbarazzandosi così di ogni controllo sulla costituzionalità delle leggi, svuotando la Corte del ruolo di organo di garanzia e rendendola nella sostanza nient’altro che una cinghia di trasmissione delle segreterie dei partiti maggiori.
La giustizia: uguaglianza di fronte alla legge, garantismo, certezza del diritto
Quanto più sono indiscriminate, tanto più le polemiche sui costi della democrazia fanno anche facilmente dimenticare che i costi della politica sono soprattutto i costi dell’illegalità e dei reati commessi o coperti da molti uomini politici. Assieme alla criminalità organizzata e alla lentezza della giustizia (della giustizia civile e di quella amministrativa, oltre che di quella penale), l’incertezza del diritto, la corruzione e la criminalità legate alla politica sono uno dei freni maggiori anche allo sviluppo economico e civile dell’Italia, e non più soltanto nelle zone di tradizionale insediamento mafioso.
Vent’anni fa, in un paese che scopriva con stupore e costernazione quanto il livello e il peso della corruzione politica fossero estesi, profondi e pervasivi oltre ogni immaginazione, poteva essere comprensibile la tentazione di apparirne i più rigidi fustigatori facendo passare in secondo piano molte preoccupazioni garantiste proprie della tradizione politica e giuridica liberale. Oggi, quando la profondità del degrado è purtroppo sotto gli occhi di tutti, per distinguersi di fronte al conclamato e non più occultabile pervertimento della vita politica operato dalla coalizione berlusconiana, e di fronte al contagio del berlusconismo che ha profondamente coinvolto parte dell’opposizione, operare concretamente in una nuova prossima maggioranza parlamentare perché i governanti, ad ogni livello, non vengano sottratti alla normale applicazione della legge penale è largamente sufficiente da sé a far risaltare il carattere differente di una forza politica liberale determinata a far uscire definitivamente il paese dagli anni di fango. Fare la faccia feroce non serve neppure più. Serve abrogare le leggi-vergogna.
Se chi vuole che la giustizia penale sia applicata anche quando a delinquere sono i governanti viene tacciato di “giustizialismo” dal Newspeak berlusconiano, non c’è che da rispondere che, se tale ne è la definizione, allora i liberali sono sempre stati “giustizialisti”. E se il Newspeak pretende di definire “comunista” chi non crede alla favola dell’ingiusta persecuzione politica di Berlusconi e dei suoi da parte di una magistratura anch’essa tutta o quasi “comunista”, non c’è che da rispondere che l’uguaglianza formale dei cittadini, l’isonomìa, altro non è che uno dei principali contributi recati dall’Occidente liberale alla civiltà universale. Quando invece erano proprio i comunisti – quelli veri, quelli di epoca staliniana – a volere il potere giudiziario sottoposto a quello politico, più o meno con gli stessi argomenti e le stesse parole usati oggi da Berlusconi e dai suoi seguaci.
Così l’Italia è diventata il solo paese al mondo in cui pretendere che la giustizia penale si applichi anche ai governanti determina una collocazione piuttosto che un’altra nel sistema politico e sul continuum destra/sinistra.
I liberali sono, piuttosto, fautori di un diritto penale minimo. Preferiscono riservare le sanzioni penali a comportamenti ritenuti irreparabilmente gravi, in linea generale e stabilmente nel tempo, dalla generalità dei consociati, e non semplicemente causa di paure irrazionali fomentate da politicanti populisti alla vigilia delle elezioni: quel che è oggetto di sanzione penale deve essere limitato e chiarissimo a tutti. I liberali sono contrari a sanzioni penali che mirino a difendere gli individui contro se stessi in nome di una morale di Stato resa obbligatoria per tutti. E inoltre, i liberali sono anche tendenzialmente sostenitori di sanzioni miti, possibilmente diverse dal carcere, convinti che la terribilità delle pene, oltre ad essere eticamente deprecabile, serva soltanto a rafforzare la propensione a delinquere dei condannati. Il carcere, quanto più è afflittivo, tanto più facilmente si tramuta in università del crimine. Un sistema penale feroce non allevia ma aggrava i costi sociali della criminalità.
Investire nell’efficienza e nella celerità della giustizia penale, civile, amministrativa e contabile, imporre una piena informatizzazione delle procedure, capace di coniugare garantismo ed efficienza, non accettare che l’esecutivo possa in alcun modo interferire nell’esercizio dell’azione penale sono tutte parti di una politica del diritto non “giustizialista”, ma liberale e garantista.
Garantista, in particolare, o comunque ben più garantista di qualunque direttiva emanante dal potere politico, riteniamo sia il mantenimento dell’obbligatorietà dell’azione penale: è ovvio che non tutti i reati potranno mai essere perseguiti di fatto con la stessa priorità, ma se i criteri di priorità fossero stabiliti dalla politica e noti in anticipo, chi intendesse commettere i delitti la cui repressione non fosse considerata prioritaria dal potere politico di turno saprebbe in anticipo di poter impunemente delinquere. Ed è fin troppo evidente che la priorità nell’Italia di oggi non sarebbero i corruttori e i ladri di Stato.
Anche leggi di riforma astrattamente condivisibili in tempi nomali acquistano un significato diverso in relazione ai contesti storici e politici in cui vengono decise. In tempi normali, in un paese normale, i liberali possono certamente ritenere che la responsabilità del magistrato per colpa grave meriti di essere considerata alla stessa stregua di quella di chi eserciti altre alte competenze professionali, e che prevedere che altri giudici possano essere chiamati ad accertare tale responsabilità sia elemento tutt’altro che distorsivo di un complessivo sistema di freni e contrappesi istituzionali. Ma è evidente che, dopo il diciottennio berlusconiano, l’introduzione di norme del genere, a differenza di venti o trent’anni fa, non potrebbe che avere il significato di un regolamento dei conti fra magistratura e potere politico, fra guardie e ladri, in favore dei ladri. Semmai, ben maggiori dovrebbero essere i risarcimenti da prevedere per le vittime degli errori giudiziari. E, se possibile, ancor maggiori quelli da riservare ai testimoni di giustizia costretti talvolta a cambiar vita e cui la Repubblica riserva oggi un trattamento il più delle volte ignobile.
Oltre che con maggiori risorse finanziarie e umane e con un maggiore impiego di tecnologia, l’intasamento della giustizia penale e il sovraffollamento delle carceri deve essere affrontato non con il colpo di spugna di una nuova amnistia, destinata, a normativa vigente, a produrre effetti solo nel brevissimo termine, e soprattutto a farla fare franca ai ladri e ai corruttori di Stato, ma con decise scelte di depenalizzazione permanente. In particolare, sono la massima estensione delle misure alternative e la depenalizzazione di intere categorie di reati la via maestra per ridurre stabilmente il sovraffollamento delle carceri italiane, dove oggi i detenuti usufruiscono di spazi vitali e condizioni di vita peggiori di quelli che la normativa europea impone per il benessere di suini e bovini negli allevamenti intensivi.
Prevedere sanzioni penali per ostacolare l’immigrazione clandestina è stata una scelta non solo spregevole, ma scellerata, perché – assieme alla proposta suicida di ridimensionare la portata degli accordi di Schengen – si tratta del modo migliore per ostacolare l’integrazione e produrre artificialmente delinquenza futura, inviando in carcere, cioè all’università del crimine, migliaia di giovani stranieri che, se prima intendevano soltanto attraversare l’Italia per cercare lavoro altrove, scontata la pena considereranno l’Italia ovvia terra di elezione di future imprese criminali, sia per sfogare il rancore per l’ingiusta detenzione, sia perché nel frattempo avranno imparato l’italiano meglio di ogni altra lingua comunitaria. Per la destra populista si è trattato di un investimento sul futuro, dato che l’aumento della delinquenza futura ad opera di stranieri, generata dall’introduzione del reato di immigrazione clandestina, le consentirà sempre nuove campagne demagogiche e fomenterà sempre nuovo razzismo e nuova xenofobia.
L’esibita e indiscriminata violenza – ideologica, burocratica, spesso fisica – che la destra populista ama mostrare nei confronti degli stranieri e che è sfociata nella criminalizzazione sommaria e nella previsione della detenzione dei sans papiers senza processo e senza accuse fino a un anno e mezzo in strutture perfino più invivibili e meno trasparenti delle carceri ordinarie, non è stata capace di ridurre gli ingressi clandestini, ma i media asserviti si stanno ben guardando dal fare dell’arrivo di ogni nuovo barcone la notizia di apertura, come sempre avveniva ai tempi del governo Prodi.
Questa violenza razzista non è che un aspetto di una più generale concezione autoritaria e violenta dei rapporti fra potere politico e individui, che ha toccato il suo apice più vergognoso nella “notte cilena” del barbaro assalto alla scuola Diaz in occasione del G8 di Genova del 2001. Si tratta di un aspetto sinistro e ricorrente dell’autobiografia della nazione. Un partito liberale dovrebbe prendere molto sul serio queste cicliche degenerazioni storiche, soprattutto in un periodo in cui la crisi economica rischia di inaugurare una stagione di intenso disagio sociale e di frequenti proteste di piazza. Anche per non fornire pretesti al rischio di un possibile ritorno a nuovi “anni di piombo”, sarebbe bene mettere molto tempestivamente allo studio nuove tecniche di gestione nonviolenta dell’ordine pubblico, confrontandosi con tutte le esperienze internazionali esistenti in materia.
A nostro avviso è ormai anche ampiamente tempo di prendere atto del fallimento evidente di quarant’anni di politiche internazionali proibizionistiche, che non solo, esattamente come il proibizionismo americano sugli alcolici negli anni Venti, hanno prodotto l’esplosione dell’offerta di droga e il dilagare del consumo incontrollato e incontrollabile di ogni tipo di sostanza nelle peggiori condizioni igieniche e sanitarie, ma che, più ancora, costituiscono un essenziale sostegno paradossalmente fornito dagli Stati alla crescita della potenza finanziaria, economica e politica della criminalità organizzata. Bisogna scegliere (anche se si tratta di una scelta impraticabile da un singolo Stato, e possibile solo a livello internazionale): politiche proibizioniste e lotta alle mafie si sono dimostrate priorità fra loro non compatibili.
Laicità e diritti civili
Come ampiamente documentato dal rapporto annuale sulla secolarizzazione della società italiana condotto congiuntamente dalla fondazione Critica liberale e dal settore Nuovi Diritti della Cgil nazionale, e a dispetto della corrente rappresentazione politico-mediatica che ne viene data, l’Italia è ogni anno più secolarizzata, nei comportamenti concreti dei suoi cittadini, anche rispetto all’epoca delle grandi battaglie laiche degli anni Settanta che portarono ai risultati positivi dei referendum sulle leggi sul divorzio e sull’aborto.
A loro volta, sondaggi e inchieste ricorrenti dimostrano che le preferenze elettorali dei cattolici si spalmano sull’intero continuum destra /sinistra, come è logico che sia, dato che alcuni dei temi cari a quella che è, da molti anni, la minoranza dei cattolici praticanti sono privilegiati dall’impostazione clericale, oscurantista e autoritaria imposta al proprio schieramento da Berlusconi, mentre altri sono più omogenei all’atteggiamento solidaristico, “buonista” o terzomondista di parte della sinistra.
Se le elezioni si vincono conquistando l’elettorato incerto, che oscilla fra i due schieramenti, quel che è certo è che tale elettorato non coincide per nulla con un presunto elettorato “cattolico”, che, come tale, non esiste più da quando è scomparsa la Dc (il cui elettorato moderato non era peraltro interamente composto da cattolici praticanti, e tanto meno da cattolici tutti integralisti). Non ha quindi alcun senso per il centrosinistra voler competere solo per acquisire l’elettorato integralista, come se l’elettorato laico, che certo è meno visibile perché non organizzato, fosse meno vasto, oppure da ritenere sempre e comunque acquisito in partenza al centrosinistra. Le elezioni si vincono sì conquistando il voto degli incerti, ma anche, ed è sempre meno scontato, convincendo a recarsi alle urne un elettorato laico che in questi anni ha accumulato mille ragioni per essere tentato di restarsene a casa.
Con un Pd largamente paralizzato su questi temi dalle divisioni interne – ed erede del resto di due partiti, l’uno prevalentemente ostile e l’altro al massimo tiepido, sulla difesa della laicità delle istituzioni – è compito di una forza politica liberale occupare le vaste pianure disertate in cui abita un diffuso elettorato laico, che è ben lontano dal volersi far rappresentare soltanto dalla sinistra estremista o massimalista, o dall’imprevedibilità, congenita su altre questioni, del Partito radicale.
Non è possibile operare per una modernizzazione economica e sociale del paese e volerlo mantenere al tempo stesso in uno stato di arretratezza e minorità civile. Come ha mostrato l’economista Richard Florida, i picchi di sviluppo economico si registrano nei luoghi del mondo che sono al vertice anche in fatto di tolleranza, modernità civile e rispetto per il pluralismo. “Umiliare la laicità” – per usare uno slogan adottato anni fa dalla Federazione della Chiese Evangeliche per celebrare l’annuale settimana della libertà – significa umiliare e calpestare non solo alcuni diritti e libertà ben concreti, ma anche la pari dignità sociale dei cittadini. In una società sempre più multireligiosa, come lo sono tutte le società europee, significa anche creare le premesse per una disgregazione etnico-religiosa e comunitaristica che è il contrario dell’integrazione: sia nel caso che si continui a privilegiare soltanto la confessione tradizionalmente maggioritaria a discapito dei non credenti e delle minoranze religiose, sia nel caso – cui alla lunga non sarà possibile sottrarsi – di estendere privilegi e sostegni economici anche alle altre confessioni in più rapida crescita, a danno di tutti i contribuenti, credenti o non credenti che siano.
Il “principio supremo” della laicità – secondo lo status attribuitogli dalla Corte costituzionale – va affermato nel suo solo possibile significato concreto, realizzando cioè il massimo grado possibile di neutralità religiosa delle istituzioni pubbliche, il cui solo obbligo in questo campo è quello di garantire a ciascuno la più ampia libertà nell’ambito delle regole comuni della convivenza costituzionale.
Si è già accennato alla laicità della scuola e agli ingiustificabili privilegi fiscali attribuiti alle attività commerciali della Chiesa cattolica, al perverso meccanismo che presiede alla spartizione della quota inoptata dell’otto per mille. A questo va aggiunto lo scandalo dell’attribuzione a enti ecclesiastici, stabilita da Berlusconi con suoi decreti, perfino della quota dell’otto per mille espressamente conferita dai contribuenti allo Stato anziché alle chiese. Negli anni di fango, il denaro dei contribuenti e le libertà dei cittadini sono stati il prezzo pagato da Berlusconi per ottenere l’indulgenza delle gerarchie cattoliche per la sua condotta privata e perfino per le sue occasionali bestemmie “scherzose”.
Ma sono tutti i diritti e le libertà che sono stati conculcati negli anni di fango a dovere essere riconosciuti ormai anche in Italia, come lo sono da anni in tutti gli altri paesi dell’Europa occidentale e non solo.
Una forza politica liberale dovrà battersi per il riconoscimento delle libertà e dei diritti, e la rimozione dei capricciosi divieti, che la maggioranza uscente ha imposto agli italiani.
Non è tollerabile che su ogni questione etica “controversa” il solo parere diffuso dalla televisione pubblica (e divulgato da gran parte dei media) sia quello vaticano e che si censurino sistematicamente gli argomenti e la voce dei bioeticisti laici. Non sono tollerabili lo stupro obbligatorio, e la tortura di massa, promessi a tutti gli italiani non più capaci di far valere espressamente la propria volontà con la legge che disconosce il valore del testamento biologico, soprattutto in un paese in cui la larga maggioranza della popolazione è invece da anni stabilmente favorevole perfino alla depenalizzazione dell’eutanasia volontaria. Non è tollerabile che siano ancora in discussione la messa in commercio e l’utilizzo da parte di medici e pazienti della pillola abortiva RU386, approvata e in uso da anni in quasi tutti i paesi europei, o che addirittura non siano ovunque disponibili i contraccettivi di emergenza post-coitali, che altrove si acquistano senza prescrizione medica. Non è tollerabile il boicottaggio della legge sull’aborto in intere regioni, a partire dalla Lombardia. Non è tollerabile che gli italiani siano obbligati a ricorrere all’estero all’inseminazione artificiale. Non è tollerabile che la ricerca scientifica sia limitata dai diktat delle autorità religiose cattoliche e che la ricerca scientifica sia messa nelle mani di esponenti politici orgogliosamente oscurantisti. Non è tollerabile che gli hate crimes commessi contro gli omosessuali, e solo contro di loro, non siano puniti anche come tali e che non sia prevista anche per le minoranze sessuali alcuna organica normativa antidiscriminatoria. Non è tollerabile che l’Italia sia il solo paese dell’Europa occidentale a non riconoscere alle coppie gay il diritto di sposarsi o comunque di poter regolare i loro propri rapporti giuridici e patrimoniali come tutte le altre coppie hanno il diritto di fare, e, addirittura, nemmeno l’accesso a un riconoscimento giuridico minore come il “pacs” francese; e nessun valore alle convivenze di fatto, eterosessuali o omosessuali che siano, neppure se di durata pluridecennale. Non è tollerabile che non si sia ancora risolto decentemente e ovunque il problema dell’ora alternativa a quella di religione cattolica nella scuola pubblica. Non è tollerabile che in molti Comuni ai funerali laici non siano assicurate condizioni minime di decenza.
E fa specie, nel centocinquantenario dell’Unità, che una paccottiglia pubblicistica antirisorgimentale e sanfedista spesso di infimo livello venga foraggiata con il denaro dei contribuenti, o che, per il governo della Repubblica, e senza scandalo per gran parte dell’opposizione, la nascita della Repubblica e la Liberazione dalla dittatura siano ricorrenze meno meritevoli di essere degnamente celebrate dell’Epifania, dell’Immacolata Concezione o delle feste dei patroni municipali e rionali.
Immigrazione e politiche di integrazione
La questione dell’immigrazione è servita, ovunque in Europa, da terreno di cultura della demagogia populista e la coalizione berlusconiana ne ha fatto ampio uso elettorale in Italia.
Ma, in Italia più che altrove, il dibattito si è anche polarizzato fra due posizione contrapposte, l’una disposta a cavalcare, e spesso a promuovere senza vergogna, pulsioni e atteggiamenti apertamente razzisti; l’altra, anche per comprensibile ma ingenua reazione, schierata su posizioni acriticamente entusiaste della contaminazione con ogni “cultura altra” che non fosse occidentale, e preoccupata di rimuovere o nascondere i problemi che pure esistono, all’insegna di quello che è stato definito dai primi “buonismo”: questa parte della società italiana vede nel multiculturalismo in senso forte l’ultima espressione possibile dell’antica diffidenza verso le aspirazioni universalistiche della democrazia liberale, individualistica e laica di matrice occidentale.
Entrambe queste posizioni sono rigorosamente refrattarie a far tesoro dell’esperienza dei paesi europei che hanno preceduto l’Italia come terre di immigrazione: ed entrambe sono destinate quindi a ripeterne l’una gli orrori e l’altra gli errori, reciprocamente alimentandosi.
Noi crediamo che una forza politica liberale e laica possa fornire un proprio specifico contributo, capace di rigettare e combattere con il massimo rigore ogni atteggiamento razzista e xenofobo, e di far valere al tempo stesso con determinazione le ragioni e i valori di fondo di una convivenza rispettosa delle regole costituzionali e dei principi universalistici propri della democrazia laica e liberale.
Trattare gli elettori da adulti anziché da bambini irresponsabili significa anche dire loro chiaramente che un’Italia e un’Europa, aperte all’economia del mondo contemporaneo e in sicuro declino demografico nei prossimi decenni, non solo non possono fare a meno, ma hanno l’assoluta e crescente necessità economica di una importante presenza di manodopera extracomunitaria, se, anche una volta superata la lunga crisi globale, vorranno difendere la propria prosperità, garantire lo sviluppo ed evitare il collasso del welfare e di ogni rete di protezione sociale.
Educare alla convivenza e combattere razzismo e xenofobia non è soltanto un obbligo etico-politico incondizionato per una democrazia liberale, è ormai anche condizione di sopravvivenza. La più rigorosa repressione di hate crimes, discriminazioni e diffamazioni a carattere razzista è un obbligo morale, ma è anche la condizione necessaria per non ritrovarsi prima di quel che si pensi di fronte a conflitti comunitari capaci di produrre una rapida degenerazione della sicurezza pubblica, a tutto vantaggio della demagogia populista e razzista. Favorire i ricongiungimenti familiari giova al pacifico e virtuoso inserimento degli immigrati nella vita sociale e produttiva dell’Europa: immigrati responsabili delle loro famiglie sono certamente meno propensi a cedere alla tentazione di comportamenti asociali di quelli isolati e sradicati.
Va anche subito detto che tutelare dalla diffamazione i gruppi minoritari non significa affatto accettare che la libertà di espressione, anche in materia di religione, possa essere limitata per rispetto dei sentimenti religiosi, degli autoctoni o dei nuovi residenti: deve essere ben chiaro a tutti che l’Europa non tornerà mai più a censurare Voltaire.
Per i liberali ogni individuo è prima di tutto un individuo. Lo è prima di ogni sua possibile origine o pretesa “appartenenza” etnica o religiosa. Per questo i liberali devono decisamente optare per politiche di integrazione degli individui, anziché mirare a inglobare in blocco comunità destinate a rimanere estranee l’una all’altra o al più disponibili, un po’ come in Libano o in Bosnia, a una precaria convivenza se e finché non siano in grado di tentare di sopraffarsi a vicenda.
È purtroppo il contrario di quel che sta accadendo oggi in Italia, perché, in assenza di scelte responsabili della politica, il modello di inserimento spontaneo per qualunque gruppo di immigrati è sempre quello comunitaristico. Cioè quello che, nel resto d’Europa, dove si è affermato per scelta o per omissione della politica, ha prodotto il massimo di separatezza etnica, e spesso etnico-confessionale, ed è stato il terreno di coltura di fondamentalismi totalitari.
Finora, in Italia, il “dialogo interreligioso” è stato spesso presentato dalla politica e dai media come il surrogato di politiche di integrazione inesistenti. Ciò ha tra l’altro comportato l’ascrizione sommaria di tutti gli immigrati provenienti da paesi di una determinata tradizione religiosa all’“appartenenza” implicita, e implicitamente coatta, a quella tradizione religiosa.
Questo atteggiamento, al fondo razzista, ha di fatto accomunato razzisti e “buonisti”, uniti entrambi dal desiderio di vedere gli immigrati e le loro famiglie come appartenenti a gruppi compatti, omogenei e soprattutto il più possibile “esotici”. Ne hanno fatto le spese soprattutto i non pochi immigrati che sono approdati in Europa non solo in cerca di migliori condizioni economiche, ma anche perché attratti da un sistema di rapporti civili e sociali più libero e meno autoritario di quelli di provenienza. Sono proprio questi immigrati, proprio quelli maggiormente propensi e potenzialmente integrabili con più successo nella società europea, le prime vittime di una politica dell’immigrazione che fa di ogni erba un fascio e che vede in ogni immigrato un “appartenente” obbligato a comunità etniche o religiose il più possibile esotiche e “altre”. Più ancora, di questa politica, o di questa assenza di politica, fanno le spese le minoranze interne alle minoranze: innanzitutto le donne, i minori e gli omosessuali, e più in generale gli immigrati più secolarizzati, occidentalisti e modernizzanti.
Una politica liberale dell’immigrazione dovrebbe innanzitutto trattare ogni immigrato come un individuo, senza permettersi arbitrarie illazioni sulla sua cultura e sulle sue opinioni religiose, senza permettersi di dedurle dalla provenienza geografica, e senza proporre ossessivamente come moralmente dovuto, o eticamente più lodevole e desiderabile, il mantenimento di un rapporto obbligato con le “radici” della sua tradizione di provenienza. Ad essere obbligati a rimanere attaccati alle radici per poter sopravvivere sono i vegetali, non gli esseri umani. E la libertà religiosa non è soltanto la libertà di praticare la religione degli avi, ma è anche la libertà di cambiarla, o di abbandonare semplicemente qualunque pratica o credenza religiosa, o qualunque precedente stile di vita, o tradizione ideologica, intrinseca o meno che sia alla propria cultura di origine.
Una politica liberale dell’immigrazione dovrebbe poi favorire, anziché ostacolare come ora, percorsi individuali di accesso pieno alla cittadinanza, sulla base di un’adesione volontaria e individuale al patto costituzionale, piuttosto che attribuire a tutti indiscriminatamente – anche a chi non ha nessuna intenzione di radicarsi qui – soltanto diritti di cittadinanza ed elettorali dimidiati: se si tratta di affermare il principio no taxation without representation, non c’è alcuna ragione perché esso debba valere sono nelle elezioni amministrative, così come d’altra parte non c’è alcuna ragione di attribuire diritti elettorali, neppure alle elezioni amministrative, chi non intenda esprimere ufficialmente e formalmente la propria individuale volontà di aderire alle regole, ai diritti e ai doveri della cittadinanza europea.
Al tempo stesso, una società liberale non può tollerare sul proprio territorio, neppure all’interno delle comunità e famiglie di stranieri, violazioni dei diritti degli individui che ne fanno parte, o considerarli con indulgenza in nome del rispetto dell’alterità culturale. Donne, minori e omosessuali stranieri hanno lo stesso titolo dei cittadini comunitari alla protezione dei loro diritti, della loro integrità fisica e morale, della loro autodeterminazione, del libero sviluppo della loro personalità individuale, anche di fronte e contro a condizionamenti o tentativi di coartazione da parte delle loro famiglie e comunità. Non può esservi la minima tolleranza per alcuna limitazione dei diritti delle donne, per alcuna imposizione di carattere religioso nei confronti dei minori «naturalmente capaci» di opinioni proprie (secondo la già citata convenzione di New York), per alcuna discriminazione o intimidazione nei confronti degli omosessuali. Non può esservi, in nome del rispetto per l’alterità culturale, la minima tolleranza per l’abuso di mezzi di correzione, per l’imposizione di simboli e pratiche religiose, per i matrimoni forzati, per mutilazioni sessuali neppure “simboliche”.
In una società secolarizzata e laica le pratiche religiose non possono essere mai causa di discriminazione, ma non possono neppure giustificare la violazione dei principi della convivenza costituzionale. La proibizione del velo integrale in pubblico non può essere motivata con ragioni religiose o perché richiesta dal riguardo per la cultura degli europei nativi, ma solo perché – come nel caso del casco integrale dei motociclisti – impedisce la riconoscibilità della persona e dunque l’imputazione alla stessa degli atti di cui si rende responsabile. E la stessa legge francese sul divieto generale del velo nelle scuole secondarie – per quanto la questione sia davvero delicatissima – è giustificabile non in quanto miri a limitare la libertà religiosa, ma a garantire il libero sviluppo della personalità individuale, coartato da una pratica familiare e comunitaristica che, imposta a partire dall’età di circa dodici anni, è altrimenti destinata a tradursi in un condizionamento permanente e a ostacolare scelte consapevoli in una fase più matura della vita.
E, così come non sarebbe oggi permessa nelle nostre città la costruzione di chiese cattoliche che fossero la copia falsa e artefatta di chiese paleocristiane, romaniche, gotiche o barocche, non c’è ragione perché il diritto, che deve essere difeso rigorosamente e senza tentennamenti, alla costruzione di luoghi di culto musulmani o di altre religioni, debba essere svincolato dall’onere di seguire prescrizioni urbanistiche e edilizie che ne favoriscano la piena integrazione anche estetica nel tessuto urbano delle città europee.
Purtroppo non possiamo nasconderci che molti di questi temi sono spesso usati – certo con toni molto differenti dai nostri e con intenzioni opposte – come pretesto e come copertura di atteggiamenti xenofobi e razzisti da parte di gruppi e uomini politici che della laicità delle nostre istituzioni hanno fatto sistematicamente strame in questi anni. Ma una politica di lotta rigorosa contro ogni forma di razzismo e di xenofobia, che miri a far comprendere a tutti il valore e i benefici, oltre che la necessità, di una ragionevole e generosa politica di apertura, non può che trarre giovamento dalle prese di posizione più inequivoche e intransigenti su questi argomenti.
Società pluralistiche e multireligiose come lo sono oggi tutte le società europee hanno più, e non meno, bisogno che nel passato di istituzioni pubbliche laiche, cioè religiosamente neutrali: le sole capaci di essere realmente rispettose della parità di diritti, della pari libertà, e in definitiva della pari dignità sociale di ogni singolo individuo.
[Redatto da Giulio Ercolessi]
{ Pubblicato il: 14.09.2011 }
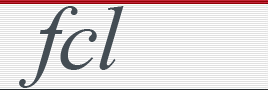




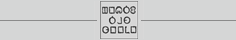




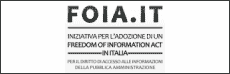






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.