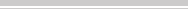fondazione critica liberale
2 commenticon due commenti
Da molti anni, nei Paesi che hanno rappresentato l’avanguardia della democrazia liberale, si assiste a una profonda crisi delle sinistre, ormai pressoché sistematicamente sconfitte dal “pensiero unico” delle destre post-reaganiane, ispirato a quello che Joseph Stiglitz ha definito il Washington consensus; sinistre incapaci di proporre ricette sociali ed economiche alternative, sempre più inadeguate ad intercettare il favore degli elettori.
Non è un caso, a parere di chi scrive, che ciò sia avvenuto per figure politiche tutte in qualche modo capaci di prendere atto della ormai acclarata inadeguatezza del “paradigma socialdemocratico” a fornire un convincente strumentario di governo nellamodernità globalizzata; ma tutte poi inclini a sostituire quel paradigma con un fumoso “nuovismo”, con un generico democraticismo buonista, ma privo di qualsiasi solida base culturale e di una coerente e convincente weltanschauung politico-culturale. Un’attitudine (culturale prima che politica) disastrosa, della quale è stato catastrofico epigono quel tal candidato premier del centrosinistra italiano del quale non mette conto nemmeno di parlare, per gli esiti ad oggi irreversibili della crisi politica e di rappresentanza a cui la sua incoscienza ha dato luogo nel Paese.
Se davvero la lunga età socialdemocratica è giunta, da più decenni, alla sua conclusione, e non certo con un bilancio solo negativo, è invece forse il caso di porre l’ipotesi che ci sia un’altra via, rispetto a questo generico new age politico, a questo vuoto sincretismo funzionalista, per rianimare le sinistre occidentali, per dare loro un programma politico capace di convincere davvero una nuova constituency in grado di dare stabilità a un coerente programma politico riformatore.
È possibile tracciare un breve quadro delle ragioni e delle dinamiche che hanno spiazzato il “paradigma socialdemocratico”. Nel quadro della “grande trasformazione” (per dirla con Polanyi) iniziata nella seconda metà degli anni ’70 del Novecento, e che ha trovato, nei decenni più recenti, un irresistibile volano nella modernizzazione tecnologica, tutti i principali contesti sociali prima ancora che economici hanno mutato profondamente le proprie caratteristiche, incidendo profondamente sui punti di forza del modello.
L’impresa ha smantellato la piramide organizzativa del fordismo, si è rigenerata nella forma dell’arcipelago produttivo disarticolato in collocazioni geografiche distanti ma interconnesse; il lavoro manuale non è scomparso, ma quantitativamente ha perso rilevanza rispetto ad altre e più pregiate funzioni, a nuove forme di imprenditoria diffusa e a nuove professionalità.
Conseguentemente, la massa di forza lavoro operaia, che era la base elettorale del progetto socialdemocratico, si è disintegrata in una miriade di lavori e professioni, le cui caratteristiche e i cui bisogni non sono più facilmente organizzabili attorno a parole d’ordine unitarie, come ai tempi della prima e della seconda Rivoluzione industriale. Il consumatore dei prodotti standardizzati dell’impresa tayloristica,massificato nell’uso della “Fordmodello T di qualsiasi colore, purché nera” (come recitava un celebre paradosso attribuito allo stesso Henry Ford), è oggi vellicato nella sua individualità attraverso una ben più raffinata strategia di marketing, resa possibile da una più ampia diversificazione del prodotto-servizio, esemplificata dall’orologio Swatch.
Questo mutamento di paradigma ha ben presto tracimato sull’organizzazione istituzionale e politica.
La forza lavoro non più coesa attorno a semplici e maggioritarie domande sindacali si è frantumata in mille rivoli di rappresentanza, sui quali ha avuto buon gioco la richiesta di deregolamentazione e restaurazione padronale cavalcata dalle destre.
L’impresa “sconfinata” (nel senso di non essere più legata a confini) si è sottratta alla forza regolativa degli Stati-nazione, facendo saltare il compromesso su cui il welfare socialdemocratico era fondato.
La speculazione finanziaria ha esasperato all’ennesimo grado questa tendenza a svincolarsi dai confini, rendendosi pressoché inafferrabile e portando sul piano globale problemi cruciali e relative ipotesi regolative.
Si è così imposta quella globalizzazione che ha marginalizzato tanti sistemi socio-economici regionali e sfidato tante realtà produttive anche nazionali, portando, per contraccolpo, le comunità locali e ricoprire un localismo spesso sconfinato nel comunitarismo (quando non in tribalismo), come reazione ad un profondissimo senso di anomia, su cui, prima di morire, ha scritto pagine acutissime Ralph Dahrendorf. Man mano che si rendeva sempre più evidente la necessità di sedi di governo di questi fenomeni superiori agli Stati, per paradosso storico si imponeva dunque un campanilismo asfittico e rivendicativo, sulla scorta del quale anche gli Stati nazionali hanno ripreso fiato, innescando dinamiche nuovamente solo intergovernative anche laddove si stava già progredendo verso vere e proprie forme di integrazione sovranazionale (il caso dell’Unione Europea è, da questo punto di vista, paradigmatico).
Ciò ha reso sempre più difficile governare flussi migratori sempre più ampi e costanti, che stanno cambiano la morfologia stessa delle genti d’Europa e del mondo avanzato: basta guardare una qualsiasi sfida calcistica tra squadre nazionali per averne una conferma plastica.
Incalzata, a livello istituzionale, da questo ritorno al campanile, la globalizzazione ha preso la sua rivincita sul piano dei comportamenti individuali: le vecchie abitudini religiose e di perbenismo condiviso sono state smantellate in quasi tutti gli strati sociali, a beneficio di una società molto più individualista e secolarizzata, sempre più incapace di ragionare in termini di socialità, ma anche più laica e pluralista quanto agli stili di vita socialmente accettati. Ciò ha comportato anche contraccolpi di tipo demografico, che rendono ormai insostenibili tanti vecchi sistemi di welfare di carattere assicurativo, per lo squilibrio tra le coorti di età dei contribuenti (sempre meno numerosi) e dei fruitori (sempre più numerosi).
Dunque, la classe lavoratrice omogenea, organizzata sindacalmente in coorti di sostegno ai partiti del laburismo, è ormai un ricordo, come lo è l’onnipotenza di quello Stato nazione che a beneficio di quella classe organizzava meccanismi redistributivi, servizi pubblici universali, piattaforme istituzionali di welfare.
Alla perdita di queste fondamenta sociali e istituzionali si è affiancato, a livello valoriale, un discredito crescente per l’egualitarismo socialista, una richiesta di protagonismo individuale, di equità generale, di chance di vita.
Se quanto sin qui sostenuto è vero, pare davvero difficile immaginare che il futuro delle sinistre occidentali possa trovarsi in una rianimata socialdemocrazia. Come pare difficile che a sfide così grandi, di portata epocale sul piano istituzionale e dell’organizzazione politica, ma anche così profondamente legate al sentire profondo degli individui, si possa dare risposta attraverso un grigio funzionalismo, per di più incapace di ridiscutere i rapporti di potere esistenti nella società.
E dunque? Nessun futuro per le sinistre occidentali?
Una prospettiva di lotta politica limitata al contenimento centrista allo strapotere di destre depositarie di un unico modello di vita, società e istituzioni legittimato politicamente?
Non è necessariamente così.
Se è vero che i problemi che la modernità ha messo di fronte alle sinistre consistono largamente nello sfaldamento di vecchie coalizioni di attori ormai numericamente insufficienti, che lascia l’individuo solo al cospetto del Potere; se è vero che la delegittimazione dei vecchi meccanismi istituzionali del “paradigma socialdemocratico” è accompagnata da una perdita di credibilità del valore dell’uguaglianza su cui essi erano fondati; allora alle sinistre resta la possibilità di ripartire proprio da quell’individuo solo e opposto al Potere, dal valore della sua autonomia, dalla sua richiesta di autodeterminazione, di affermazione, di adeguate chances di vita.
Resta, difficile e affascinante, la prospettiva della libertà; resta, antico emoderno a un tempo, nella sua ispirazione originaria, fondante della modernità occidentale e potenzialmente sempre produttivo di nuovi equilibri sociali, il liberalismo.
Le sinistre occidentali, da decenni condannate a ripetute sconfitte o a cocenti delusioni, nel loro ostinato rifiuto di tornare a rimeditarne la lezione, dovranno essere liberali, o non saranno.
E d’altra parte, non si tratta che di completare un ciclo storico, riportando a quella che ne è stata la cultura originaria le forze che si oppongono alla conservazione dello statu quo.
All’alba del Parlamentarismo, sulle ali destre degli emicicli parlamentari stavano i lealisti, i monarchici, i difensori del feudalesimo nelle sue ultime propaggini; a sinistra stavano i difensori dei nuovi ceti, delle città, della nascente industrializzazione, del progresso scientifico e tecnologico, ma anche sociale, di un costituzionalismo tutto da affermare, di uno Stato di diritto tutto da costruire. I liberali. Poi, con il progresso economico, scientifico e sociale, sempre a destra hanno continuato a trovare posto i sostenitori degli equilibri già maturati, che divenivano man mano difensori dogmatici di ciò che avevano
combattuto: le città, l’industria, la stessa libertà individuale, ma usata solo comemanto retorico per difendere interessi di ceti prevalenti. A sinistra, invece, i liberali venivano pian piano scalzati, proprio fisicamente, verso il centro dell’emiciclo dai nuovi partiti del socialismo, forti della consistenza numerica dei ceti inquadrati nella rigida organizzazione sociale del fordismo.
I socialisti sorpassavano i liberali e li condannavano, nella migliore delle ipotesi, ad una minorità da terza forza, a componente perdente di una competizione “a sinistra” (così in Gran Bretagna); nei casi peggiori, li ricacciavano in un asfittico moderatismo centrista (come a lungo in Germania), quando non in una paradossale collocazione conservatrice, figlia di un ritardo storico evidentemente non colmato (così in Italia).
La cultura liberale dell’intraprendenza borghese, dell’affermazione individuale, della equità generale, delle chance di vita, della tutela delle minoranze, nel cozzo degli interessi del conflitto lavoristico otto-novecentesco, che conformava largamente la dialettica politica generale nell’emergenza creata dalle storture della seconda industrializzazione, veniva sopravanzata dall’egualitarismo socialista, dall’affermazione della classe prevalente degli esclusi, dalla burocratizzazione della società per mezzo di strutture amministrative incaricate di riequilibrare le sorti di vita della gran massa dei lavoratori. L’uguaglianza sopravanzava la libertà come valore centrale del progetto politico delle sinistre.
Nel mentre ciò accadeva, la cultura liberale si interrogava sui limiti delle istituzioni sociali che essa stessa aveva contribuito ad affermare, dal mercato all’amministrazione pubblica all’impresa; partoriva nuove declinazioni della sua perenne aspirazione alla libertà e alla autodeterminazione di tutti e di ciascuno; inventava il welfare, che poi le sinistre socialiste (e in molti casi le destre clericali) avrebbero realizzato in forme più burocratiche e corporative; scopriva le virtù della regolazione del mercato, che altri avrebbero poi sclerotizzato in forme a loro volta neocorporative, quando non apertamente anticoncorrenziali o monopolistiche.
Nonostante una costante vitalità e una capacità di autorigenerazione del liberalismo sul piano culturale, insomma, i partiti organizzati che a quella cultura facevano riferimento sono stati scavalcati a sinistra, a cavallo tra Ottocento e Novecento, da quelli di matrice socialdemocratica. I quali ultimi hanno poi governato (con esiti diseguali ma in definitiva con successo) quel modello welfarista-interventista nato, paradossalmente, più dalla migliore riflessione della cultura liberale (da Mill a Beveridge a Keynes) che dalla loro stessa cultura (in molti casi adattandone essenza e strumenti in maniera da fiaccarne non poco le potenzialità perequative).
Ora, però, le trasformazioni avvenute e quelle in atto danno un nuovo spazio ad un liberalismo organizzato che abbia voglia di tentare la scommessa di un controsorpasso nei confronti dei partiti socialdemocratici ormai agonizzanti. Chi scrive ha già ipotizzato su queste colonne che un simile sorpasso sia urgente, in specie in chiave europea (Il sorpasso, in “Critica liberale”, febbraio-marzo 2009, nn. 160-161, pp. 33 ss); più in generale, occorre iniziare a porre con forza l’ipotesi che la sinistra continui a perdere ovunque nel mondo, che stenti a mettere insieme un convincente programma politico ed elettorale, perché si attarda a progettare implausibili riproposizioni di ricette del passato o a sognare improbabili nuovismi senza base culturale solida.
Perché tarda ad accettare il dato di realtà di avere davanti a sé l’unica vera opzione di farsi liberale.
Eppure i segnali in questo senso sono, per chi abbia voglia di vederli, moltissimi e concordanti. A una condizione, ovviamente: che del liberalismo non si adotti la stanca e stereotipata versione che l’ha assurdamente
schiacciato su un moderatismo esangue; né che se ne sogni chissà quale mutazione nuovista; ma, molto più semplicemente, che se ne recuperi la versione più antica e più vera.
Quella di una cultura modernizzatrice, che ha il coraggio di sovvertire l’esistente anche se appare incrollabile.
Che promuove l’autonomia dell’individuo, la laicità delle istituzioni e la secolarizzazione della società, per consentire a ognuno di attendere al proprio irripetibile progetto di vita. Che si fa liberatrice delle energie della società civile. Che critica e controlla ferocemente il potere (non certo solo il Governo, ma ogni potere che circola nei gangli della società). Che ne predica la separazione, sia in orizzontale (tra poteri dello Stato) che in verticale (tra istituzioni territoriali, ma sulla base di una prospettiva di progressiva integrazione federalista), sia tra tipologie di potere (economico, mediatico, politico, istituzionale, religioso). Che critica e limita gli stessi meccanismi della democrazia, temendone la potenzialità autoritaria, e recupera l’essenza più vera del costituzionalismo nella limitazione del potere, dopo decenni di retorica della governabilità. Che dà spazio e voce ai nuovi attori sociali contro lo sclerotico monopolio dei ceti egemoni (e quindi oggi urgentemente alle donne, ai giovani, ai migranti, agli innovatori sociali ed economici). Che ridà fiato, per questo, a un dibattito pubblico vitale e perfino acceso, a un conflittualismo permanente (ma irreggimentato nelle categorie del civismo) che è l’unico vero antidoto alla violenza immanente nella società. Che rivitalizza in forme sempre nuove la partecipazione politica. Che sposta continuamente il confine, necessariamente mobile, tra un mercato che sia attivazione delle migliori energie della società (impedendogli, però, di tramutarsi nel far west degli interessi consolidati) e uno Stato che sia garanzia dei diritti degli esclusi e fattore di riequilibrio delle fortune individuali (evitandone, però, il parassitismo burocratico). Che ridisegna un welfare a misura degli individui e non delle corporazioni. Che dà corpo alle dinamiche di una governance partecipata, in luogo delle ormai sclerotiche forme del dirigismo amministrativo ereditato dallo Stato assoluto, recuperando il coraggio istituzionale delle grandi escogitazioni del costituzionalismo settecentesco. Che riafferma un nuovo umanesimo individualista e borghese (nel senso originario che l’aggettivo aveva all’alba della modernità) come premessa di qualsiasi discorso pubblico, coltivando, a questo fine, educazione individuale e civica, progresso materiale e civile.
Non potrebbe intraprendere lo stesso programma ardentemente riformatore, perennemente rivoluzionario degli equilibri successivi della società una forza di matrice socialdemocratica (nè semplicemente democratica).
Perché non ha nel suo bagaglio gli anticorpi contro i pericoli di una democrazia che degeneri in dittatura del numero. Perché non ha la sensibilità per progettare istituzioni e regole a misura del singolo a dispetto della corporazione. Perché ha una connaturata tendenza a seguire bisogni e domande della maggioranza a fronte di quelli delle tante minoranze protagoniste dellamodernità. Perché sposa per istinto l’aggiustamento progressivo dell’esistente piuttosto che ribaltare gli equilibri consolidati. Perché vive dell’esigenza del potere, ne ha una concezione salvifica, anziché temerne gli eccessi e limitarne l’esplicazione. Perché, semplicemente, non ha l’individuo al cuore della sua riflessione, ma il gruppo, la classe.
Perché discende, in definitiva, dal dispotico Rousseau anziché dallo scettico Montaigne.
Quasi quaranta anni di torsione verso l’ingiustizia e di negazione delle chances di vita, perpetrati dalle destre in tutto il mondo, richiedono un’urgente inversione di rotta. Ma solo una sinistra che sappia farsi anticamente liberale potrà concretizzarla.
{ Pubblicato il: 20.09.2011 }
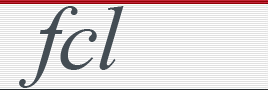




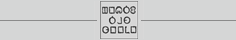




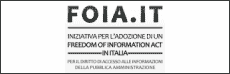






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.