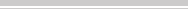pierfranco pellizzetti
Nessun commentoMentre sull’Italia incombe sempre più minaccioso il rischio default, da più parti si sollecitano provvedimenti anticrisi del Governo sotto forma di decreto; cui Silvio Berlusconi replica spensierato, dicendo che non ci sono soldi e comunque la faccenda non è poi così urgente.
D’altro canto il premier non fa testo, visto che è in altre faccende affaccendato e – comunque – quello delle strategie per il rilancio economico non è terreno in cui può rifulgere la sua unica attitudine comunicativa: l’arte del barzellettiere.
Queste note – dunque – sono soltanto un messaggio nella bottiglia per tempi in cui (sperabilmente) si tornerà a parlare di argomenti seri tra persone meno pagliaccesche.
A futura memoria: ha senso trasformare – con le parole di Francesco Vella, economista dell’Università di Bologna – “il mantra della crescita” nel rapporto tra economia reale e riforma delle regole?
Infatti sono ormai quasi tre lustri che si pensa di ovviare alla perdita di competitività del sistema-Italia pestando nel mortaio sempre la stessa acqua amministrativo-regolativa, come se l’eccellenza produttiva fosse solo un de cuius. Nell’illusione che l’impresa sia un potente motore in ceppi e che, una volta liberato dai vincoli burocratici (Guido Carli li chiamava “lacci e lacciuoli”), tornerebbe immediatamente a ruggire; innovando, conquistando nuovi spazi di mercato e diffondendo benessere.
Qualcosa a cavallo tra la Mano Invisibile, il laissez faire e l’attesa della manna dal cielo, per cui allo sviluppo competitivo (e il tipo di società che ne consegue per tutti noi) sarebbero titolati a pensarci solo padroncini e manager…
Ma le cose non stanno così. Come dimostra il fatto che si continua a inseguire questa falsa rappresentazione senza ottenere svolte degne di questo nome.
Già nel 1998 il Testo unico della finanza (Tuf) aveva introdotto importanti novità in materia di governance societaria allo scopo di rimuovere impedimenti alla crescita delle piccole imprese allargando i perimetri della borsa e facilitandone l’accesso. Con risultati pressoché nulli. Data la semplice ragione che le imprese di taglia minima non crescono per ragioni sociali e culturali, riassumibili nel familismo: stanze di compensazione dei rapporti proprietari tra parenti che recalcitrano ad accettare le regole di trasparenza imposte dalla quotazione. Poi l’osmosi tra giuristi ed economisti ha prodotto la modifica della disciplina fallimentare, liberando le procedure concorsuali dallo stigma sociale. Infine, recentissime, le nuove disposizioni sul contratto a rete per favorire aggregazioni e sinergie. Per non parlare delle precarizzazioni.
Dopo questo titanico sforzo regolamentativo la situazione del nostro tessuto produttivo non si è modificata di un capello. E il declino non ha subito battute d’arresto. Per una semplice ragione: l’astrattezza di tali impostazioni.
Qui non si vuol dire – figuriamoci! – che le regole non servano, ma il cuore del problema batte altrove. Ossia nella tangibile materialità di pratiche finalizzate a creare beni e servizi che interessino, che siano appetibili.
Un nodo che non si scioglie grazie al formalismo leguleio.
Il problema è che l’Italia ha smarrito da tempo la cognizione di ciò che sa e vuole fare, mentre perdevamo tutti i treni che si potevano agganciare con una politica attiva per l’impresa. Siamo ancora manifatturieri, ma ormai puntiamo solo sull’abbattimento dei costi. Siamo un mercato per la logistica, ma sono i grandi gruppi stranieri a menare la danza. Siamo un polo turistico di tutto rilievo, ma gestendo il patrimonio paesaggistico ed artistico come una rendita stiamo perdendo posizioni. Scommettiamo sull’hi-tech, ma in maniera scoordinata e senza strategie.
Il risultato è che non abbiamo più nicchie merceologiche che ci assicurino vantaggi competitivi. E nessuno le cerca.
Per questo – a futura memoria – bisognerebbe mettere in campo una politica di indirizzo. Come la Germania, che punta sulle produzioni d’alta gamma. Come la Francia, che sceglie l’infrastrutturazione della mobilità pubblica. Come fece il Giappone, individuando settori (la microelettronica di consumo e l’automotive), come sembrano iniziare a fare in Cina spostandosi gradatamente dall’export ai consumi interni. Perché il dottrinarismo economico e il formalismo giuridico vengono dopo la politica. E la politica poggia sulle spalle della società.
Una consapevolezza che ha molto a che fare con la qualità democratica.
P.S.
Qualcuno mi obietterà che il problema non è lo sviluppo (con tutte le precisazioni al riguardo) ma la decrescita. Per i fan nostrani di Serge Latouche non so se nutrire più tenerezza o irritazione: non capite che senza creazione di ricchezza avalliamo un’operazione reazionaria, in cui si bloccano gli accessi a migliori condizioni di vita per chi sta in basso, cristallizzando i vigenti svantaggi/privilegi?
Del resto, se non offriremo prospettive credibili, l’unica sirena per chi cerca un’opportunità di avanzamento sociale resterà quella del Neoliberismo con le sue macellerie sociali, dello sviluppismo incontrollato e dei consumi drogati.
[il Fatto online]
{ Pubblicato il: 21.10.2011 }
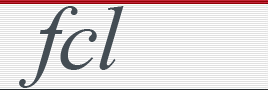




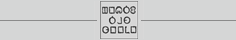




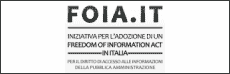






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.