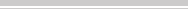tommaso visone
Nessun commentoDa questo punto di vista è possibile sostenere che la parabola governativa di Berlusconi si sia esaurita nel peggiore dei modi possibili. Non si tratta solo della pericolosissima vicenda attinente al crollo dell’appetibilità dei Btp italiani sui mercati finanziari, ma del protrarsi della logica che, di tale crollo, ne era – e ne è - alla base. Al di là delle responsabili (ma in molti “soggetti” ipocrite e strumentali) preoccupazioni per l’emergenza finanziaria che rischia di travolgere il Belpaese infatti sembrano latitare, in particolare nel ceto politico e giornalistico, analisi di lungo periodo, capaci d’inserire la deriva dell’Italia in una precisa fase della storia globale ed europea, individuandone la fenomenologia, gli attori, le principali linee di tendenza e l’interdipendenza con la realtà vissuta dal resto del mondo. A questa assenza di giudizi articolati fa eco la preoccupante pochezza propositiva contenuta nell’offerta politica (sempre nel medio-periodo) che i cittadini italiani si trovano dinnanzi – ancora?! – in questi frangenti. Negli ultimi anni – e in maggior misura negli ultimi difficili mesi – non è emersa, tra le forze presenti in Parlamento, alcuna proposta politica di fondo capace di fornire, sia pur da singole prospettive valoriali e di senso, un antidoto alla crisi economica riaprendo le porte del futuro. Inoltre – fatta eccezione per alcune eterogenee realtà esterne al Parlamento stesso (Vendola, Zingaretti, Montezemolo e Grillo) non sono affiorate proposte concrete sui primissimi passi da fare nel futuro prossimo, ovvero non e’ stata neanche chiaramente individuata una strategia di riforme prioritarie minima (quattro o cinque punti) da proporre al nuovo governo quali mosse da realizzare in sequenza nel breve periodo. E’ quindi d’obbligo costatare come in questo scenario - in cui di fatto le forze politiche “democraticamente” elette in parlamento difettano di un progetto di ampio respiro, capace di mobilitare i cittadini e di smuovere le coscienze - Berlusconi sia caduto grazie alle sue deficienze, stimolate e evidenziate dalla pressione europea e combinate con dei “conti” di palazzo interni non tanto ad una galassia politico-culturale, quanto a dei precisi gruppi d’interesse che già da molti anni fanno, sia pur in un gioco complesso, la parte del leone nella politica italiana (Chiesa Cattolica, Confindustria, ecc.). Non vi è stata alcuna contrapposizione progettuale al “Caimano” che, guidata dal parlamento, abbia trovato riscontro e sostegno nel Paese. A riguardo sia detto per inciso: negare una cosa non significa affermarne un'altra. Lo stesso Monti è stato di fatto voluto e sostenuto prevalentemente da Presidente della Repubblica che lo ha abilmente inserito all’interno di un gioco parlamentare che si stava facendo troppo pericoloso per tutti. Nel caso di Mister B si tratta, dunque, di una caduta che non è stata provocata dalla crescita inarrestabile di un’idea alternativa dell’Italia e del mondo reificatasi in una precisa azione parlamentare, quanto di un sostanziale gioco di palazzo – a proposito : chi di meschinità ferisce di essa perisce - avvenuto sulla base d’interessi di bottega particolari, gli stessi che fino ad oggi hanno sostenuto Berlusconi e che hanno contribuito a delineare il fallimentare modello di vita collettiva diffusosi come un cancro nel mondo durante gli ultimi trent’anni. Tale dinamica ha un risvolto decisamente negativo nella misura in cui non si è, fino ad oggi, colta l’occasione apertasi in Italia - ma non solo - dalla duplice contingenza data dalla crisi del governo Berlusconi e dalla crisi economica mondiale. Il che, ovviamente, non significa che le dimissioni del “piazzista di Arcore”, con il suo implicito ridimensionamento politico, siano un fatto negativo, tutt’altro. Significa solamente che esse costituiscono un elemento necessario (potremmo anche dire l’elemento necessario per la riapertura del quadro politico italiano) ma non sufficiente e che, in certe condizioni ,come quelle proprie all’Italia, il perseguimento dell’obiettivo necessario non deve essere portato avanti nella più totale mancanza di lumi riguardo a quello sufficiente (il progetto politico), pena il mancato raggiungimento della meta. Lo si deve sottolineare: l’obiettivo principale non era e non è quello di colpire Berlusconi. Non si tratta, infatti, di dare vita a sterili vendette politiche o civiche su quest’ultimo o sul cosiddetto berlusconismo. Inutile accanirsi sull’uomo che è tristemente quello che è (fatto salvo il doveroso e, si spera, indipendente cammino della giustizia ordinaria). Il punto è un altro.
Il nostro, ormai ex, “caro leader”, tramite la sua azione mediatica e di governo, ha coperto, rappresentato, consentito, legittimato e, a modo suo, subito un sistema dirigenziale (non solo politico) incivile, marcio e regressivo che ha potuto prosperare ed evolvere (non certo nascere) alla sua ombra. Fare seriamente i conti politici e civici con il suo governo in questo momento sarebbe stato farli, finalmente, con quel sistema e con la logica clanica e barbara che ad esso fa capo. E’ quest’ultimo l’elemento da valutare politicamente e, in maniera ancor più profonda, secondo una prospettiva di civiltà rivolta al futuro. Proporre un’alternativa forte, credibile allo sfascio civile, istituzionale, progettuale, economico e morale della “Seconda repubblica” - che ha avuto in Berlusconi il suo tappo e il suo specchietto per le allodole, il suo fulcro e la sua “tempesta perfetta” - avrebbe significato rilanciare il Paese ben oltre la fine del “princeps” alla rovescia (ultimo tra gli ultimi). La crisi del governo Berlusconi e della sua, inizialmente ampissima, maggioranza significa, infatti, che il re è nudo e che quell’ordine regressivo ha perso la sua stabilità (e Monti, anche nel peggiore dei mondi possibili, può difficilmente restaurarne l’assetto originario). Da qui le disperate manovre che si sono seguite l’un l’altra all’interno della stessa, ormai ex, maggioranza e i tentativi di alcuni – guarda caso i più furbi e navigati - di ragionare attorno agli scenari politici del futuro per tentare di rendere operativa quella vecchia massima gattopardesca secondo la quale: “occorre che tutto cambi affinché tutto resti com’era prima”. Data l’entità dei lavori in corso sul fronte dei soliti noti é possibile dedurne che, aumentata la pressione nella melmosa vasca del potere, il tappo stia saltando. Ergo – dandone una lettura alla rovescia rispetto a quella propria ai conservatisi interessi conservatori - si manifesta, complice anche la crisi mondiale, una grossa occasione per realizzare una svolta nella politica italiana e, quindi, anche europea: quel riscatto che moltissimi sognano e che alcuni (purtroppo una ristretta minoranza se si tiene conto solo della, decisiva, classe dirigente) cercano, da tempo, di costruire. Sarebbe questo il momento per dare vita ad una decisa proposta politica capace di andare oltre la “Seconda repubblica” e i suoi stilemi di in-civiltà, ribaltandone gli effetti nefasti in un’ondata costruttiva e innovativa di cui l’Italia potrebbe ancora essere capace. La misura è quasi colma e molti non aspettano che una parola d’ordine e degli esempi per aprire, con una tenace manifestazione di cittadinanza, le porte del futuro. In tale scenario inedito, tuttavia, l’Alternativa (che non ha nulla a che vedere con l’alternanza) non sembra palesarsi. Vi sono, certo, dei movimenti attivi in tal senso dotati di visibilità (e anche, a volte, di qualche buona proposta) che restano tuttavia sostanzialmente incapaci di egemonizzare lo spazio pubblico, di darsi una leadership (fatta salva quella “carismatica” ma non strettamente politica di Beppe Grillo per il Movimento cinque stelle e quella eccessivamente compromessa con la vecchia classe dirigente di Luca Cordero di Montezemolo) o di disegnare un programma complessivo di governo fatto di cinque/sei punti chiari e in grado riaprire complessivamente la vita democratica italiana. D’altra parte i partiti (sia quelli rappresentati in parlamento che quelli rimastine ad di fuori) non sembrano essere in grado di raccogliere la fiaccola del rinnovamento accesa dall’opinione pubblica. E questo per un triplice ordine di ragioni distinte ma non disgiunte su cui si deve ragionare e agire se non si vuole perdere l’attimo propizio che si è aperto e che rischia di chiudersi troppo presto se lasciato in balia di soggetti e entità dediti al barbaro – e quindi sempreverde – amore del proprio “particulare”.
Prima ragione: la nostra classe politica non ha credibilità. Eccone in sintesi i motivi esaminati alla luce dell’opinione pubblica: gli esponenti della politica nostrana risultano mediamente compromessi con numerose vecchie esperienze politiche fallimentari o “opache” e quindi sostanzialmente incapaci di intervenire sui danni da loro stessi operati; si mantengono in vita, come leader di partito, grazie all’inesistenza di un sistema di selezione politica interna (con il “porcellum” anche esterna) che sia efficiente e democratico; hanno o hanno avuto, in numerosi casi, problemi con la giustizia (che spaziano da condanne definitive a processi eclatanti in corso) il che li rende difficilmente idonei a rappresentare degnamente il paese e li rende soggetti a numerosi dubbi rispetto alla loro onestà in qualità di amministratori pubblici; sono di frequente portatori palesi di conflitti d’interesse dati dall’incontro nelle loro stesse mani di poteri decisionali dalla forte rilevanza sociale nel settore pubblico e privato il che li delegittima in qualità di legislatori idonei a perseguire l’interesse generale e, last but non least, risultano privi di progettualità politica di medio-lungo periodo, il che li abbassa costantemente al ruolo esclusivo di portatori di interessi particolari (privati, di ceto, di partito, ecc.) privandoli di ogni contatto ideale con la cittadinanza che non può in nessun caso individuare in loro un progetto complessivo su cui fare – e dare – affidamento.
Seconda ragione: i partiti e la classe dirigente che ne promana non si fanno portatrici di alcuna prospettiva politica complessiva sulla vita in comune, sul futuro della collettività e sull’uomo. Per rispondere alla domanda “che fare?” bisogna sempre avere prima in mente la risposta a quella “cosa si vuole?”. Se si desidera cambiare la realtà e convincere la cittadinanza a sacrificarsi, a spendersi, per un obiettivo si deve avere questo telos ben chiaro nella testa e nel cuore. In Italia la classe politica appare, mediamente, priva di un’idea complessiva, seria e sentita, della vita in comune che intenderebbe proporre, del tipo di uomo che ne dovrebbe emergere e della direzione in cui muovere per avvicinare la realtà a tale idea. Anche i “sedicenti” – merce rarissima - conservatori non fanno eccezione (a differenza dei conservatori “di fatto” che invece sono moltissimi, pur continuando ad auto etichettarsi nei modi più svariati e a predicare cambiamento e novità a ogni pié sospinto): infatti non c’è praticamente nessuno che si prenda la briga di spiegare e motivare perché e in quale modo la realtà del paese debba rimanere esattamente quella che è rispondendo essa al migliore dei “mondi possibili” (non certo Berlusconi & Company sedicenti liberali e/o popolari). In questo deserto, alimentato da lunghi decenni di mancato confronto con il mondo della cultura, è normale che la visuale del politico si restringa esclusivamente all’obiettivo congiunturale e alla mera ricerca del potere per il potere, cosa che viene percepita largamente dai cittadini che spesso votano “contro” e non “per”. Così si riducono le possibilità di preparare e pensare delle svolte politiche complessive in quanto alla domanda “che fare?” si risponderà sempre in maniera approssimativa e non tanto per assenza di conoscenze tecniche quanto per mancanza di discussione (e di elaborazione) sui fini. Inoltre in tale modo salta completamente la funzione educativa – e quindi civica, in quanto portatrice di cultura intersoggettiva - della politica che dovrebbe trasmettere al cittadino un insieme di valori e di comportamenti da perseguire all’interno della società; valori che, ovviamente, non possono essere professati con effetti positivi (e tantomeno insegnati) da chi, oltre ad ignorarne nei fatti l’importanza, non ha svolto alcuna riflessione su di essi e sul loro ruolo politico e sociale. Il grande problema connesso a questa assenza di prospettiva – sempre sottovalutato nel mondo contemporaneo – non è certo proprio alla sola Italia: esso è comune a tutti i paesi democratici del mondo e rischia di divenirne il principale cancro nella misura in cui, per dirla con Bobbio, per far si che esista la democrazia bisogna sempre avere almeno due alternative reali tra cui scegliere. L’assenza di prospettive fa infatti diventare le alternative fittizie, riducendo il tutto alla mera alternanza (dalla politica alla sola amministrazione, dalla scelta di senso alla funzione tecnica) e facendo avvizzire completamente l’albero democratico.
Terza ragione: il sistema partitico ed i suoi dirigenti principali risultano strettamente legati al mondo dei grandi interessi di cui non si fanno, come un tempo, sintetizzatori e interlocutori, ma di cui risultano in ultima istanza dei rappresentanti. Il mitico richiamo ad un ruolo centrale della società civile – altro lato “ideologico” e malsano dell’incontro tra la protesta anti-partitica degli anni novanta e il neo-liberismo allora imperante - si è risolto nella diretta subordinazione dei grandi partiti ai più forti interessi costituiti presenti all’interno della società italiana (siano essi quelli della Confindustria, della Chiesa Cattolica, di qualche sindacato o di privati più o meno scaltri e/o facoltosi). La scarsa indipendenza del mondo della stampa e, più in generale, dell’informazione non aiuta a far luce su questa preoccupante resa delle forze politiche, incapaci, anche per le due ragioni citate sopra, di contrapporsi ai grandi interessi nel nome del più grande interesse del Paese e di quello – altrettanto nobile e legittimo – della casa comune europea e cosmopolita, la cui manutenzione e costruzione dovrebbe costituire la preoccupazione costante di un uomo politico del ventunesimo secolo. Tale subordinazione – sul piano di fatto e su quello strettamente programmatico e ideale - contribuisce fortemente ad allontanare il comune cittadino, portatore di interessi più piccoli o di speranze più vaste, da un mondo in cui non può sentirsi rappresentato. Le sue esigenze non vengono più filtrate dal partito e fatte pesare nell’equilibrio complessivo della sintesi politica del partito stesso, al massimo ci si limita a slanci populisti volti ad assecondare il trend medio (che non coincide mai con le reali aspettative dei singoli) dell’umore popolare. Non si discute, si registrano (e in maniera strumentale agli interessi di cui sopra) solo le grida più alte. Si trattano, come aveva genialmente previsto Tocqueville, gli uomini come bambini. Molti cittadini di fronte a tale cinica prassi preferiscono smettere di giocare e scegliere una strada diversa, che può consistere nella partecipazione alle attività di una realtà politica extra-partitica, in altre attività sociali o nella rinuncia alla propria partecipazione civica. Tutto questo contribuisce a chiudere sempre di più il mondo dei partiti verso l’esterno e ad alimentare il circolo vizioso per cui i soliti personaggi finiscono per occupare gli stessi posti nel corso di decenni e sempre nell’interesse degli stessi soggetti. Anche siffatto problema non è presente esclusivamente in Italia, basti a riguardo leggere le lucidissime analisi di Sheldon Wolin sul sistema in vigore negli Stati Uniti. Eppure nel Belpaese esso si manifesta in maniera particolarmente virulenta perché si tratta di un contesto in cui la democrazia è stata sempre debole e parzialmente etero diretta, in cui lo Stato si è dovuto costruire in presenza di un attore millenario e ostile quale la Chiesa Cattolica e in cui le mafie hanno svolto - e svolgono - un ruolo preoccupante nella determinazione della vita sociale d’intere aree del Paese. Infatti, se il lavoro di sintesi dei partiti nel secondo dopoguerra era stato decisivo per la democratizzazione dell’Italia, il più che ventennale venir meno della loro funzione non può che aver contribuito in maniera decisiva all’inversione del trend democratico e alla sostanziale rovina della, pur imperfetta, macchina civilizzatrice e partecipativa messa in piedi sulle macerie lasciate dalla seconda guerra mondiale e dal fascismo. Quindi, anche qualora si volesse sostenere l’inutilità dei partiti per il futuro della vita democratica italiana, si dovrebbe riflettere a fondo sul ruolo da essi giocato e sulla funzione che essi seppero svolgere. Il fatto che i partiti lavorino male .- che appunto non giochino più un lavoro di sintesi, di filtro, dalla natura democratica e democratizzante - potrebbe sembrare una buona ragione per eliminarli. Per sostituirli con cosa? E in quale quadro di rapporti di potere? Attenzione: si è quasi giunti al punto di gettare il bambino con l’acqua sporca.
Giunti a questo punto ci si permetterà, chiudendo, di indicare tre punti su cui lavorare immediatamente per iniziare a invertire il trend e cercare di cogliere, per quanto possibile data l’enorme portata del problema, quell’attimo che sembra ancora una volta passare senza alcun decisivo esito progressivo (fermo restando che si auspica il miglior futuro possibile per l’operato del governo Monti, che tuttavia, non può certo fare miracoli). Bisogna adoperarsi subito in tal senso perché una volta chiusosi questo spazio storico – questo Kairos – non si sa quando tornerà.
Riguardo alla prima ragione: inutile chiedere un passo indietro ai leaders esistenti. Non lo faranno mai e, in un certo senso, sarebbe anche una cosa “normale” per il mondo della politica. In un contesto in cui non esistono prassi o regole precise rivolte a costringere un dirigente politico all’abbandono (chi pensa che Blair o Zapatero lascino per scelta spontanea non si rende conto della dinamica degli altri sistemi politici) è ridicolo insistere in tal senso. Sono pochi i casi della storia in cui il potere si è suicidato, così come sono e saranno pochi i Cincinnati a disposizione (lo sarà Monti?). C’è una sola strada: batterli politicamente. Come fare? Coalizzando tutti coloro che – all’interno delle singole compagini politiche e nel Paese – si rendono conto della fondamentale importanza di tale problema (purtroppo per chi non se ne rende conto la brutta sorpresa di ritrovarsi un Renzi – spregiudicato e populista quanto si vuole ma in grado di vedere prima degli altri tale decisivo spazio politico – è dietro l’angolo). Qui si pone un altro problema, cui il punto seguente. Non è infatti possibile porsi esclusivamente contro la vecchia classe dirigente ma bisogna farlo per una precisa prospettiva politica al fine di potersi realmente riappropriare del futuro.
Riguardo alla seconda ragione: l’operazione avrà un esito positivo solo se sostenuta da una precisa prospettiva politica futura dotata di un’idea dell’uomo, della società e del mondo. Le idee – per quanto siano soggette ad una possibile ermeneutica strumentale – vincolano e selezionano più e meglio degli interessi. Se non si terrà conto di questo si passerà, dopo terribili sforzi, da un vecchio dirigente privo di credibilità a un “nuovo” dirigente già predisposto a perderla: ovvero dalla padella (esperienza usata a fini conservativi) alla brace (protervia e ambizione usata a fini personalistico-accumulativi). Ovviamente nel tempo il “nuovo” leader diventerebbe “vecchio” ripresentando nuovamente i medesimi problemi di oggi e, in tal modo, il gioco proseguirebbe in eterno a spese di tutta la cittadinanza. L’elemento decisivo di rottura in tal senso è dato da una forte apertura nei confronti del mondo della cultura e degli intellettuali caratterizzata in maniera esattamente opposta alla dinamica presente concernente la relazione tra Politica e Cultura. Ad oggi si invitano gli intellettuali a sponsorizzare un progetto già stabilito o ad definirne i dettagli (e non la sostanza), mentre il mondo della cultura viene utilizzato in senso mediatico ai fini di legittimazione di questo o di quel interesse personalistico. In tale ottica è facile intuire come l’intellettualità disposta a prestarsi al gioco non sia sempre la più integerrima, critica e realmente propositiva. Si è, in tal senso, creato un circolo vizioso che rovina sia la Politica (priva di un ampio respiro e proprio per questo incapace di sintesi e priva di ogni appeal parenetico) che la Cultura (che si riempie di arrivisti e di conformisti, appoggiati dalla politica di cui sopra, e che spesso si insterilisce a causa dell’assenza di ogni serio confronto con la politica): di conseguenza la società le perde entrambe come soggetti sani. Occorre, quindi, cambiare tale prassi aprendo la strada alla creazione di un circolo virtuoso. Coloro che intendono coalizzarsi contro il vecchio sistema dovrebbero a riguardo fare un passo preciso : aprire degli spazi mediatici e sociali pubblici in cui ascoltare e discutere le proposte già definite – e finora mai prese seriamente in considerazione - che provengono dal mondo esterno, da coloro che hanno conservato – irrisi dalla supponenza tipica dell’ultimo uomo nietzschiano – una visione d’insieme e di lungo periodo. Le fondazioni promosse dai partiti, per come sono state gestite fino ad oggi, hanno svolto un ruolo opposto: dei luoghi chiusi in cui si discute tra amici, in privato, di prospettive utili a questo o a quel leader politico. Invece occorrerebbero degli spazi – su internet, in televisione, nelle università, nei giornali, ecc. – in cui scontrarsi, discutere, polemizzare su delle questioni di fondo (si pensi, ad esempio, ad un programma impostato come “Servizio Pubblico” ma non basato sulla cronaca politica o sull’attualità), cercando di far partecipare criticamente i cittadini e di far emergere quelle prospettive che possono incontrarsi e quelle che possono divergere nel lungo periodo al fine di ridefinire una proposta politica complessiva per il mondo moderno che tenga conto – con chiarezza propositiva – di questi tre elementi (e delle relazioni tra di essi) a carattere programmatico : uomo, società e mondo del futuro. In questo spazio i politici dovranno in primis ascoltare per poter poi selezionare, scegliere, ibridare, sintetizzare e reificare politicamente tali prospettive. Si torni a dare importanza alla cultura non per associarla ad una propria strategia di potere ma per associare il potere ad una strategia culturale. Lo si faccia da subito: in merito le occasioni potrebbero essere molte (festivals, dibattiti, ecc.), basti riconoscere il valore rivoluzionario, anche per il mondo della cultura, di tale istanza. Quest’ultimo infatti non ha bisogno di foraggiatori o di mecenati più o meno interessati: ha bisogno di una società e di una politica che diano un peso essenziale alle sue istanze, al suo ruolo ed alle sue proposte, solo così potrà migliorare la propria selezione interna e promuovere le proprie eccellenze. Tramite questo processo già in qualche mese inizierebbero ad emergere delle forti alternative programmatiche (es. crescita o decrescita? big society? stato sociale? Federazione europea o Europa intergovernativa? ecc.) attorno alle quali elaborare una proposta complessiva capace di vincere e di convincere. Per cambiare la realtà, infatti, non basta prendere il potere ma bisogna sapere esattamente in quale direzione adoperarlo, altrimenti si peggiora solo la situazione, specialmente in democrazia.
Riguardo alla terza ragione: si preparino nei prossimi mesi delle proposte strutturali – tenendo presente in primis il quadro disegnato tramite il lavoro di cui sopra – da rivolgere al mondo degli interessi e si ascoltino le loro risposte cercando poi una mediazione che tenga in assoluto valore gli elementi programmatici di fondo: basta inseguire la realtà, essa deve essere pensata e ordinata sulla base di un lavoro di sintesi rispondente ad un’ottica futura (quindi di per sé in grado di indirizzare il presente, interessi compresi). Si torni a pensare una politica industriale ed energetica. Si dica chiaramente, dopo anni di vuota esaltazione della società civile, che ai dirigenti politici spetta il ruolo di sintesi e d’indirizzo degli interessi sociali (ricordo che ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”). Riguardo al loro legame con la classe politica si dichiari, come elemento programmatico e identitario, l’incompatibilità “momentanea” (ovvero corrispondente al periodo della carica politica e ai tre/cinque anni successivi) di tutti i futuri dirigenti con incarichi dirigenziali nel pubblico e nel privato. Si ragioni subito su come ridefinire le possibilità di spesa dei soggetti politici in campagna elettorale (e nella loro attività quotidiana) e il loro finanziamento. Se non si spezza, con nuove regole, il filo conduttore tra interessi e politica ne morirà la democrazia: in merito una riforma capace di sancire il conflitto d’interessi sociale in tutte le cariche dirigenziali (ovvero capace di impedire, nel pubblico e nel privato, l’accumulo di cariche dirigenziali) sarebbe l’ideale. Chissà se Monti, su questo ultimo punto, non riuscirà a produrre qualcosa (certo un governo con Passera al suo interno non potrà fare moltissimo, ma mai dire mai). In ogni caso qualsiasi proposta complessiva di riforma di tali rapporti che vada in questo senso contribuirebbe a riavvicinare i cittadini alla politica evitando la trappola populista del singolo provvedimento mediatizzato (ad esempio quello rivolto esclusivamente ad un singolo caso). Affrontando tale problema si prenderebbe anche di petto la questione del, necessario, rinnovamento dei partiti che restano, a patto di una loro trasformazione, degli imprescindibili strumenti di democratizzazione (il che ovviamente non ne esclude altri).
Si inizi subito, senza alcuna paura : il governo di “impegno nazionale”, infatti, nel suo operato contro l’emergenza non risentirà di tali iniziative votate ad una ridefinizione programmatica/identitaria. Oggi la preoccupazione di chi sogna un Paese diverso deve rivolgersi, nella speranza che gli ultimi anni abbiano insegnato qualcosa, alle modalità attraverso le quali cogliere quest’irripetibile occasione per riaprire uno spazio di civiltà. Carpe diem.
{ Pubblicato il: 23.11.2011 }
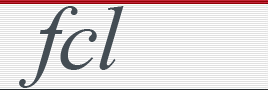


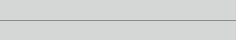

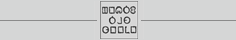




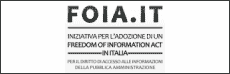



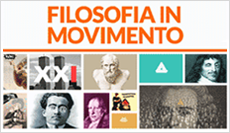


 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.