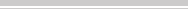gérard prunier
Nessun commento«Sosterremo il nuovo Stato del Sud e noi favoriremo la sua stabilità, perché siamo vicini e resteremo amici», ha dichiarato il presidente sudanese Omar Al-Baschir il 25 gennaio scorso. Qualche giorno prima la popolazione locale aveva massicciamente votato per l’indipendenza. Inedita per l’Africa, questa spartizione «consensuale» mira a mettere termine a decenni di conflitti. Ma lascia in sospeso elementi chiave della stabilità regionale: la spartizione della rendita petrolifera e la delimitazione delle frontiere.
Storico, il referendum che si è svolto nel Sudan meridionale dal 9 al 16 gennaio segna una svolta, non solamente per questo Paese da mezzo secolo straziato dalle guerre civili, ma anche per l’intero Continente africano: per la prima volta, il sacrosanto principio dell’intangibilità delle frontiere derivate dalla colonizzazione è stato messo in discussione.
Dal 1963 e dalla creazione dell’Organizzazione per l’Unità africana (OUA), era comunemente ammesso che i confini – talvolta assurdi – imposti dalle potenze coloniali fra il 1885 e il 1926 non sarebbero stati contestati. Una sola trasgressione era stata riconosciuta: l’indipendenza dell’Eritrea nel 1993. ma l’eccezione era soltanto apparente, perché di fatto si trattava di un territorio colonizzato dall’Italia e poi confiscato dalle Nazioni Unite all’Etiopia nel 1952 (1).
I tentativi di secessione del Katanga (ex Congo belga) nel 1961 e del Biafra (Nigeria) nel 1967 si erano a loro volta scontrati con un rifiuto radicale dell’OUA e dell’ONU. Proclamate più recentemente, nel 1991, le velleità del Somaliland di ritornare a prima della sua fusione con la Somalia italiana (realizzata nel 1960) non hanno trovato una via d’uscita legale, malgrado un’indipendenza di fatto (2). Nel caso del Sudan del Sud la rottura sembra quindi essere radicale: la regione che ha appena votato del tutto legalmente la sua autonomia non è mai stata oggetto di una delimitazione coloniale dei confini.
L’idea prende forma a partire dalla fine della colonizzazione, nel 1956. L’inimicizia fra questi due popoli, uniti con la forza a partire dal 1898 da parte dei colonizzatori inglesi, risale all’epoca in cui i Neri del Sud erano stati perseguitati dai trafficanti di schiavi del Nord. Una parte dei primi aveva optato per la conversione al cristianesimo, allo scopo di mettere in evidenza la loro diversità dall’Islam dei secondi. Ne risultò una colonia sudanese profondamente sfaldata, che gli inglesi nulla fecero per rinsaldare, amministrando le due regioni come entità pressoché separate. Il Nord riceveva la maggior parte degli investimenti sociali ed economici (3).
Iniziata ancor prima dell’indipendenza, la guerra civile durò fino al 1972 e il Sud ottenne un’autonomia abbastanza ampia dopo la firma degli accordi di Addis-Abeba (Etiopia). Il suo governo provinciale, installato a Giuba, gestì le antiche province ribelli del Paese durante una decina d’anni e sembrò che il fossato che minacciava l’integrità del territorio nazionale potesse essere colmato.
Ma le tensioni tornarono quando la compagnia americana Chevron trovò l’oro nero nel Sud, dove attualmente si trova l’85% dei pozzi di petrolio sudanesi. Il presidente dell’epoca, Giafar Al-Nimayri, si dedicò allora allo smantellamento dell’autonomia duramente conquistata: chiusura del Parlamento autonomi di Giuba, abolizione del governo, sostituito da un’amministrazione militare, e tentativo di disarmo dei reggimenti neri dell’esercito. La rivolta scoppiò in maggio 1983; sarebbe durata diciannove anni.
Diretta dal colonnello John Garang, un ufficiale del sud che aveva disertato, l’Esercito di liberazione dei popoli del Sudan (SPLA) si presenta dapprima come movimento antimperialista. Con base in Etiopia – allora governata dal colonnello Mengistu Hailé Mariam, pro sovietico – esso riceve il suo armamento da Mosca. Da parte loro, le autorità di Kartum sono appoggiate dagli Stati Uniti.
Il ruolo della destra religiosa americana
Il crollo dell’Unione sovietica nel 1991 avrebbe potuto assicurare al Nord la vittoria se quest’ultimo, diventato islamico nel 1989, non avesse perso l’appoggio di Washington. Durante tre anni (1991-1994) gli avversari si battono quindi senza sostegni dall’estero. Poi, con la fine dell’apartheid in Sud Africa, Garang riceve un discreto aiuto da Pretoria e dai suoi alleati, fra i quali la Tanzania di Julius Nyerere e lo Zimbabwe di Robert Mugabe.
Infine, gli Stati Uniti decidono di immischiarsi di nuovo nel conflitto: spinto da un’estrema destra religiosa che difende a spada tratta i «cristiani perseguitati del Sud Sudan», il presidente americano George W. Bush costringe i belligeranti a negoziare nel 2002. Firmati tre anni più tardi, gli accordi di Nairobi, chiamati anche Accordi di pace globale (Comprehensive Peace Agreement, CPA), prevedevano fra l’altro un referendum d’autodeterminazione trascorso un periodo interinale di sei anni e mezzo.
Ma tutti quegli anni di guerra hanno finito per ravvivare altre contraddizioni: quelle di un Paese vasto e diversificato, che non si potrebbe ridurre alla semplicistica dicotomia fra il Nord e il Sud. Molte altre regioni – il Darfur, il sud del Kordofan, la provincia del Nilo Azzurro, le colline del Mar Rosso – prendono così le distanze dal «cuore» arabo-musulmano del Sudan centrale, che li ha trattati non meglio di quanto ha trattato il Sud. Queste periferie, popolate da gruppi allogeni molto diversi (ma tutti musulmani), a lungo sono stati considerati come facenti parte di un Nord astratto. Per il colonnello Garang, che non era secessionista, l’approfondimento di queste contraddizioni centro-periferie avrebbe dovuto portare a rimettere in discussione il dominio della minoranza musulmana su tutto il Paese.
Qualche settimana dopo la firma del CPA si era recato a Kartum, dove era stato accolto da una folla entusiasta, in maggioranza araba. Aveva allora creato la sezione nordista del suo movimento, la cui popolarità non aveva smesso di aumentare. Le sue probabilità di vincere le elezioni nel 2010 sembravano essere molto forti. L’esplosione della rivolta del Darfur nel febbraio 2003 confermava d’altronde la pertinenza della sua strategia. Ma Garang è morto in un incidente d’elicottero sui monti Imatong il 30 luglio 2005.
Gli accordi di Nairobi descrivevano con grande dispendio di dettagli una spartizione delle ricchezze, del potere politico e delle forze militari. Spartizione che si sforzava d’essere più neutra e ugualitaria possibile. Durante un periodo di sei anni gli ex nemici dovevano cooperare per «rendere attraente l’unità», prima del referendum previsto per gennaio 2011. Il periodo di sei mesi che sarebbe seguito doveva permettere sia l’impostazione di un «Nuovo Sudan» unito, più democratico e ugualitario (il sogno del colonnello Garang), sia una secessione. Morto Garang, s’impone questa seconda opzione, poiché i suoi compagni riponevano le loro speranze di libertà su una vittoria della spartizione legale (4).
Fin dall’inizio, e malgrado la sua sofisticazione diplomatica e organizzativa, il CPA si rivela un mezzo fallimento. Da un lato, le misure di sicurezza dimostrano un’efficacia reale, malgrado scontri [armati] ripetuti ma alla fine messi sotto controllo; inoltre, l’attribuzione all’amministrazione semi-autonoma del Sud della metà dei profitti petroliferi viene rispettata. Al contrario, la ripartizione del potere politico e amministrativo cambia bruscamente direzione: gli islamici del Partito del congresso nazionale (NCP), che hanno instaurato a Kartum un regime autoritario in seguito al colpo di Stato del giugno 1989, non hanno alcuna intenzione di giocare al gioco del CPA. I ministri del Sud che assumono le loro funzioni nel governo d’unità nazionale installato nella capitale si rendono così rapidamente conto che è loro impossibile esercitare il mandato, a causa del permanente controllo da parte del NCP, di cui sono oggetto. D’altronde una parte di questo fallimento deve essere fatto risalire allo stesso Garang, che ha sempre diretto lo SPLA, diventato nel 1983 Movimento per la liberazione dei popoli del Sudan (SPLM), in modo molto autoritario e che spesso aveva tenuto a distanza i membri della diaspora dotati di buona cultura.
Inoltre le risorse umane disponibili per la guerriglia si rivelano rapidamente insufficienti quando si deve passare alla gestione non di uno ma di due Stati, il governo autonomo del Sud e il governo d’Unità nazionale al Nord. Durante i sei anni del periodo interinale previsto dal CPA, l’NCP non fa che due cose: cercare di trarre il massimo beneficio materiale dallo sfruttamento petrolifero al Sud e tentare di intralciare il governo sudista di Giuba. Quindi nulla viene fatto per rendere allettante l’unità del Paese. In questa situazione, al Sud gli ultimi sostenitori di una soluzione unitaria a poco a poco scompaiono. A partire dal 2009 diventa evidente che il referendum, se avrà luogo come previsto, non potrà condurre ad altro se non all’indipendenza.
Malgrado tutte le pessimistiche previsioni il referendum si è svolto senza incidenti gravi. Tuttavia il risultato – che convalida la secessione del Sud – causerà molte difficoltà.
Le frontiere fra Nord e Sud non sono ancora fissate. Si tratta di una mancanza grave, poiché le zone contestate nascondono una buona parte delle ricchezze petrolifere.
Nessun provvedimento regola i passi da compiere per mettere in chiaro il sistema della cittadinanza nello Stato diviso: che status avranno i milioni di sudisti che abitano al Nord? Il medesimo problema si pone per quanto riguarda la posizione civica delle popolazioni nomadi che esercitano la transumanza fra il Nord e il Sud al ritmo delle piogge e delle stagioni.
Non sono state prese in considerazione le modalità per la ripartizione del debito (38 miliardi di dollari).
Non è stata fissata la ripartizione dei redditi petroliferi.
In molte regioni (territorio di Abyei, provincia del Nilo Blu) le popolazioni che Garang definiva «emarginate» hanno ottenuto il diritto a «consultazioni popolari», destinate a mettere in chiaro i loro rapporti rispetto sia la Nord che al Sud. Ma nulla è previsto per attuarle.
Il CPA nulla ha organizzato per quanto riguarda il Darfur: autoritario, il governo sudanese, che sembrava aver nulla appreso e nulla dimenticato, rifiuta ostinatamente di risolvere il conflitto mediante negoziati internazionali realisti.
Speranze deluse di un sostegno cinese
Alla fine, la complessità stessa del Sudan ha assicurato il buon svolgimento del processo referendario. Effettivamente, lo Stato-NCP deve fare fronte, all’inizio degli anni 2000, a un cambiamento dei rapporti di forze interni. La guerriglia del Darfur si rende consapevole del fatto che le sue divisioni interne la rendono vulnerabile alle manipolazioni di Kartum e inizia quindi a coordinare le sue azioni. Nello stesso periodo le regioni emarginate del Sudan decidono di prepararsi a fare valere i loro diritti con le armi nel caso in cui una secessione del Sud le lasciasse sole in uno scomodo confronto testa a testa con lo Stato in mano al NCP. Allo stesso modo, il settore settentrionale del SPLM comprende di giocarsi il tutto per tutto in questo referendum, che potrebbe spingere a un combattimento decisivo delle forze democratiche contro il regime islamico. Per completare il tutto, la popolazione del Nord constata che i vent’anni di tensioni e sacrifici legati alla guerra civile rischiano di finire con l’umiliazione nazionale di una spartizione che, oltre tutto, farà perdere l’accesso alla sola ricchezza dalla quale trae qualche vantaggio: il petrolio.
In effetti, autoritario e prevaricatore, il regime di Kartum si atteggia a promotore dello sviluppo nazionale. Lo scontento popolare raggiunge allora tale livello che perfino i vecchi partiti politici arabi, consunti da un mezzo secolo di gestione politica inetta, si sentono obbligati a reagire e a integrare le aspirazioni democratiche.
Al Nord non si parla ormai più d’altro che di rovesciare il regime (5). Lo stesso NCP si divide: il vice presidente Ali Osman Mohamed Taha, messo in disparte da un anno perché giudicato troppo moderato, ritorna in scena alla grande, mentre i «duri» del regime si trovano presi alla sprovvista. All’esterno, il vecchio dirigente islamico Hassan Al-Turabi dichiara pubblicamente, in pieno referendum, che il Sudan deve seguire la strada aperta dalla Tunisia. È immediatamente arrestato e le case dei suoi seguaci vengono perquisite.
È vero che il governo di Kartum appare sempre più isolato. Le manifestazioni di solidarietà araba, molto forti quando il presidente Omar Al-Baschir fu incriminato dalla Corte Penale dell’Aja nel 2009, si rivelano effimere (6). Allo stesso modo sono presto deluse le speranze di un sostegno da parte cinese. In effetti, Pechino, che controlla il 50% dell’estrazione del petrolio sudanese e fornisce le armi essenziali al governo di Kartum, non desidera impegnarsi contro la «comunità internazionale» in una grave crisi su una questione che non sembra essere vitale. Di fronte a un Sud male organizzato ma risoluto ad afferrare la chance che aspetta da cinquant’anni, la dittatura del NCP si trova improvvisamente sulla difensiva. Paradossalmente, il dopo referendum si annuncia più pericoloso per il Nord che per il Sud.
D’altronde si deve indubbiamente a questo aumento di senso del pericolo al Nord la grande calma nella quale si è effettuato il referendum. Reso fragile, il presidente Al-Baschir si comporta tutto miele nei confronti del Sud. La sua visita a Giuba, la vigilia dell’inizio delle operazioni elettorali, è stata interpretata nella sorpresa generale come una vera e propria «dichiarazione di pace». Forse il capo dello Stato voleva così disimpegnare le sue retrovie per meglio affrontare la guerra che minaccia il suo stesso feudo. D’altra parte ha fatto una sola richiesta: l’espulsione dei responsabili della guerriglia nel Darfur, che si sono rifugiati nel Sudan del Sud.
I responsabili del Sud si sono affrettati a dargli soddisfazione, troppo felici di acquistare a questo modico prezzo la tranquillità durante la grande consultazione referendaria, che tanto stava loro a cuore. Ciò facendo, il presidente Salva Kiir Mayardit ha praticamente concluso la missione che aveva ereditato alla morte di Garang e ha già annunciato la sua intenzione di ritirarsi, una volta terminati gli scrutini.
Chi gli succederà? In un Sud Sudan ancora giovane politicamente e dove gli appetiti potrebbero facilmente aguzzarsi, queste rivalità sono pericolose. Favorito in una possibile corsa al potere sembra essere il vicepresidente Riek Machar, che dovrà assicurarsi l’appoggio di diversi dirigenti come Pagan Amoun, James Wani Igga et Luka Biong Deng che rappresentano altre tribù (egli è puer) e altre regioni diverse dalla sua (è originario dell’Alto Nilo). Ogni governo futuro dovrà, per essere efficiente e preoccuparsi dell’equilibrio etno-geografico, in un Paese molto frammentato.
L’avvenire resta purtroppo incerto. Effettivamente i problemi non risolti prima del referendum restano sul tavolo, in particolare la fissazione complessiva delle frontiere e la conclusione di un accordo petrolifero. Nessuno può dire che cosa accadrà al Nord, ma è molto evidente che la nervosità di Kartum rende la situazione incerta ed esplosiva. In condizioni difficili dovranno essere negoziate soluzioni di compromesso, potenzialmente gravide di conseguenze. Se pure la sua lunga marcia arriva al termine, il Sud, per rendere concreta e perenne la sua indipendenza, dovrà superare le contraddizioni di Kartum, delle quali si ritrova a essere l’involontario ostaggio.
(1) D’altra parte questo mandato è stato violato quando l’Etiopia ha annesso unilateralmente l’Eritrea nel 1962.
(2) Leggere Alain Gérard, «Faux-fuyants au Soudan», Le Monde diplomatique, juillet 1984
(3) Paradossalmente, le autorità coloniali inglesi non favorirono la cristianizzazione. I missionari furono in maggioranza italiani, americani e franco-canadesi. Londra preferiva trattare con i musulmani, percepiti come più «avanzati» e più facili da amministrare.
(4) Garang aveva avuto sempre molta difficoltà nel «vendere» la sua visione unitaria ai suoi compagni d’armi, istintivamente secessionisti. Soltanto la sua autorità personale e un crescente interesse dei musulmani oppositori del regime islamici gli avevano permesso d’imporla.
(5) Leggere Jérôme Tubiana, « Poker menteur au Soudan», Le Monde diplomatique, juillet 2010.
(6) Leggere Anne-Cécile Robert, «Le président soudanais face à la justice internationale », Manière voir, n° 108, «Indispensable Afrique », décembre 2009-janvier 2010.
(traduzione dal francese di José F. Padova)
{ Pubblicato il: 04.03.2011 }
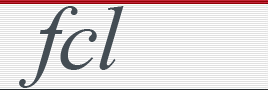




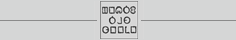




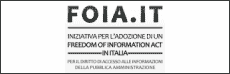






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.