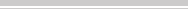dino cofrancesco
Nessun commento
["Il legno storto", 27 marzo 2011]
Nel corso di una trasmissione radiofonica in onda la mattina su RadioTre, un critico esperto di simboli politici (che, però, mostrava di ignorare le ricerche di Giorgio Fedel, lo scienziato politico che a questo tema ha dedicato, in Italia, gli studi più approfonditi) ha messo in guardia dalle nuove ondate di razzismo che si starebbero abbattendo sugli Stati Uniti, nonostante (o, forse, proprio a causa de) l’elezione di Barack Obama alla Casa Bianca. A sostegno di tale inquietante rigurgito di barbarie ha citato i movimenti di... Tea Party, evidentemente da lui assimilati al Ku Klux Klan. Le sue parole mi hanno raggelato il sangue nelle vene, facendomi sentire come il rinoceronte di Eugène Ionesco. Come il protagonista della pièce teatrale si ritrovava ad essere l’unico uomo rimasto sulla terra a giudicare orrendo il corno sul naso, così io mi sono ritrovato ad essere uno dei pochi sopravvissuti a conservare il senso dell’orrore totalitario.
Giacché, a pensarci bene, assimilare le manifestazioni di un libertarismo economico estremo – e persino anarco-capitalista – al razzismo significa, né più né meno, essersi impadroniti violentemente del linguaggio e dei suoi simboli, sottraendolo definitivamente all’uso critico della ragione, che è il contrassegno più inequivocabile della sindrome totalitaria. Grazie a quest’audace colpo, i ‘soliti noti’ stanno imponendo il principio in base al quale tutto ciò che non è, a loro avviso, politically correct, deve sprofondare nella palude stigia della reazione e del nazismo. L’onesto e competente Oscar Giannino, gli amici dell’Istituto Bruno Leoni – di cui peraltro condivido solo in parte l’impegno civile e culturale – in quanto espressioni italiane del Tea Party perdono, sotto il profilo morale – almeno e per ora – ogni diritto di cittadinanza. Se si vogliono meno tasse è perché si pensa alla ‘tratta degli schiavi’, se si vuole rivedere il Welfare State è perché si progetta una nuova forma di apartheid.
Forse sto esagerando e, come spesso mi capita, do troppa importanza a cretinate raccolte qua e là sui giornali, nelle aule universitarie, nei dibattiti radiofonici e televisivi. Sennonché, a forza di trascurare i segni della malattia, si rischia di ritrovarsi nella categoria degli inguaribili. Per la verità, non penso, per ingenito pessimismo, che ci si possa ancora salvare; ma ritengo irrinunciabile per la salvaguardia della nostra libertà e della nostra dignità conservare, fino all’ultimo, lo sguardo lucido evitando le consolazioni alle quali ci hanno abituato lo storicismo laico e quello cattolico.
Ebbene il dovere della veridicità ci avverte che, al di là delle retoriche edificanti, delle teorie normative alla John Rawls, ai nuovi contrattualismi e alla rinascita del repubblicanesimo, è radicalmente cambiato il concetto di democrazia. Quest’ultima non è più (o, forse, da noi non è mai stata) la registrazione di ciò che vuole o teme la gente comune e la sua ricezione da parte di Parlamenti liberi di emanare qualsiasi tipo di legge che non violi alcuna norma costituzionale, ma è il perseguimento del benessere e della felicità per tutti, tanto più raggiungibili quanto più i cittadini saranno stati ‘rieducati’ e redenti spiritualmente ovvero avranno imparato a reprimere i loro istinti egoistici e le loro pulsioni antisociali. Questo ‘stile di pensiero’, è inutile nascondersi dietro un dito, piaccia o no, è iscritto nella Costituzione della Repubblica «fondata sul lavoro». Nata dall’incontro delle tre grandi culture politiche dell’Europa continentale – le teorie socialiste, le dottrine sociali della Chiesa, il liberalismo garantista – lo spirito della nostra ‘Magna Charta’ delegittima eticamente e culturalmente tutto ciò che si allontana dall’impegno solidaristico, dall’altruismo, dalla protezione delle categorie più deboli. Chi vuol pagare meno tasse, implicitamente, intende dare minori risorse agli ospedali, alle scuole, ai musei, agli istituti previdenziali etc. Nell’immaginario collettivo dei giuristi engagés tale comportamento asociale è sempre meno distinguibile – ripeto: sul piano dei valori – dall’attentato alla libertà di stampa e di associazione. “Prendere sul serio” i principi che stanno a fondamento della Costituzione significa prenderli en bloc, non tollerare deviazioni e infrazioni né in senso antiliberale né in senso antisociale. E’ il trionfo della mentalità azionista, non ovviamente dell’azionismo storico – che fu movimento assai complesso, frastagliato e contraddittorio – ma di quell’attitudine potenzialmente totalitaria che, avendo stretto con nodo indissolubile tutte le cose buone, non riesce più a giustificarne il presentarsi l’una in conflitto all’altra. Se il liberalsocialismo o il socialismo liberale hanno risolto il contrasto tra eguaglianza e libertà, che bisogno c’è più di un partito liberale, che difende la libertà senza far caso all’eguaglianza, o di un partito comunista, che si batte per l’eguaglianza ma è disposto a sacrificarle la libertà? E’ questa mentalità che – indipendentemente dai costituenti del Partito d’Azione spesso critici nei confronti dei singoli articoli – ha posto il suo suggello indelebile sulla Costituzione italiana, facendone non un “codice della convivenza” ma l’espressione più alta della “riforma morale e intellettuale” degli italiani.
In virtù di questo suo carattere, se un partito (che non sarebbe, comunque, il mio partito) venisse a disporre di un seguito di massa, inalberando la bandiera dello “Stato minimo” e presentando un programma che Friedrich A. Hayek avrebbe sottoscritto punto per punto, difficilmente potrebbe evitare una vera e propria guerra civile. Si pensi soltanto a quanto accadrebbe – moti di piazza, interpellanze parlamentari, manifesti degli intellettuali etc. – nel caso che tale partito, ottenuta la maggioranza dei suffragi elettorali, intendesse abrogare lo Statuto dei lavoratori che, formalmente, non essendo legge costituzionale, è rivedibile come qualsiasi altra legge ordinaria ma che, sostanzialmente, in virtù della filosofia neo-azionista, è diventato un “diritto non disponibile”.
Se questi rilievi colgono nel segno, ci troviamo in presenza di una “nuova democrazia”, per così dire, “unidirezionale”, nel senso che, sulla base dei suoi parametri di valore, “avanti c’è posto” ma “indietro non si torna”: il confronto politico legittimo riguarda i mezzi, i tempi, i modi del “progredire” ma non può tollerare quanti intendono “regredire” (poi, di fatto, li tollera ma come misura prudenziale, al fine di evitare la violenza politica e le sue spiacevoli conseguenze sul piano di una civile convivenza). Insomma una “democrazia”, che consenta alla destra di governare, non è concepibile: il campo di calcio è aperto solo a determinate squadre, quelle che vogliono le stesse cose ma dissentono sulle “velocità” ossia sulle tattiche da seguire.
Ho l’impressione che, al di là dei limiti umani e caratteriali di Silvio Berlusconi, al di là del suo discutibile (e dissoluto) stile di vita privato e, soprattutto, al di là della sua oggettiva mediocrità di statista – la sua indiscussa capacità imprenditoriale si manifesta nella politica aziendale e nell’organizzazione delle macchine elettorali molto di più che a Palazzo Chigi – l’odio che si riversa sul Cavaliere trovi una vera spiegazione nel suo richiamo a un principio di legittimità politica che non solo ha sostituito, come hanno visto bene Gianni Baget-Bozzo e Giorgio Fedel, l’appello diretto al popolo (tendenzialmente plebiscitario e sondaggistico) al simbolo antifascista e resistenziale, ma ha fatto qualcosa di più e di “peggio”: ha rimosso e svilito la Costituzione non in quanto elenco di articoli ma in quanto espressione di una sintesi politica divenuta insoddisfacente – almeno per un’ampia parte del “paese reale”.
I vari Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky hanno ragione: Berlusconi è un nemico “oggettivo” della Costituzione ma non perché intende rivederne talune norme (col ‘Titolo V’, i Giuliano Amato e gli altri amici di Rodotà e di Zagrebelsky non hanno cambiato il testo, l’hanno “stravolto”...) bensì per il fatto che rappresenta il guastafeste di quell’idillio comunitario che i partiti della Resistenza avevano tacitamente instaurato. La sua “discesa in campo” prefigura un mutamento drastico di paradigma: il “rischio” che non sono più la democrazia e il liberalismo a dover presentare le loro credenziali alla Costituzione ma è la Costituzione a doversi sottoporre alla democrazia e al liberalismo e a dover giustificare le sue carenze – dalla mancanza dell’habeas corpus all’ambiguo riconoscimento del diritto di proprietà. Dinanzi a tale rischio i contrasti del passato sembrano liquefarsi come neve al sole: basta assistere a una riunione di ex democristiani e di ex comunisti nei tanti organismi, enti, associazioni che li vedono collaborare d’amore e d’accordo per leggere nei volti la domanda: «ma come abbiamo potuto rimanere per tanti anni ostili e divisi?». A rendere impossibile un rapporto ancora più stretto è solo l’incapacità della sinistra di elaborare una strategia unitaria, ma al di là della continua frammentazione in correnti e in partiti, a unire gran parte dei “cari nemici” di un tempo non è l’indignazione morale per il gossip di Villa San Martino ma la grande peur di un’invasione barbarica – PDL e Lega – in grado di sovvertire tutte le logiche consociative del passato, mettendo a repentaglio antiche e recenti rendite di posizione.
Non vorrei essere equivocato. Berlusconi non ha molto a che fare con Friedrich A. Hayek, con Karl R. Popper o con Ludwig von Mises. Intimamente è un “doroteo”, più disposto a seguire Gianni Letta che Antonio Martino (il che non è necessariamente un male, se si pensa a certe rigidezze dogmatiche degli ultras del liberismo) ma, indipendentemente dal giudizio di valore che se ne voglia dare, la sua figura è quella di un picconatore che minaccia di radere al suolo quanto i padri costituenti, nobili antenati di Rodotà e Zagrebelsky, hanno costruito e trasmesso agli eredi in oltre mezzo secolo di postfascismo. Sennonché riconoscerlo comporta l’ammissione di una “idea bloccata” di democrazia, di una teoria e di una pratica che sarebbero profondamente imbarazzate se un partito di massa di ispirazione hayekiana andasse al governo. Ne deriva la necessità di una “sintesi negativa” che, in qualche modo, squalifichi irrimediabilmente il new deal liberale (non lo chiamo “rivoluzione liberale”, non amando gli ossimori) mettendo assieme tutte le cose cattive: l’edonismo, la concorrenza selvaggia, l’individualismo anticristiano, la deregulation con le sue vittime, lo sfruttamento intensivo del pianeta, il consumismo vorace e suicida, le minacce ai giudici e alla Costituzione, la rinascita del qualunquismo, il populismo plebiscitario, la difesa sfrontata dei privilegi, l’allargamento intollerabile della forbice dei redditi etc. Per civettare con il linguaggio dei vecchi idealisti, Ruby e le escort, in virtù di quella sintesi, diventano la “verità nascosta” di Hayek, l’esito obbligato di un percorso involutivo che comincia dalla Scuola di Chicago e termina ad Arcore. Se vien meno il mondo ideologico di Paolo Flores d’Arcais e di Nadia Urbinati non c’è più scampo: si ritorna allo stato di natura in cui è consentito tutto e domina incontrastata la forza – oggi rappresentata dai mezzi di imbonimento di massa delle tv commerciali.
Di qui la battaglia su due fronti: da un lato, i reparti d’assalto della “cronaca nera” che, in simbiosi con le procure giacobine, infilano uno scandalo dietro l’altro, accumulando fotografie e filmati osceni del Satyricon brianzolo; dall’altro, i fondamentalisti del “socialismo liberale”, i neo-azionisti, che non riescono neppure a concepire un pacato confronto con i teorici del liberalismo economico antistatalista. In tal modo, il direttore di Critica Liberale può giudicare Hayek: «un autore secondario [sic!], di cui è più che legittima l’emarginazione dal pantheon del liberalismo novecentesco», mentre, sul Secolo XIX, un “opinionista di MicroMega” può scrivere che i «bolscevichi della libertà» (i seguaci di Hayek) «costituiscono una sorta di setta (non di rado attraversata da furiosi conflitti interni ma sempre con evidenti vantaggi personali di appartenenza: saranno i banchieri svedesi a determinare l’attribuzione del premio Nobel a Hayek nel 1974) che svolge la sua ‘predicazione' sostenuta dall’establishment finanziario internazionale, fornendo il modello ai numerosi think-tanks conservatori che si costituiranno negli anni successivi a servizio della nuova egemonia di classe». Un’analisi, questa, assai più impietosa di quella dedicata all’economista austriaco da Augusto Illuminati sul Manifesto, a dimostrazione del fatto che, quando la borghesia radical chic ci si mette, Lenin diventa un riformista di destra. Quello che ci interessa, però, non sono queste farneticazioni ideologiche ma il fatto che quando gli avversari diventano “il blocco storico degli impauriti e degli abbienti”, interessati soltanto allo “accantonamento della spesa sociale” e a “una clamorosa opera di trasferimento della ricchezza alla fascia più alta della società”, in base a quale logica istituzionale dovrebbero poi venire rispettati come credibili interlocutori politici e si dovrebbe riconoscergli il diritto di guidare un governo, solo perché “abbienti” e “impauriti” li hanno votati in maggioranza? Se il fascismo non è il convincimento tetragono di “stare dalla parte giusta”, di essere l’incarnazione di un interesse superiore agli interessi individuali e insieme la criminalizzazione etica (ma in Italia anche giudiziaria) degli avversari, che cos’è tutto questo se non fascismo?
Per queste ragioni preoccupa la piega che da tempo sta assumendo la lotta politica in Italia. Qui non si tratta di stare con Berlusconi (personalmente lo voterei solo se costretto a scegliere tra lui e Di Pietro), o con Bersani, ma di stabilire se c’è diritto di cittadinanza per le posizioni politiche dell’uno o dell’altro, se il momento welfaristico della Costituzione è scritto a caratteri di bronzo o se, al contrario, è un semplice ornamento retorico – spiegabile negli anni della caduta del fascismo e di una violenta guerra civile – che non obbliga ad “andare avanti” ma non impedisce neppure di “tornare indietro” (sempre nel rispetto rigoroso dei “diritti di libertà” e dei “diritti soggettivi”) qualora sia questa la volontà della maggioranza degli elettori.
Tornando alla trasmissione radiofonica da cui siamo partiti, identificare razzismo e Tea Party non è privo di logica ma è la logica di una guerra spietata, di uno “scontro di civiltà”. Stiamo forse assistendo al divorzio tra “democratismo” e “liberalismo” – che, in tutti i paesi dell’Occidente, nel secondo dopoguerra, si erano uniti in matrimonio assumendo la denominazione comune di “democrazia”, intesa come “liberaldemocrazia” – ma questa volta le masse non stanno con gli amici del demos bensì con quanti, almeno a parole, promettono più libertà anche a costo di socchiudere un poco la porta dell’eguaglianza. Se gli sconfitti non si rassegnano e dai loro insuccessi non ricavano utili lezioni e un serio impegno all’esame di coscienza, la parola rischia di passare dalle urne alle piazze, dimenticando l’amara costatazione del vecchio leader socialista: “piazze piene, urne vuote!”. E’ una prospettiva che, però, non sembra spaventare i talebani della Costituzione materiale: nei loro sogni, sarà il potere giudiziario ad assumersi l’incarico di realizzare il Progetto Democrazia, dal momento che gli eletti dal popolo sono inaffidabili, in quanto irrimediabilmente corrotti e corruttori. Toccherà, quindi, ai magistrati dover stabilire cosa intendere come “giusta causa di licenziamento”, come e quando risarcire il contadino i cui ruscelli sono stati inquinati da una fabbrica vicina (“che dà lavoro a centinaia di operai”), quale priorità assegnare a un caso giudiziario piuttosto che a un altro (salvo restando, ovviamente, l’obbligatorietà del procedimento penale), come va definito e difeso “l’interesse collettivo”. In quest’ottica, la democrazia elettorale, siamo sempre lì, è una cosa buona se prende decisioni buone: se non le prende è giusto che ceda lo scettro della sovranità a quanti, invece, sono in grado, per saggezza, cultura e disinteresse personale di interpretare e farsi carico della volontà generale.
{ Pubblicato il: 28.03.2011 }
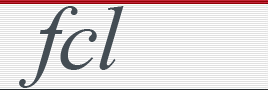




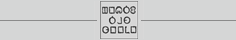




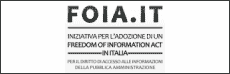






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.