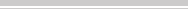gim cassano
Nessun commentoMi permetto di citare, al riguardo, un intervento dell’amico Mario Saccone (del 15 Marzo di quest’anno), che ritengo estremamente pertinente, col quale egli è intervenuto in una discussione apertasi sulla mailing list del Circolo Rosselli di Milano, proprio su questi argomenti.
Afferma dunque Mario Saccone:
<<…..debbo ribadire che la diseguaglianza dei punti di partenza non è un problema astratto, è il problema concreto che incontrano oggi tutti quelli che hanno obiettivi ed idee da realizzare, imprese (non solo economiche, ma anche culturali, scientifiche, sociali) da intraprendere e che non appartengono a ceti “privilegiati”. Un grande risultato che i nostri padri, operai, contadini, artigiani, con le loro lotte hanno ottenuto è stato che oggi i loro figli non combattono solo più per la sopravvivenza (per quella c'è sempre da combattere) ma associano sempre più la loro sopravvivenza ad idee, progetti, ambizioni.
Il non rendersi conto della maturità e della modernità di questo stato di cose, che tra l’altro inizia in Italia, in molti settori, già dagli anni 70, è tipico della sinistra che è rimasta al solo lavoro operaio, mentre oggi lo sfruttamento del lavoro nelle aree di capitalismo avanzato, come è in parte l'Italia, riguarda sempre di più il lavoro fatto con la testa e quindi coinvolge sempre di più i lavoratori nei contenuti del loro lavoro, con una contraddizione tra capacità, obiettivi e scopi che è la vera caratteristica del nostro tempo.
Le forze politiche non si rendono conto di quello che è oggi il precariato, che non è caratterizzato solo dalla mancanza del posto fisso, ma ancor prima proprio dalla diseguaglianza dei punti di partenza, perchè è da lì che il figlio di un operaio o di un impiegato inizia a verificare nella mancanza di capitale economico e sociale la propria inferiorità sociale.
Cito un episodio che credo importante. Prima delle primarie [del centrosinistra al comune di Milano] i 4 candidati sindaci della sinistra si sono incontrati alla Casa della Cultura con i precari organizzati. Hanno iniziato tutti e quattro con il solito discorso della lotta al precariato, con le frasi fatte che fanno parte ormai dello sciocchezzaio della sinistra. La risposta dei precari è stata chiara e semplice. Si certo c'è in Italia un precariato pretestuoso che va cancellato, ma credere che si possa abolire una realtà che è profondamente inserita negli sviluppi della produzione capitalista, in primis nel fatto che oramai il lavoro intellettuale fa parte integrante della produzione capitalista, vuol dire fare solo demagogia.
Ciò di cui i precari hanno bisogno è un welfare responsabile, che copra i periodi di non lavoro e permetta loro l'adeguamento professionale continuo che le aziende ormai non si accollano più ed è il supporto alle loro iniziative “imprenditoriali”. Si imprenditoriali, perchè oggi i 2 o 3 ragazzi che mettono su una srl per lavorare nell'informatica, nella comunicazione, nel marketing, sono imprenditori, perchè oltre al lavoro tecnico gestiscono anche delle imprese con tutti i problemi connessi e le competenze, esclusa quella dello sfruttamento del lavoro degli altri, perchè sono sfruttati ne più ne meno dei loro colleghi impiegati produttivi a tempo indeterminato e degli operai.
Certo Marx non ha mai parlato di sfruttamento del lavoro intellettuale, ne di imprenditori sfruttati, ma di Marx ci interessa la lettera della parola o il metodo di ricerca e di analisi che ci ha lasciato? La lettera della parola è tutta ben catalogata nel marxismo leninismo, nel materialismo scientifico ed in simili assurdità di cui Marx non ha nessuna responsabilità, perchè quelle parole le usava in contesti ben diversi. Il metodo è ancora vivo e lo si ritrova dovunque ci siano persone che studiano la realtà e non i dogmi. C'è più Marx in uno studioso del precariato come Sergio Bologna (a cui rimando per la comprensione del precariato oggi in Italia) che mai lo cita e mai lo prende a garante delle sue conclusioni, che in tutti i “ragionamenti” marxisti della sinistra marxista e post marxista da Fausto Bertinotti a Nichi Vendola>>.
Con le manifestazioni del 9 Aprile si è aperto uno squarcio su questo mondo, la cui attuale estensione non è motivabile solo con la sostituzione di forme consolidate e tradizionali di lavoro dipendente con altre, ritenute più convenienti (per ragioni di basso costo, minori tutele, maggiore flessibilità) dalle imprese. A questo si aggiunge anche il peso crescente di “nuovi” lavori e figure professionali, che difficilmente sono inquadrabili nelle categorie tradizionali del lavoro subordinato. La caratteristica peculiare e che accomuna queste situazioni, sia che sostituiscano lavoro subordinato di tipo tradizionale, sia che riguardino prestazioni specialistiche e di natura intellettuale o persino microimprese, è quella dell’abbinamento tra le basse retribuzioni o compensi, la nessuna certezza contrattuale, e la scarsissima tutela giuridica.
Ora, anche se è vero che la maggior parte del precariato rimpiazza lavoro dipendente, a costo basso e tutele zero, all’aspetto economico e normativo si aggiunge anche la distanza tra il ruolo svolto nel processo produttivo e le aspirazioni: si tratta in gran parte di giovani qualificati, che hanno tentato o aspirano al “mettersi in proprio”, o quanto meno a rapporti di lavoro subordinato dignitosi e nei quali intelligenza e sapere abbiano un ruolo significativo. Ciò, oltre alla non-autonomia ed all’incertezza economica, conduce a forme di rapporti alienati che travalicano quei confini della fabbrica e della catena di montaggio, a partire dai quali Marcuse aveva avviato la sua critica della società moderna, e che riguardano anche settori non piccoli della lower middle class.
La risposta alla complessità di questo fenomeno non può stare solo nelle ricette tradizionali dell’operaismo di sinistra, cioè nel non consentire forme di lavoro non rispondenti a determinati canoni, e quindi di richiedere la generale omologazione al modello del lavoro subordinato a tempo indeterminato come unico mezzo per affermare la dignità del lavoro. Bisognerebbe, intanto, rendere per le imprese meno appetibile sul piano retributivo e contributivo il lavoro precario, e di estendere al lavoro precario le tutele sociali. In altre parole: se l’impresa trova utile il ricorso a forme di lavoro precario in ragione della flessibilità, non può unire a questa utilità anche quella del minor costo retributivo e contributivo (e quest’ultimo dovrebbe essere destinato unicamente all’estensione delle tutele e della previdenza dei precari) rispetto alle forme di lavoro tradizionali. Altrimenti, l’inevitabile sbocco, confermato dall’esperienza attuale, è il precariato a tempo indeterminato.
Altra questione è quella del lavoro intellettuale e professionale che si maschera sotto le varie forme di praticantato, che richiederebbero una regolamentazione che stabilisca diritti, doveri, durate, livelli minimi di retribuzione.
Ed altra questione ancora è il diffondersi di micro e piccole imprese, spesso a carattere individuale, soggette alle imprese maggiori; fenomeno anch’esso connesso alle esigenze di flessibilità e di trasformare in costi variabili aliquote crescenti di costi fissi. E, in più, connesso alla possibilità di non doversi far carico diretto di questioni, norme e prescrizioni di diritto del lavoro, di sicurezza, ambientali, etc. In questo campo possiamo trovare di tutto: dalle microimprese fornitrici di apporti materiali o immateriali di elevato contenuto tecnologico e di conoscenza, a volte ad elevata intensità specifica di capitale, sino a quelle che rimpiazzano servizi o produzioni di contenuto tecnologico povero ed a bassa intensità di capitale, che forniscono essenzialmente lavoro. In altre parole, si va da chi fornisce software, processi industriali, o componenti sofisticati, a chi fornisce servizi di pulizia.
Comune a queste imprese è lo sbilanciamento nei rapporti contrattuali, che non si manifesta solo nella questione delle condizioni di pagamento, ma nella forma stessa del rapporto, che prevede impegni vaghi da una parte e stringenti dall’altra, clausole di rescissione unilaterali, diritti di esclusiva, prezzi-capestro. E comune a queste imprese è il fatto di non avere adeguata tutela giuridica e sindacale: la prima è affidata ai principii generali del Codice Civile(salvo le deroghe contrattuali), del diritto commerciale e fallimentare ed alla prassi della giustizia civile italiana; la seconda, semplicemente non esiste.
Per questa via, non viene posta al di fuori dell’impresa maggiore solo una parte della produzione e/o dei servizi connessi, ma anche una parte del conflitto sociale, del rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, di quelle sui diritti del lavoro, senza che ciò trovi adeguato corrispettivo contrattuale ed economico. Questa è un’ulteriore forma di precarizzazione, se vogliamo indiretta, ma non per questo meno evidente: quante volte decine di dipendenti si sono trovate all’improvviso senza lavoro perché la piccola impresa da cui dipendevano ha visto di punto in bianco rescisso il proprio contratto, magari sostituito da uno analogo ed a prezzi inferiori con un’altra piccola impresa?
Se è vero, come riporta Saccone, che questa tipologia di imprese riguarda milioni di imprese e 9 milioni di lavoratori non sindacalizzati, credo che una sinistra moderna, e ripeto moderna (termine che non piace ad alcuni), debba porsi qualche domanda al riguardo. Oppure la loro utilità economica e sociale non deve interessarci?
{ Pubblicato il: 14.04.2011 }
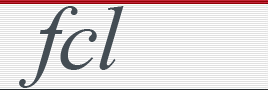




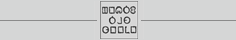




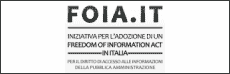






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.