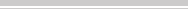pierfranco pellizzetti
Nessun commentoIndigna ma non deve stupire troppo l’applauso di solidarietà dell’assise confindustriale di Bergamo all’AD di Thyssen, condannato a sedici anni dal tribunale di Torino per l’omicidio volontario di sette operai arsi vivi nella notte del 6 dicembre 2007. Al massimo ci si potrebbe stupire per la macroscopica improntitudine evidenziata, in un soggetto della rappresentanza sotto i riflettori e che buon senso avrebbe dovuto suggerirgli almeno l’abituale pratica dell’ipocrisia, non delle ragioni che determinano una tale esplosione di cieca protervia.
Il fatto è che ormai da decenni Confindustria è un’organizzazione a tutela di uno status privilegiato e sempre meno una parte sociale che promuove le ragioni del fare impresa, dunque un ruolo, nella lotta da tempo in corso anche nel nostro Paese tra insiders contro outsiders, tra abbienti e poco o nulla tenenti.
Perché a Bergamo è risuonato il sempreverde richiamo della foresta che faceva dire al senatore Giovanni Agnelli Sr. che «la Fiat è governativa per necessità». Un richiamo di classe. Il poeta Edoardo Sanguineti avrebbe chiosato: «odio di classe». Non “dal basso”, ma “dall’alto” dei piani della società.
Questo perché l’autopercezione e il sistema di alleanze proprio del ceto padronale italiano sono sempre dipesi dalle logiche dell’appartenenza in chiave difensiva, più che dalla fierezza di una funzione sociale esercitata.
Va detto che ci fu un breve momento, all’inizio degli anni Settanta, in cui questo antico riflesso condizionato venne temporaneamente messo da parte e l’allora Presidente di Confindustria, Giovanni Agnelli jr., lanciò la generica parola d’ordine della “alleanza dei produttori”, riassunta nello slogan “profitto e salario contro la rendita”. La stagione del famoso Patto dell’EUR tra imprenditori e sindacati, allora rappresentati dalla trimurti Lama – Storti – Vanni, che modificò la scala mobile in una logica di ripresa dello sviluppo. Una stagione appassita rapidamente.
I presunti industriali “produttori” ben presto rifluirono nel campo dei possidenti, evidenziando che le loro reali identificazioni erano nei comuni interessi delle categorie agiate, più che in quelli delle altre componenti dell’impresa; soprattutto quei “colletti blu” da tenere a bada. Visto che gli industriali tornarono a rendersi conto rapidamente di un’antica verità: l’unica condizione con cui sapevano di poter reggere il confronto competitivo era quella che consentiva di abbattere i fattori di produzione (dunque, la compressione del costo lavoro) e di foraggiarsi con vantaggi a spese della collettività (finanziamenti, protezioni dal mercato e ammortizzatori vari. Dunque un rapporto collusivo con la classe politica). Alla faccia della tanto strombazzata “innovazione” o dell’Araba Fenice chiamata “politica industriale”. Pura chiacchiera da convegno, tenuto conto che il mix produttivo in cui il nostro sistema si è specializzato è in larga misura composto da prodotti maturi a contenuto tecnologico basso/bassissimo, dunque facilmente imitabile. E imitato, come conferma palesemente la caduta dell’export italiano.
Sicché nell’organismo di rappresentanza imprenditoriale prevalgono logiche puramente difensive e la ragione associativa è in larga misura quella dell’appartenenza. La ragione per cui in questo Paese hanno un peso spropositato gli associazionismi a certificazione e tutela dell’immobilismo sociale. Da club esclusivi di bennati, che ancora operano alla luce del sole (i vari Rotary e Lyons), per arrivare a realtà “coperte” come le varie massonerie laiche e clericali (vedi l’Opus Dei). In buona parte, confraternite che ruotano nell’ampia costellazione reazionaria del berlusconismo.
Confindustria non è troppo distante da questo modello, e l’applauso a Herald Espenhahn di Tyssen non è altro che l’espressione “di pancia” di questo spirito da confraternita che si stringe protettiva attorno “a uno dei nostri” minacciato. Una minaccia che domani potrebbe colpire altri di noi. Noialtri contro gli altri.
“Arciconfraternite”, le chiamava qualcuno un tempo. Al tempo in cui la società era più fluida e si scioglievano i grumi che fungevano da meccanismo bloccante. Era il tempo in cui il conflitto sociale faceva venire alla luce le resistenze oligarchiche al cambiamento e imponeva compromessi non meramente difensivi dello status quo. C’è da chiedersi come sia andata, come questa stagione sia finita. Certo, la ripresa di antiche relazioni di scambio tra ottimati e ceto politico in chiave di desertificazione del conflitto (nel Parlamento come altrove) ha svolto egregiamente il proprio ruolo. Ma anche la trasmigrazione nel campo del controllo sociale dei vertici di numerose organizzazioni di rappresentanza degli interessi degli insiders (qualcuno pensa maliziosamente a qualche sigla sindacale?) ha dato una bella mano all’involuzione. Con effetti devastanti per la democrazia industriale. Per la democrazia tout court.
{ Pubblicato il: 11.05.2011 }
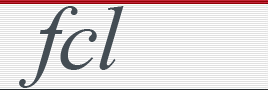




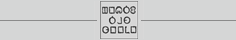




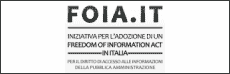






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.