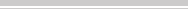stefano pietrosanti
Nessun commentoTra le varie posizioni che si possono assumere nell’ambiente politico delle democrazie occidentali, quella della sinistra liberale è particolarmente complessa. La numerosità dei significati che le si possono attribuire – a partire dall’interpretazione della parola “sinistra” e della parola “liberale” cui si voglia aderire – costringono chi si dichiari concorde con essa a definire con cosa, effettivamente, egli concordi. Questo esercizio, che può ambire a un valore universale quale suggerimento di una possibile interpretazione sistematica se svolto da un esperto del pensiero politico, credo possa avere un suo valore anche se svolto da un cittadino interessato e impegnato, per quanto non professionale. Ciò mi propongo con quanto segue, non una panoramica che voglia inquadrare il soggetto, ma un’istantanea molto ravvicinata di alcune suggestioni: quanto per prima è saltato agli occhi di una persona nata all’alba del crollo dell’Unione Sovietica, che ha voluto osservare e vivere i fatti della politica da questa prospettiva.
Queste suggestioni, il reagire tra fatti e stralci di libri, mi hanno posto il bisogno di riflettere meglio sul concetto di “conservazione” e “conservatorismo”, apparentemente lontano dalle posizioni che ho assunto e che tanto viene maltrattato – quantomeno in Italia – su riviste, giornali e nei discorsi dei principali gruppi che si preparano ad affrontare il confronto elettorale. Molto è dovuto all’incontro con gli scolii di Dávila, pensatore reazionario sudamericano, frequentato in Italia principalmente da suoi omologhi, o da liberisti estremi che probabilmente ne apprezzano il pessimismo radicale. Prescindendo da ciò, è interessante leggerlo come rarissimo esempio di reazionario moderno lontano dai toni allucinati dei totalitarismi europei e dei misticismi di destra americani. Cattolico e solitario, probabilmente per questo in grado di osservare gli ideali che professava come qualcosa ancora in grado di vita non mostruosa ma feconda, risparmiò ad essi l’ignominia di essere difesi col tono della bestia ferita. In lui si verifica l’esempio di reazione come conservatorismo sconfitto, che parla la lingua del conservatore con la tristezza di un caduto.
Per prima cosa è però necessario chiarire i termini: il conservatorismo di cui si sente parlare il più delle volte è inteso o come la difesa dello stato delle cose dove esso abbia un radicamento nel passato, per semplice paura del cambiamento; o la difesa delle posizioni di potere da parte dei pochi contro i più. In entrambe i casi, sono nemici auto-costruiti, posti in posizioni indifendibili per ottenere facili vittorie retoriche. Utili magari alla singola persona nel definire ciò che non apprezza, pienamente fuorvianti dove si voglia fare una discussione meno attenta al breve termine.
In questo riflettere intendo la parola “conservatorismo” come lo sforzo di conservare determinati principi di fondo, nodi ideali che chi si impegna in questo sforzo ritiene fondamentali per preservare ciò che ama della realtà in cui vive, o per avvicinare questa realtà a un’ideale già vivo e rispettato, che si sostiene. Non può avere per obiettivo l’intero stato di cose, o il proprio ristrettissimo particolare – faccende radicate nel ben più semplice slancio di sopravvivenza – ma determinate istituzioni, consuetudini e i loro significati, integrali disposizioni verso la vita nella loro incarnazione politica.
Credo tutto ciò riguardi profondamente il ruolo che la sinistra liberale ha compiuto e compie, quantomeno nell’Europa continentale. Sono convinto che, in questa realtà, la sinistra liberale sia sulla faglia tra conservatorismo e progressismo, costretta a prendere coscienza di entrambe le sue nature e segnata da difficoltà e contraddizioni che hanno radice nella complicata nascita del sistema che le è proprio, quello della democrazia moderna, idealmente tutrice delle libertà private e pubbliche. Il travaglio che ha caratterizzato questa nascita, sul Continente, è il crollo violento dell’antico regime, la vittoria della rivoluzione francese.
La caduta dell'antico ordine portò con se un trauma che fu un momento poetico, un momento fondativo dell'Europa continentale come comunità politica. La rivoluzione, con i suoi errori e dolori, ebbe il merito di aprire un'epoca, “un repertorio di tendenze positive e negative (...) un sistema di sottigliezze e chiaroveggenze unito a un sistema di rozzezze e cecità.” (Ortega y Gasset, 1924). Dischiuse un'intera “era rivoluzionaria”, che si concluse con la prima guerra mondiale.
Dieci anni dopo l'inizio di questo scontro - la guerra civile europea per eccellenza - Ortega y Gasset scriveva “Il tramonto delle rivoluzioni” e poteva ragionevolmente affermare che “niente qualifica meglio l'età che albeggia sul nostro vecchio continente che il constatare che in Europa sono finite le rivoluzioni.” Questo calo di tensione, questa ridiscesa al nulla segnata dall'interregno tra i due conflitti mondiali fu il sofferto disarticolarsi dell'Europa dopo “l'ultima guerra d'amore” (Scott-Fitzgerald, 1934); era lecito attendersi che tutto ciò sarebbe continuato. Se non fosse stato per i fascismi.
Nel 1924 Ortega y Gasset affermava che “la reazione non è altro che un parassita della rivoluzione”, non credo però fosse chiaro quali dimensioni questo parassita avrebbe assunto. Il suo fulmineo sviluppo – il germogliare in Italia, il crescere in Germania, il diffondersi in Francia, Spagna, Belgio, Balcani - fu un radicale cambio di scena. Se nel 1924 poteva apparire preponderante “lo spirito incapace di mantenersi in piedi da sé” che “cerca una tavola con la quale salvarsi dal naufragio e scruta intorno, con umile sguardo di cane, in cerca di qualcuno che gli dia asilo”, agli albori della seconda guerra mondiale (e civile) questo asilo era stato trovato dai più nel fascismo.
D’altro canto, si era arrivati ad esso con tale violenza, con tale rigetto di tutto ciò che vogliono dire le parole liberalismo, democrazia, Europa, che l’enormità dell’episodio permise di definire con maggiore chiarezza tutto ciò che gli era opposto. Diede un corpo a quel “donchisciottismo disperatamente serio e antiromantico” di cui Gobetti già scriveva nel 1922. La dimensione della reazione fascista, in Europa, fu tale da rendere evidente come in quell'esatto momento si fosse superata un'ulteriore fase: se l'antico ordine era stato sconfitto, allora - davanti all'estrema minaccia - il “nuovo ordine”, la democrazia dei moderni, diveniva a sua volta antico ordine.
Si chiarì, e definitivamente, un equivoco. L’iniziale vittoria dei fascismi in Europa fu in larga parte responsabilità delle forze politiche che all’epoca si dicevano “conservatrici”, poiché esse si ergevano in larga maggioranza a conservazione di scampoli e brandelli del mondo pre-rivoluzione. Erano in buona parte reazionari senza coraggio, conservatori di nulla. Niente ci può dare maggiore evidenza di quanto difficile sia la nozione di “conservatorismo” che abbiamo. Tradita dalle forze conservatrici, l’Europa scoprì il rischio costituito da una retroguardia infedele, scoprì la necessità di forze pronte a conservare i suoi tratti vivi e non i resti di forme morte e passate. Perché ciò potesse avvenire, era però fondamentale che cadesse questo velo, che una violenta scossa dimostrasse come la democrazia dei moderni sul Continente non era più solo qualcosa da affermare, ma ormai in larga parte anche qualcosa da difendere.
Questa scossa la diedero le forze scopertamente reazionarie, che emersero e - di nuovo alla piena luce - si riscoprono forti, patetiche e brutte. Venuti allo scoperto, i fascismi si guardarono allo specchio e dimostrarono a tutti come i secoli non avessero lasciato nulla sul loro volto dei tratti del marchese de La Rochejaquelein. Questo perché quanto di buono ci poteva essere nei vandeani veniva dal difendere qualcosa di venerando, di misurato e durevole, contro un furore nuovo. Era il triste amore di una passata conservazione sconfitta, “il fermo e lento passo dello spirito” (Dávila, 1977) davanti alla salma recente e ancora integra del vecchio antico regime.
“Il passato che il reazionario loda non è epoca storica ma norma concreta. Quel che il reazionario ammira di altri secoli non è la loro realtà, sempre miserabile, ma la norma peculiare alla quale disobbedivano.” (Dávila, 1977) Ebbene, quei reazionari palesavano come avessero perso quella norma, come i secoli l'avessero riempita di nulla e sfibrata e da essa non partisse più alcuna via praticabile.
Innalzando le imitazioni rozze di passati eroici da allucinazione, fascisti e nazisti si rivelarono in quanto adoratori di cadaveri putrefatti, che non potevano ormai che ispirare un agire perverso. Palesavano come l'unica cosa che ormai meritasse d'essere politicamente conservata era quell'ordine che volevano abbattere. I fascismi erano stati molto spesso favoriti con scopi di difesa di un ordine in pericolo ed essi stessi vivevano come questione centrale la difesa di una “civiltà europea” posticcia, si vide invece come non ci fosse civiltà europea da difendere senza liberalismo, individualismo e democrazia, come questa triade avesse assunto una sfumatura atavica, l’atavismo della modernità su cui costruire un nuovo motivo conservatore.
Quando i soldati del generale Millán-Astray gridarono: “viva la morte!” in faccia al professor Unamuno, che reagì in nome della vita; quando il tribunale di Savona condannò Parri, che ne contestò l'autorità; quando la brigata di Giustizia e Libertà andò a combattere in Spagna... e così potrei continuare a lungo. Quando quella iniziale minoranza che decise di essere Europa contro l’anti-Europa si sollevò, allora si scongiurò il pericolo che ciò che fu rivoluzione decadesse, che l’Europa venisse pervasa da un unico “spirito servile” (Ortega y Gasset, 1924).
Si verificò quanto riassunto nella “Montagna incantata” di Mann (1924): “l'acuto piccolo Naphta” il distillato del nemico di una certa civiltà che possiamo chiamare Occidente, “era quasi un dissoluto da tanto che faceva il libero pensatore, mentre quello, se vogliamo, era un San Luigi”. Dove “quello”, era Settembrini, il letterato, l'umanista borghese.
Il fascismo costrinse il continente a fare i conti con questa inversione di ruoli, e costrinse il liberalismo - il nostro liberalismo - a fare i conti con se stesso. Mentre il pensiero dei grandi movimenti popolari elaborava la democrazia borghese come uno snodo, un passaggio verso qualcosa, il liberalismo era l'unica forza sul Continente a percepirla come un punto di arrivo e quindi a percepirne non solo i lineamenti rozzi e superficiali, ma anche la particolare disposizione estetica, sentimentale, l'integrale disposizione di vita che gli si collega. L'unica forza sul Continente a poter parlare “in vece di tutto ciò che ha radici” (J.R.R Tolkien, 1977), a essere coscienza critica dell’intero sistema negato dai fascismi, non in vista di astri non ancora sorti, ma degli stessi valori fondativi cui esso trasgrediva.
Il liberalismo ritrovò per le sue mani lo scomodo arsenale della consuetudine, della norma tradita, della difesa di una giustizia ferma contro un turbinoso nulla, arsenale che sempre si era creduto appartenere ad altri, rivelatisi troppo radicalmente altri rispetto a tutta una cultura per potersene chiamare a difensori. In particolare, la sinistra liberale divenne il fulcro di tutto questo, in quanto con maggiore compattezza e impegno, anche militare, si era opposta.
Quei liberali si erano spesso dovuti riconoscere come sinistra liberale, o componente “progressista” del movimento liberale perché davanti al fascismo risaltava netto il legame con le componenti migliori di tutti i movimenti democratici nel solco della modernità, ma allo stesso tempo erano gli unici ad aver svolto con piena coerenza lo sforzo di conservare.
Tutto ciò ha posto questo liberalismo nella pericolosa e bella condizione di essere sulla faglia di tensione tra due verità: una etica, rivoluzionaria e progressiva, rivendicatrice del movimento inclusivo della modernità, della destabilizzazione scientifica del senso comune, della corrosione tramite la ragione dei rapporti di potere; l’altra estetica, conservatrice e a suo modo ieratica, la memoria sottopelle del più diretto legame col momento poetico di tutta un'epoca, la sensazione di essere tra i pochi convinti difensori del senso profondo di un’era, pronti a ricordarlo ad alta voce perché “le civiltà muoiono per l'indifferenza verso i valori peculiari che le fondano” (Dávila, 1977).
Non a caso in Italia, luogo emblematico di queste problematiche, la sinistra liberale della resistenza non è riuscita a farsi partito, ma è riuscita a produrre una classe dirigente. Non a caso una delle migliori sintesi in un uomo di tutto ciò, John Maynard Keynes, fu frutto peculiare dell'Inghilterra e del suo sistema educativo, ambiente che stemperava costituzionalmente la tensione distruttiva tra queste due verità, velandone la componente rivoluzionaria (e così stemperandone la potenza tragica), ma concentrandone attentamente il resto: pungolo dissacrante della ragione e della scienza, venerazione per l'arte e per il contenuto di bellezza inerente alla società occidentale, rivendicazione della vicinanza costitutiva tra liberalismo e parte delle istanze popolari e democratiche, volontà di difendere tutto ciò dai vari “partiti della catastrofe” vincolando il più possibile il potere alla conoscenza, nella convinzione che “the enchanted garden would become a wilderness unless it was defended from the outside”.
Così adesso, nel mondo che vede il sorgere della Cina dell’autoritarismo coniugato con la beffarda parola d’ordine dell’armonia e l’indebolirsi delle tutele democratiche dovuto a una globalizzazione non pericolosa di per se, ma resa pericolosa da classi politiche miopi che – soprattutto in Europa – si rifiutano di globalizzare la democrazia e lo stato di diritto, non credo sia inutile pensare a questa maniera di interpretare il termine “conservazione”. Né credo sia inutile ricordare come questo tipo di conservazione - la tutela dei valori fondamentali dell’individualismo, della libera ricerca, della libera critica, del diritto di partecipazione alla decisione del proprio futuro – sia uno dei motivi per cui la sinistra liberale è quale la conosciamo oggi. La posizione politica problematica per eccellenza, soprattutto sul Continente dove la rivoluzione e la reazione sono state vissute nel pieno della loro violenza. Ma anche quella determinata forza politica che porta in sé il nocciolo vitale della società in cui vive, che ha la maggiore responsabilità di renderla conforme alla sua norma. Progressista nell’avere ancora il coraggio di comprendere il significato rivoluzionario di questa norma, conservatrice per averne visto l’essenza solidificata dallo scontro, per averne abbracciato – con la resistenza e con la promessa di una continua resistenza - il senso di fronte alla morte.
Testi citati
- J. Ortega y Gasset, “Il tramonto delle rivoluzioni”, Scritti Politici p. 610-636 UTET 1979
- F. Scott-Fitzgerald, “Tenera è la notte”, Einaudi 2005
- N. Gómez Dávila, “In margine a un testo implicito”, Adelphi 2001
- T. Mann, “La montagna incantata”, Corbaccio 2009
- J. R. R. Tolkien, “Il Silmarillion”, Bompiani 2000
- J. M. Keynes, “My early beliefs”, 1938. Riportato da R. Skidelsky, “John Maynard Keynes 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesman”, Penguin 2005.
{ Pubblicato il: 20.01.2013 }
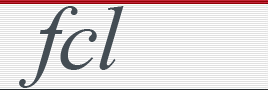




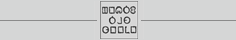




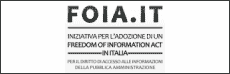






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.