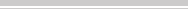giovanni vetritto
Nessun commento[12] Quando si deve assumere una decisione rilevante come è stata quella sulla scelta del dodicesimo Presidente del Repubblica, occorre valutare le qualità politiche e personali di ogni candidato, ma allo stesso tempo le prospettive politiche e le implicazioni istituzionali che ogni alternativa comporterebbe.
Per questa ragione, in un normale dibattito pubblico, per quanto incalzante e concitato come diventa inevitabilmente quello di una elezione presidenziale non plebiscitaria, non ci dovrebbe essere nulla di male nel non convergere su una candidatura, per quanto sensata e prestigiosa. Chi, però, nell'attenzione spasmodica dei cittadini e dei media, legittimamente ritiene di non raccogliere la pressante e crescete pressione per una simile convergenza avrebbe l'onere di motivare le sue ragioni di dissenso tanto, appunto, sul piano personale che politico-istituzionale.
Ciò che, viceversa, inquieta dell'ostinata resistenza della sinistra partitica e ancor più dei media istituzionali (giornali e televisioni) contro la candidatura di Stefano Rodotà al Quirinale delle scorse ore è l'essere stata una resistenza muta, immotivata, non spiegata, quasi apodittica.
Per giorni da ambienti culturali, politici e intellettuali, da opinionisti e cittadini veniva crescendo la richiesta al PD di valutare l'opportunità di convergere sulla candidatura di Rodotà; una candidatura che su queste colonne è stata subito prospettata, alla luce dell'esito delle elezioni politiche di febbraio, come la più naturale per lo stesso PD; e sulla quale, anzi, l'unico vero mistero è la ragione per cui non sia stato proprio il PD ad avanzarla, regalandola di fatto al 5 Stelle. La risposta è stato un ostinato, ermetico silenzio. Un rifiuto che Fabrizio Barca ha correttamente definito “inspiegabile”, e che resta non spiegato.
Intanto, nel contorno deprimente del bestiario televisivo il medesimo rifiuto di ogni ragionamento, la medesima congiura del silenzio venivano osservati dal solito coro di commentatori terzisti, giornalisti berlusconiani di complemento, perbenisti un tanto all'etto, corifei di regime. Mentre i più lucidi esponenti del PD (il “giovane” Pippo Civati come il “vecchio” Walter Tocci) dichiaravano pubblicamente il loro dissenso da una simile sordità, e mentre perfino un ex Margherita centrista come Cacciari invocava la chiamata della Croce Verde per i dirigenti diessini indisponibili a ragionare su un voto a Rodotà, i vari Vespa, Mannoni e perfino il presunto “indipendente” Mentana di fronte alla banale domanda “perchè no?” non argomentavano, ma ricercavano spasmodicamente alternative cervellotiche senza rispondere.
Man mano che la candidatura cresceva soprattutto nella società, il gioco si faceva via via più scopertamente scorretto, con politici e presunti intellettuali a fare a gara per schiacciare Rodotà su una implausibile immagine di estremismo grillino; perfino su una falsa biografia da comunista impenitente, avversario “socialdemocratico “ del “riformismo” immaginario dei Renzi e dei Fioroni. Ma tutto rigorosamente senza ragionare, senza argomentare, senza motivare il rifiuto.
L'unica spiegazione di un simile atteggiamento intellettuale era evidentemente la paura. La paura, via via divenuta sacro terrore, che alla più alta carica dello Stato ascendesse un garante delle regole, un arbitro imparziale, per giunta convinto custode dei valori a presidio dei quali le regole sono poste. Primo tra tutti, evidentemente, la laicità, bestia nera di certi poteri nazionali che in televisione in certi casi preferiscono non comparire direttamente ma certamente sanno pesare.
Tutto poteva sopportare la solita compagnia di giro dello sfascio, di destra e di sinistra, tranne che una simile prospettiva. Ogni azzardo appariva possibile, anche il ritorno alla peggiore nomenclatura della Prima Repubblica, tranne che l'avventurarsi nella terra incognita dello Stato di diritto e della democrazia liberale.
L'esito è stato quello più naturale, l'incistarsi pervicace della crisi con gli stessi uomini e le stesse logiche, il rifiuto di rispondere alla sfida demagogicamente nuovista di Grillo puntando sulla vera innovazione, il ritrarsi inorriditi di fronte alla prospettiva di abbracciare una moderna dialettica democratica rinnovando le istituzioni, piuttosto che perpetuare le solite logiche di casta imbellettandole con due o tre inutili misure demagogiche (la riduzione del numero dei parlamentari o l'abolizione delle province, mentre migliaia di tirapiedi politici vivono alle spalle dei contribuenti in centinaia di inutili società per azioni a capitale pubblico statali e comunali).
Si è scorrettamente costretto un vecchio comunista a fare l'unica cosa che aveva chiesto di non fare, ovvero restare al Quirinale a garantire la casta ormai impotente dei partiti del marcio sistema attuale, all'insegna della solita sbracata realpolitik e di una malintesa ragion di Stato; e ciò perché quei partiti, quel PD, qui commentatori, quei giornalisti, non volevano un arbitro ma, proprio tecnicamente, un tutore, un signore che scegliesse per loro nella loro ormai acclarata incapacità di intendere e di volere. Non un uomo che incarnasse al meglio il ruolo di terzietà e sintesi disegnato per il Presidente dalla Carta del 1948, ma un demiurgo che traesse gli imbelli leader partitici dall'impasse nella quale si erano cacciati.
E infatti subito è circolata la voce che quel vecchio comunista abbia posto, per accettare la soluzione plebiscitaria che gli veniva prospettata, condizioni che non rientrerebbero nei suoi poteri costituzionali, spingendo oltre ogni accettabile limite la transizione verso un presidenzialismo di fatto che violenta la costituzione vigente; con ciò dimostrando per l'ennesima volta la sua totale estraneità alla cultura del costituzionalismo e della democrazia liberali, per quanto auspicabilmente ormai lontano dalle giovanili infatuazioni per la violenza di Stato (fortunatamente scongiurata, nella notte, nonostante la Celere in assetto antisommossa subito schierata in Piazza Montecitorio).
In un crescendo surreale sui media si celebrava la vittoria della “moderazione” contro un imprecisato “estremismo”, per la conferma al Quirinale di un signore che sosteneva i carri armati sovietici più o meno negli stessi anni nei quali il suo competitor scriveva sulle colonne della più bella rivista della storia del riformismo liberale e borghese, “Il Mondo” di Mario Pannunzio.
Si celebrava lo scampato pericolo, la fine della paura montata nelle ore precedenti, di doversi confrontare con le regole e i valori di una democrazia liberale. E ciò a costo di rinviare ogni rinnovamento, di perseverare negli ircocervi governativi già falliti nell'ultimo anno e mezzo, di certificare il processo che porterà inevitabilmente in pochi mesi (se non in poche settimane) Berlusconi a impadronirsi, dopo inevitabili rapide nuove elezioni, di Palazzo Chigi, delle Camere, poi fatalmente dello stesso Quirinale, dove il novantenne comunista non potrà restare tanto a lungo per ragioni biologiche.
Il tutto mentre il presunto “estremista” Rodotà dava al suo casuale mentore Grillo una durissima e moderatissima lezione di democrazia e di liberalismo, ricordandogli la sovranità del parlamento, la differenza abissale tra un marchiano errore politico-istituzionale e un golpe, la necessità del rifiuto di qualunque marcia su Roma, foss'anche a fin di bene.
Da oggi quel comunista ridiventa il Presidente di tutti, di coloro che in quelle ore concitate hanno avuto paura di Rodotà come di coloro che invece lo hanno sostenuto, e che oggi non possono non ringraziare soprattutto lui per avere incarnato una battaglia liberale e democratica nel deserto del dibattito politico e istituzionale.
{ Pubblicato il: 20.04.2013 }
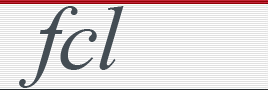




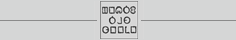




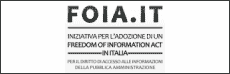






 «Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.